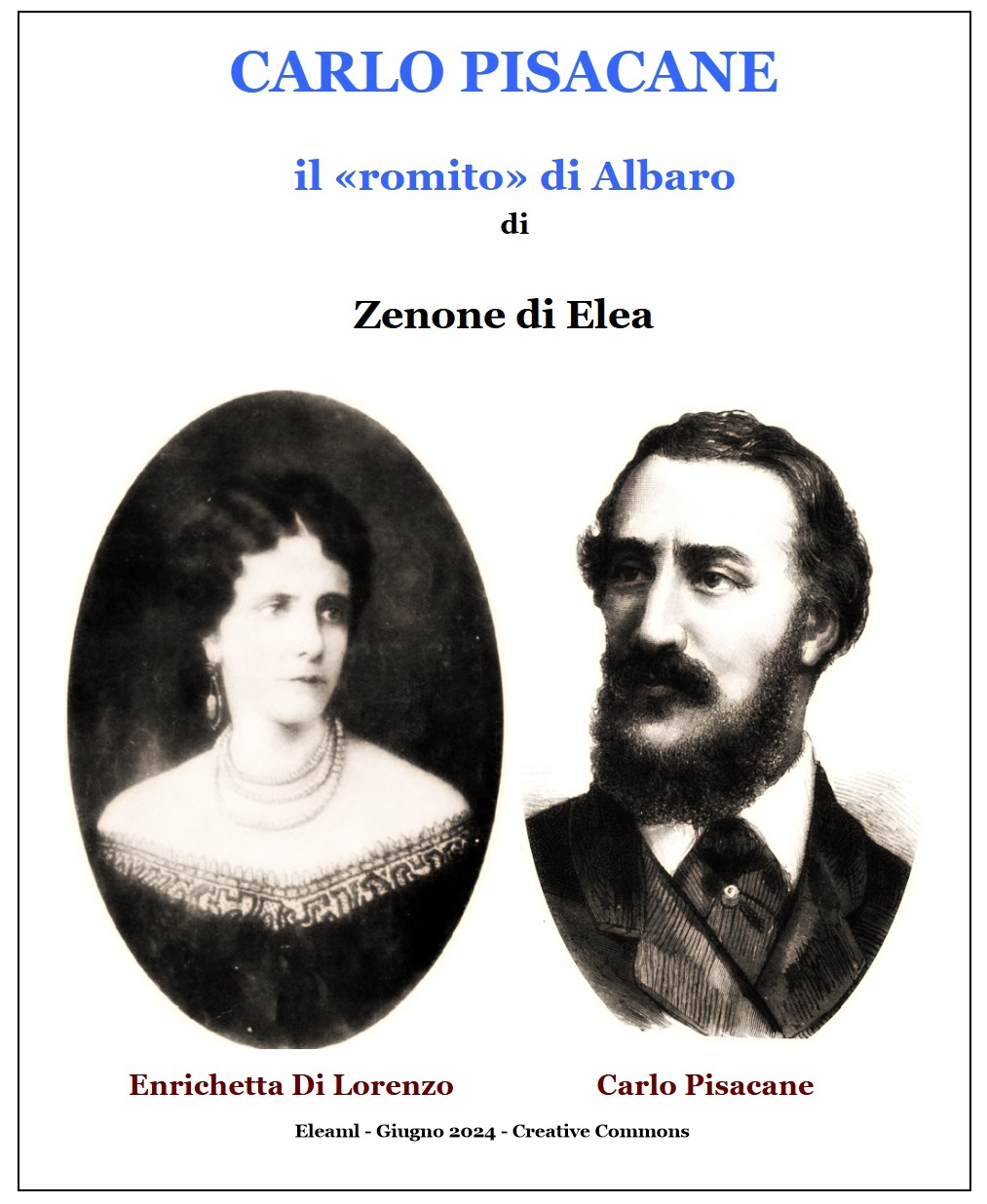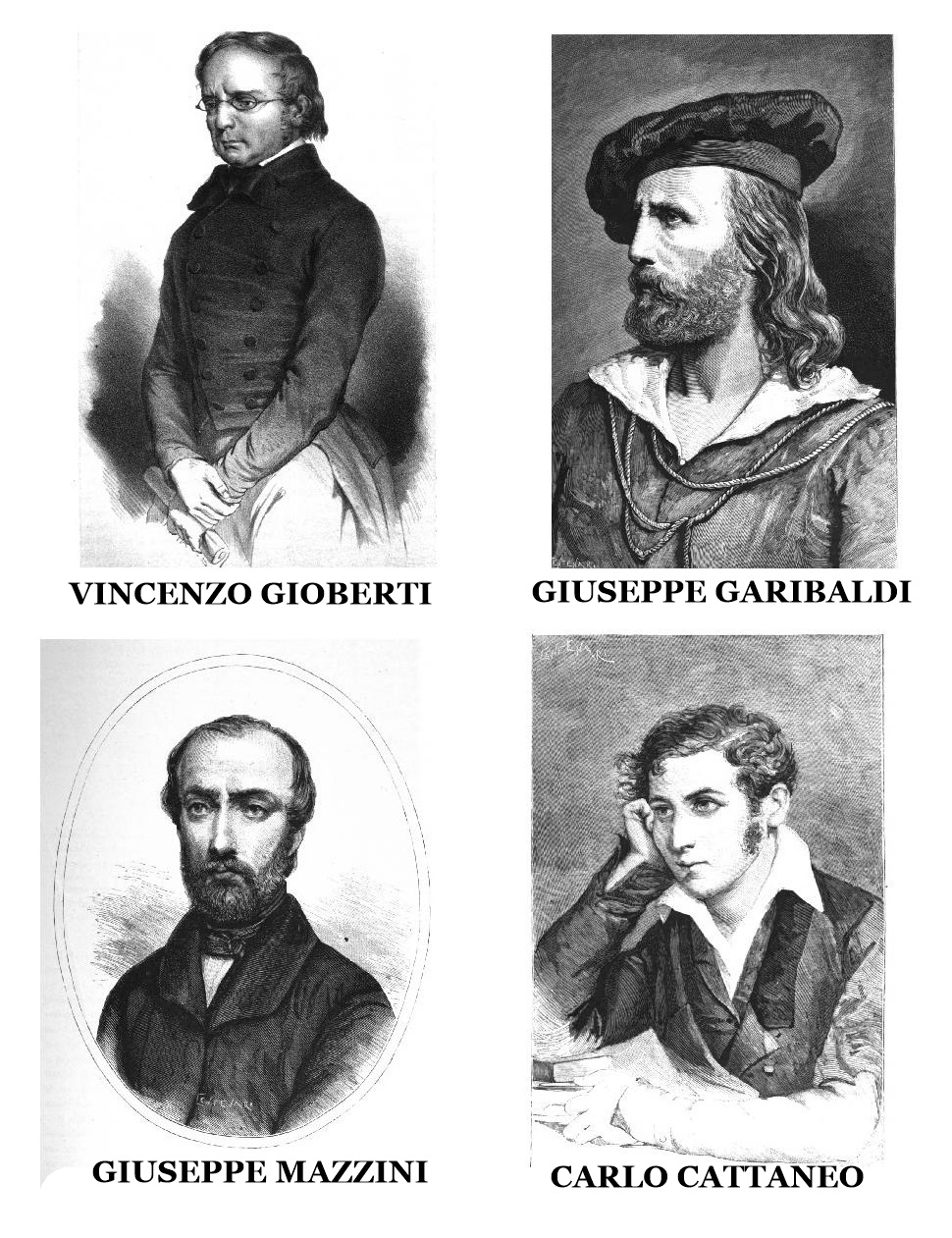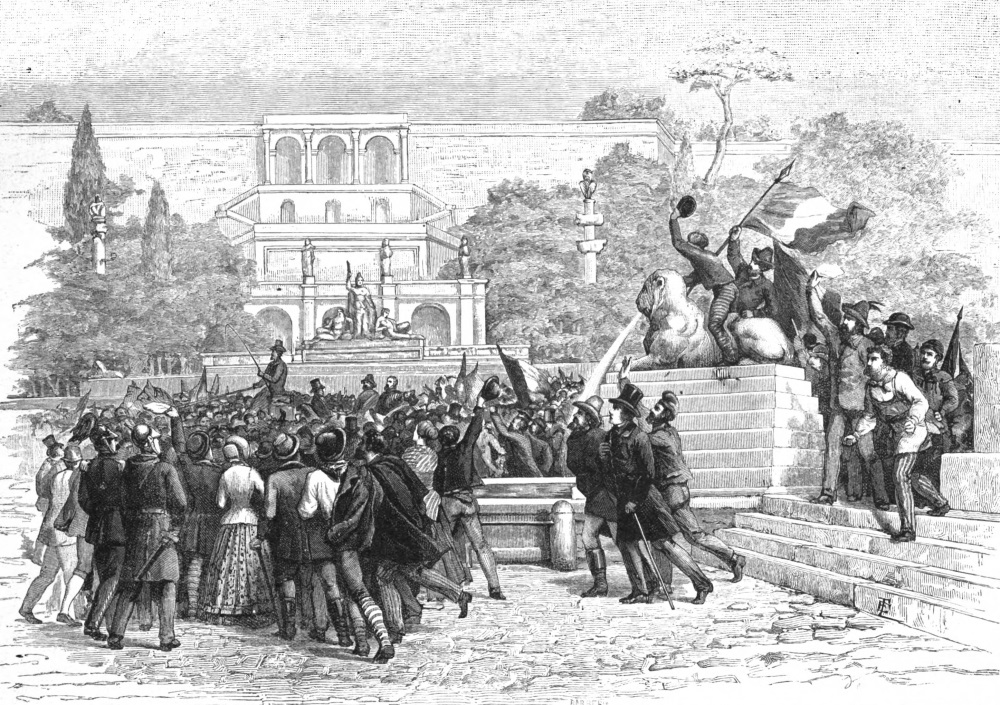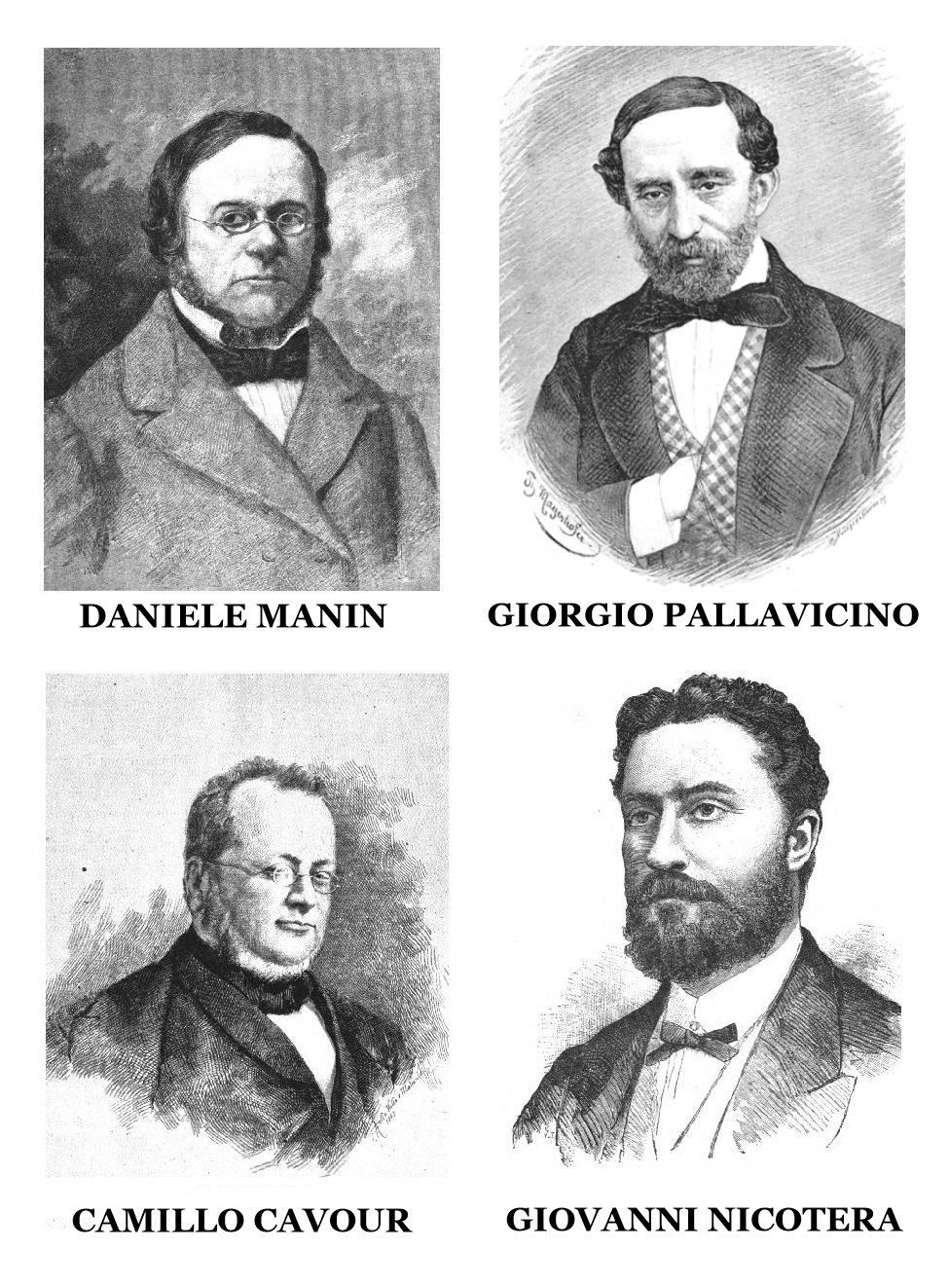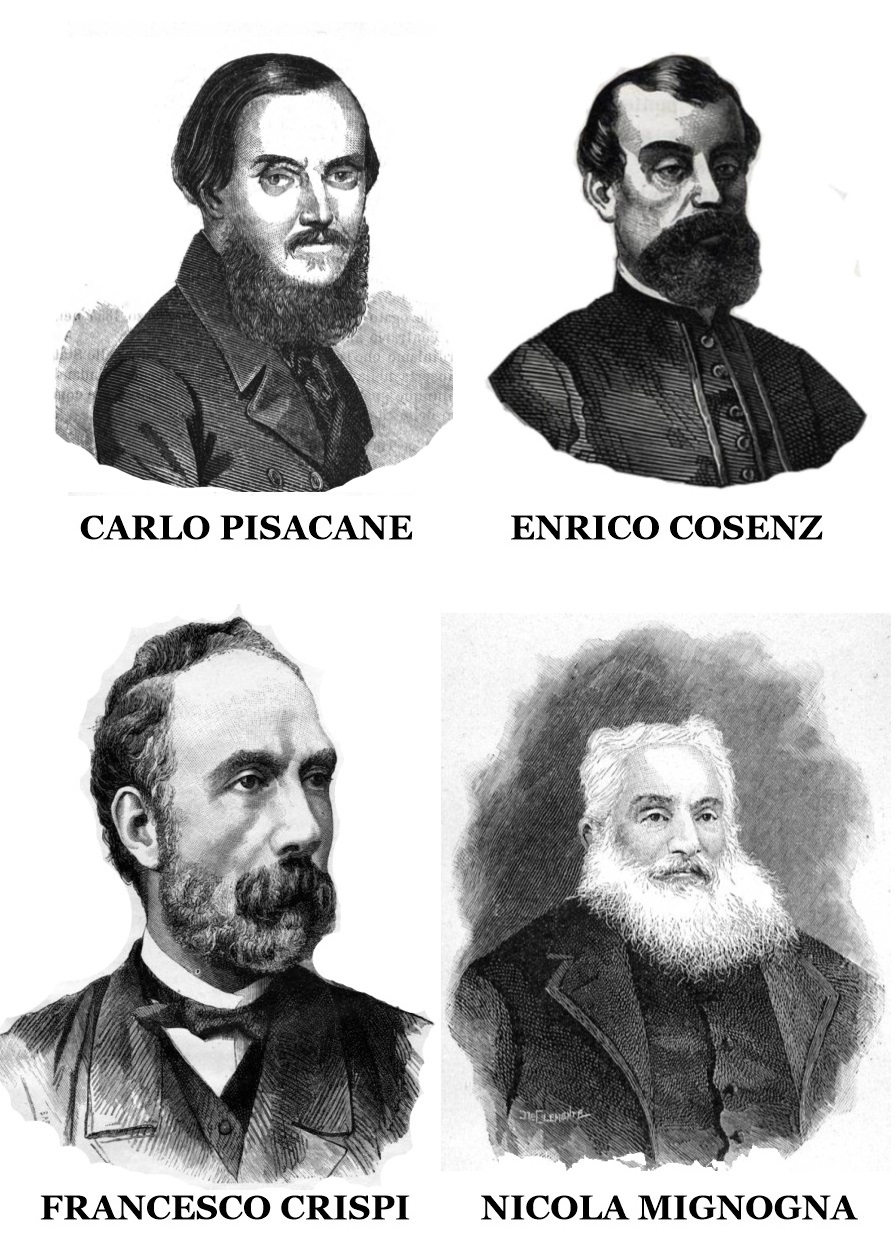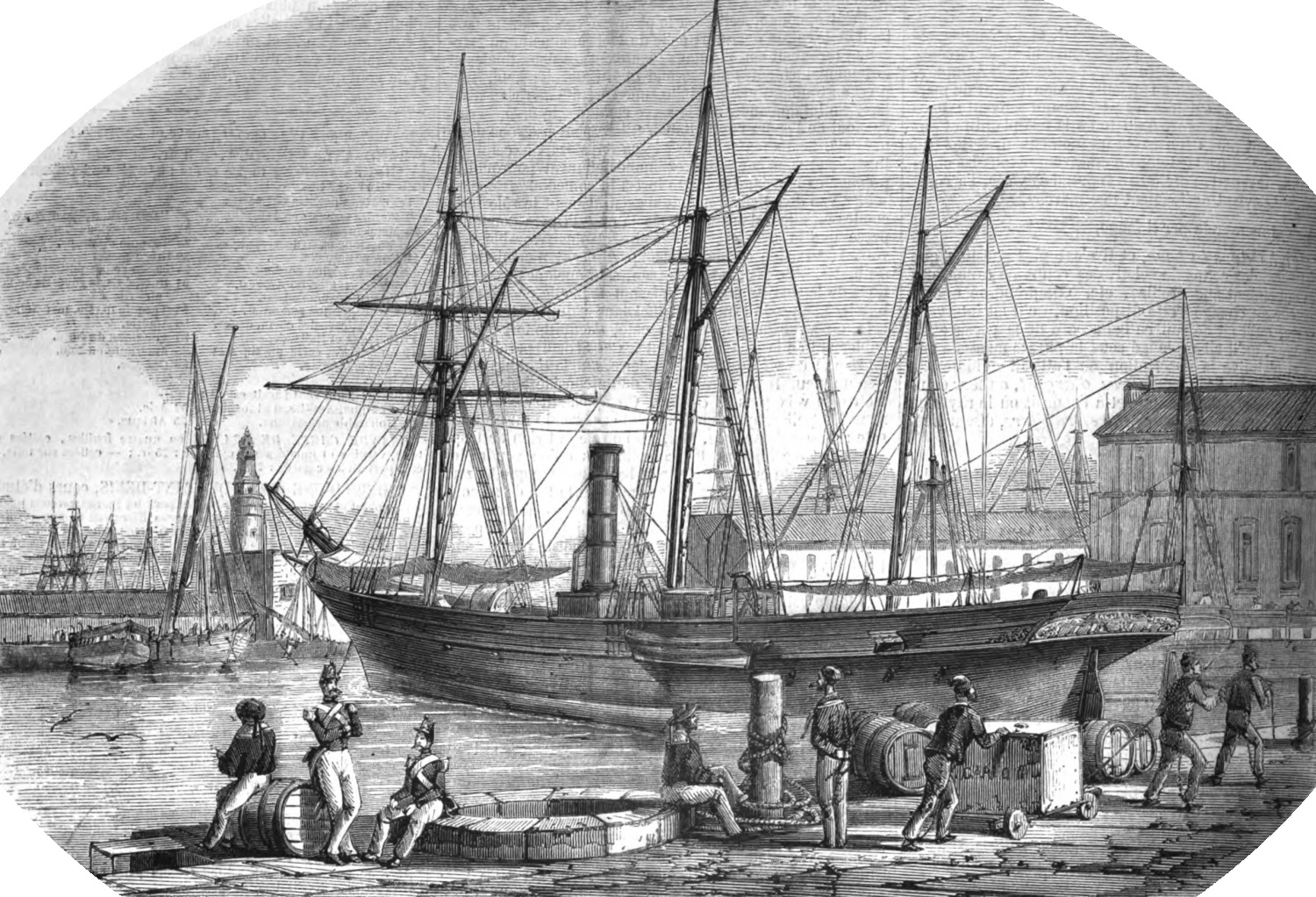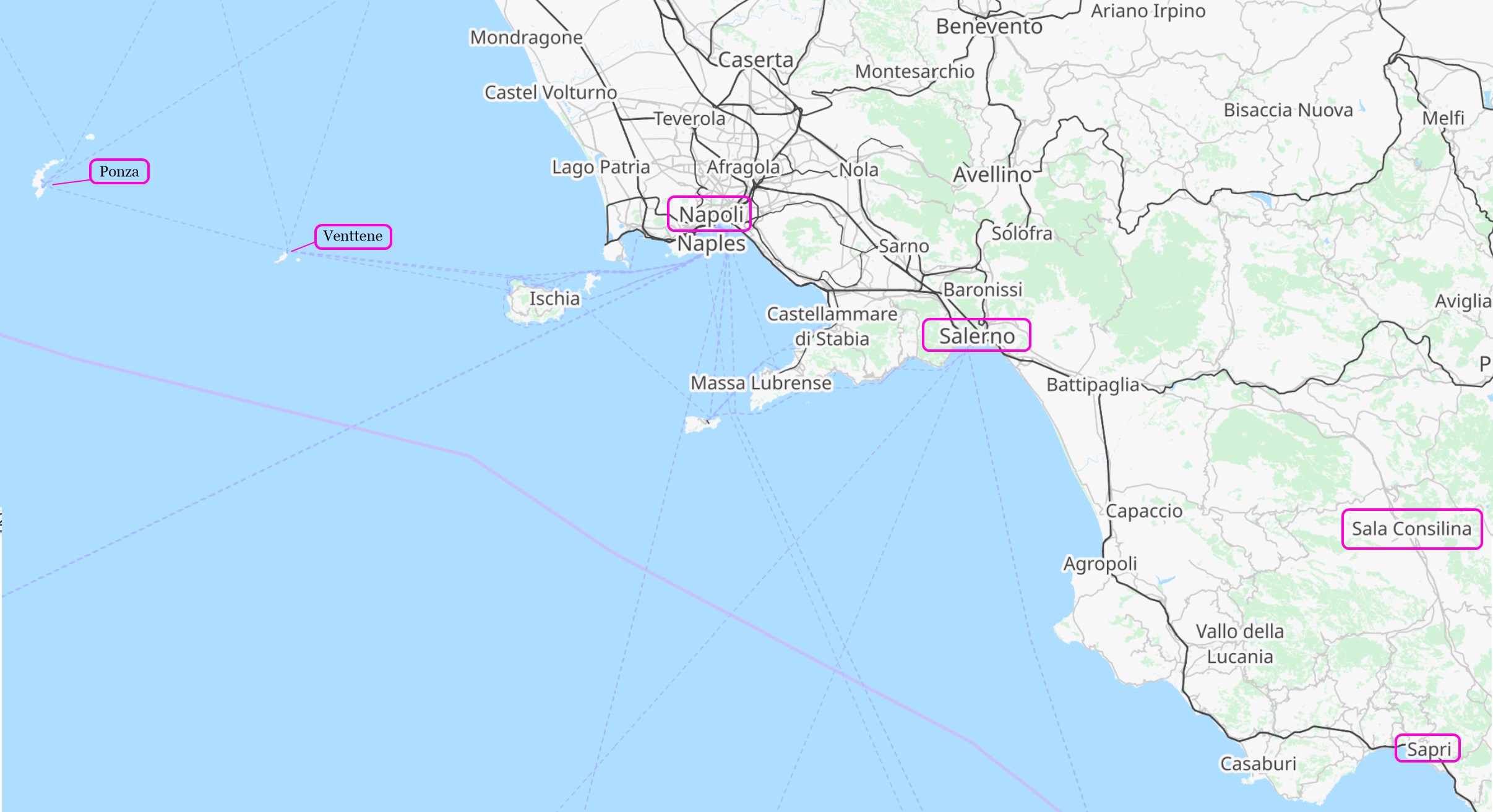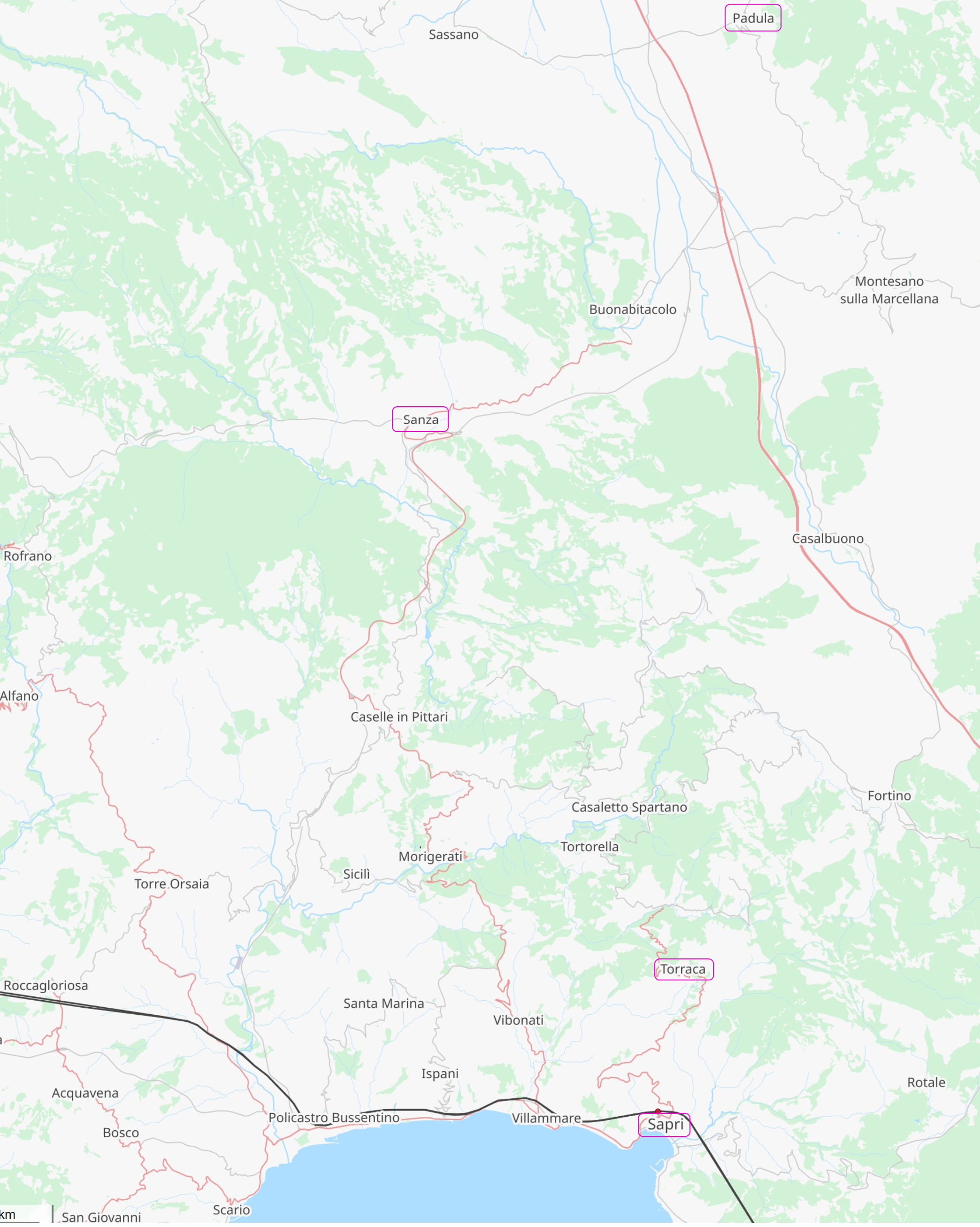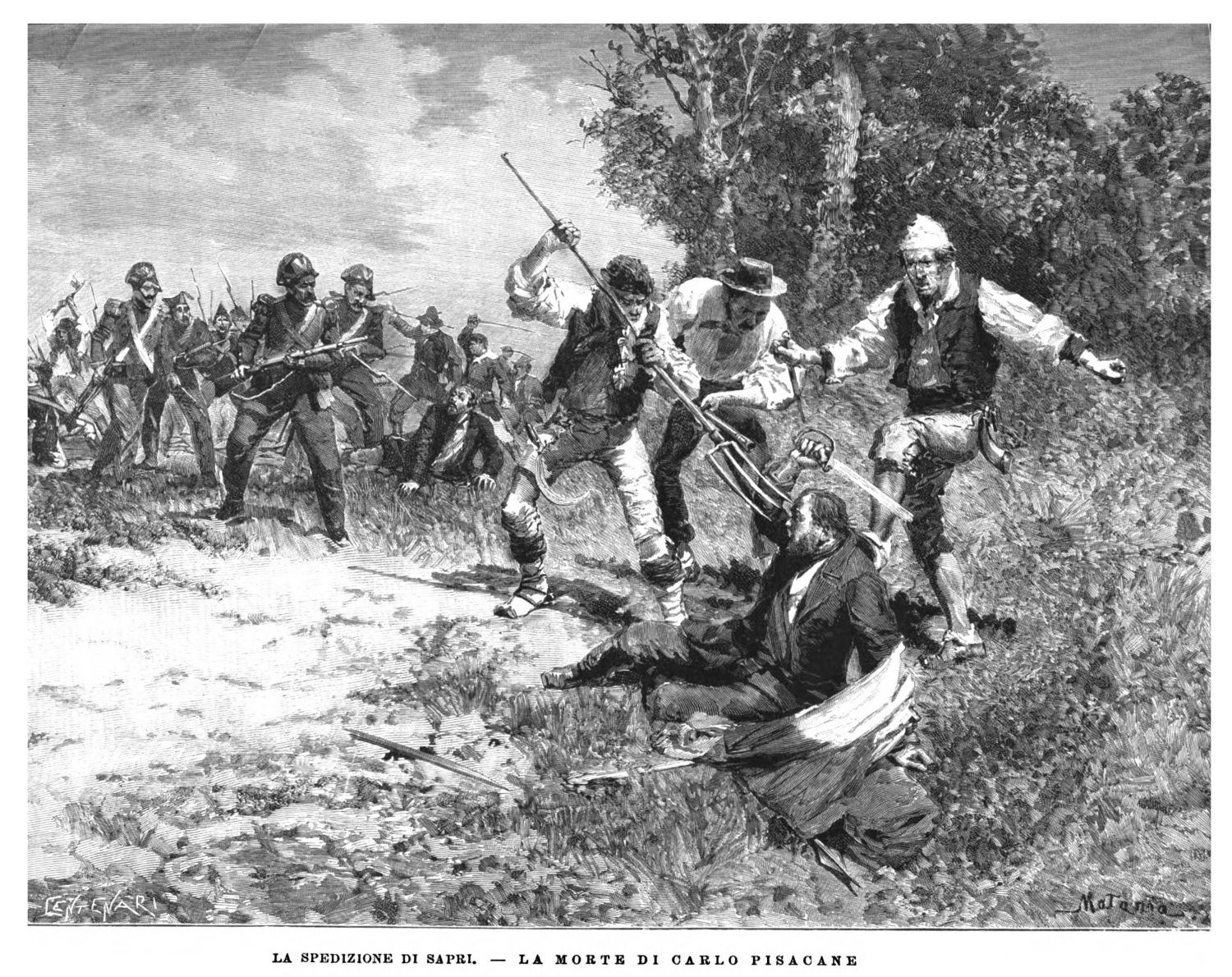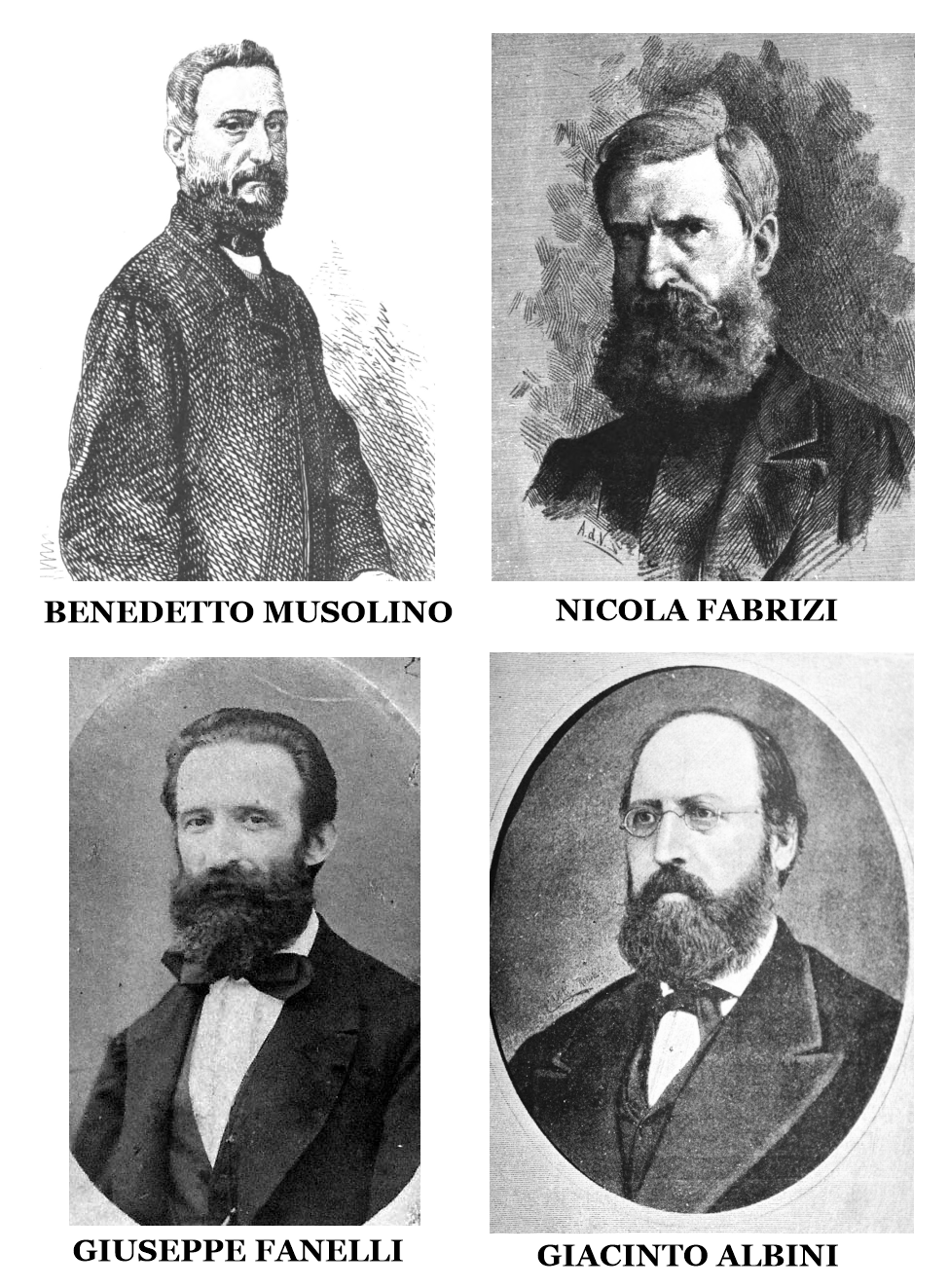|
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License |
1831 – 1847 1847 1848 1849
1850 – 1857
1857 IL PREZZO ANTICIPATO DELLA REDENZIONE |
Pisacane fu tradito, e Garibaldi no. Pisacane non ebbe aiuto dal Piemonte, come ebbe Garibaldi. Per Pisacane non vi fu corruzione dei regi, non comitati intestini, non danaro sonante, come vi fu per Garibaldi; e quindi... Lope de Vega – DIALOGO III | |
Se il 104 è il vapore ed è chiaro dal senso della frase il 166 che non è stato decifrato anche se era abbastanza facile è Rubattino… CRISTINA CONTILLI - Appunti sul codice cifrato delle lettere di Carlo Pisacane | |
Non nego di essere stato colpito, in anni giovanili, dalla figura di Pisacane, eroe romantico per definizione. Frequentai le elementari nei primi anni ‘60 e per qualche anno la mia famiglia ebbe in affito alcune stanze di un cadente palazzo ducale in cui erano disseminate, in vecchie stanze non abitabili in quanto pericolanti, alcune copie del volumetto a firma di Giuseppe Talamo, testo commissionatogli in occasione del 1° centenario dell’unità d’Italia che cadde il 17 marzo 1961 (1) . Ai versi sulla Spigolatrice di Sapri (2) che mi avevano inculcato il mito dei trecento giovani e forti seguirono letture adolescenziali di autori russi come Bakunin e Lenin che ben si legavano al Testamento politico del “biondo eroe” napoletano. Nemmeno le tante frequentazioni identitarie riuscirono a demolire quella giovanile fascinazione. Anzi, mi parevano esagerate finanche quelle ricostruzioni, ben argomentate di Alessandro Romano e di Edoardo Vitale, del personaggio risorgimentale. Per anni mi son ripromesso di indagare personalmente sulla Spedizione di Sapri ma non l’ho mai fatto, almeno non fino al 2023. | 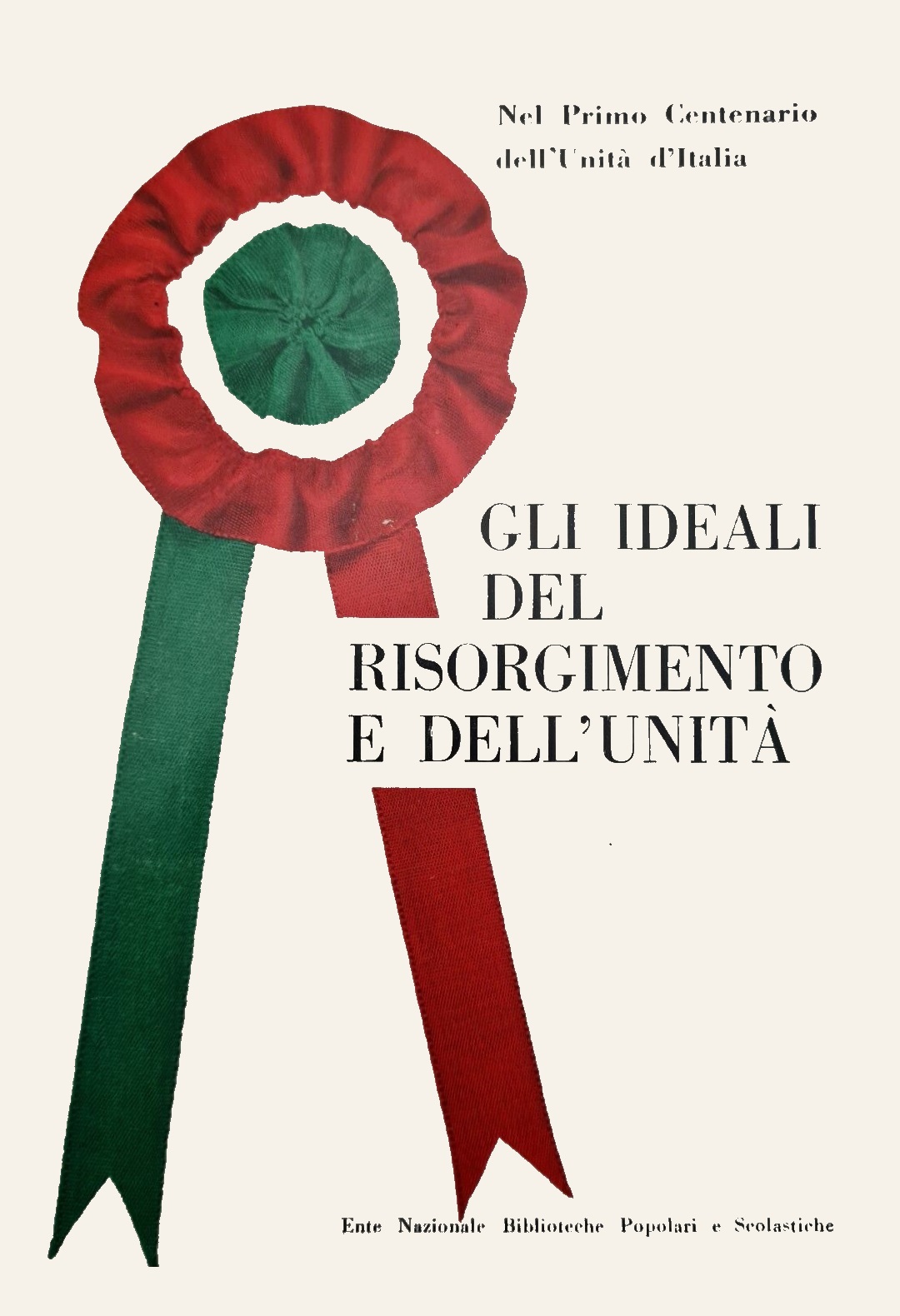
|
***
Bisogna ammettere che fatta salva la dimensione umana del personaggio, la cui vita è costellata da un vortice di passioni sentimentali che sicuramente influirono in certe sue scelte, da un punto di vista storico-politico la sua esistenza appare come un vero disastro:
– Lotta contro quelli che ritiene degli oppressori, ovvero i Borboni, ma se ne va in Algeria a combattere, a fianco dei Francesi, contro gli insorti capeggiati da Abd el Kader che si oppongono agli invasori stranieri;
– Durante la difesa Repubblica Romana viene nominato Capo di Stato Maggiore ed entra in urto con Garibaldi (3) che mal sopporta di adeguarsi alle sue logiche militari e, anni dopo, nel 1857, non accetterà di porsi alla testa (4) di una eventuale spedizione nel Regno delle Due Sicilie;
– Nei suoi scritti parla di emancipazione delle masse, di socialismo, di guerra di popolo, e finisce in una specie di trappola orchestrata dai moderati che gli promettono migliaia di uomini, di cui non se ne vede manco l’ombra (5) e prova a scatenare la ribellione servendosi di alcune centinaia di “relegati” (una decina di politici, gli altri tutti detenuti comuni) fatti evadere dalle carceri di Ponza (6) ;
– Un altro «tragico paradosso», secondo Paul Ginsborg, (7) «il fatto che tra il 1856 e il 1857 Pisacane scrivesse in modo così lucido e appassionato in favore dell’insurrezione urbana per poi morire solo pochi mesi più tardi facendo esattamente ciò che aveva invitato gli altri a non fare». Per onestà dobbiamo dire che questa discrepanza tra teoria e prassi, nel Pisacane, era già stata sottolineata venti anni prima da Vittorio Scotti Douglas (8) nel n. 20 di Spagna Contemporanea;
– Vestito da prete, va a Napoli qualche giorno prima della spedizione, per rendersi conto di persona della situazione e degli appoggi su cui potrebbe contare in loco, ma dagli incontri con gli esponenti del comitato napoletano non riesce a farsene una idea precisa (9) ; ciononostante decide di partire. I cosiddetti patrioti, Mazzini (10) , Fabrizj (11) , Fanelli, Albini (12) e tanti altri, negli anni successivi, cercheranno di scrollarsi di dosso qualsiasi responsabilità per il disastro di Sapri (13) .
1831 – 1847
DALLA NUNZIATELLA AL BLACKFRIARS BRIDGE
Sulla famiglia di origine di Carlo Pisacane, Lombroso e Besana scrivono (14) :
«Era egli nato in Napoli il 22 agosto 1818, e parve fino dalla sua nascita ch'ei fosse predestinato alla scuola del dolore, poiché perdette il padre appena tocchi i sei anni. La madre con sollecita cura gli procurò quella educazione che si conveniva a' suoi natali ed al suo ingegno. L'animo fervido del giovinetto inclinava specialmente alle cose di guerra, per cui venne, nel 1831, posto nel collegio della Nunziatella, ove si educavano al mestiere delle armi i giovani nobili di nascita ed i figli dei militari.»
Dopo gli anni di studio alla Nunziatella (15) , nel 1839, superò gli esami in modo brillante ma non essendo riuscito a militare nella cavalleria, si recò, in qualità di soldato gregario, in Nocera. Dopo sei mesi di tirocinio, venne ammesso al corpo reale del Genio napolitano col grado di sottotenente. Grazie al prestigio acquistato per le sue abilità di ingegnere, il capitano Fonseca lo ingaggiò come aiuto tecnico per costruire la ferrovia da Napoli a Caserta (1840). Svolse con diligenza il suo compito ma non sopportava i modi burberi del Fonseca. Chiese di essere assegnato ad altro incarico e venne mandato negli Abruzzi, ove restò per oltre quindici mesi.
Il 3 febbraio 1843, mentre era di stanza in Civitella del Tronto, fu aggredito da un bettoliere, il quarantenne Emidio Fiorentini, furioso perché lo sorprese in compagnia della sua giovane sposa Gaetana Michilli – “Nanella”, scrive Pisacane in una lettera al fratello Filippo (16) –, una popolana di straordinaria bellezza. La donna rimase gravemente ferita dalle coltellate, e morì tre anni dopo, nel 1846. Carlo invece riuscì a scappare e a salvarsi. Denunciato dal bettoliere, venne incriminato per adulterio e recluso nel carcere di Teramo per alcuni mesi.
Scontata la pena, tornò nella sua Napoli, col grado di primo tenente. Tra il 1844 e il 1845 si legò sentimentalmente a Enrichetta Di Lorenzo, un amore giovanile (17) che intanto si era maritata con Dioniso Lazzari, un attempato cugino del Pisacane.
Nella notte dal 12 al 13 ottobre 1846, Pisacane venne raccolto davanti casa sanguinante, ferito da varie pugnalate. (18) Taluni autori ipotizzano una vendetta del cugino, a cui stava insidiando la moglie Enrichetta (19) , ma egli dichiarò che si trattasse di un ladro di strada. Si riprese miracolosamente dalle gravi ferite – di tale ripresa l'egregio chirurgo Coluzzo non finì mai di stupirsi, dicendo che il Pisacane fosse di certo destinato a cose grandi per aver superato quel pericolo, a nessun altro uomo superabile. La convalescenza perdurò per qualche mese.
In una lettera datata “Napoli, 28 gennaio '47” Pisacane confessò ai familiari la sua “ardente passione” per Enrichetta (20) :
«Io amo Enrichetta dal giorno 8 settembre 1830; da quel giorno che la vidi per la prima volta il mio cuore, tenero allora, ricevé una impressione... quella prima fattami nella mia fanciullezza crebbe col cuore insieme, e fu un'impronta sull'acciaio, incancellabile. Enrichetta incominciò a supporre che io l'amassi nel 1841... Feci palese il mio amore nel giorno del suo nome, 15 luglio 1844, ma, credete, non con la speranza di essere amato, anzi con la certezza di non doverlo essere giammai; questa certezza e l'idea della sua infelicità amandomi, attesa la sua posizione, mi fece fare i più terribili sforzi per cancellare dal mio cuore quell'ardente passione: tentai le mille volte partire per l'estero... ma tutte le strade mi furono chiuse.
[…] Finalmente Enrichetta mi ha detto je t'aime il 1° giugno 1845. Da quest'epoca abbiamo sostenuto la lotta la più eroica che si possa immaginare...».
Ai primi di febbraio del 1847, Carlo Pisacane ed Enrichetta Di Lorenzo s'imbarcarono, sotto il nome di Francesco Guglielmi e Sara Sanges, (due domestici conniventi), sul postale francese Leonidas per Livorno, città in cui non arrivarono mai. I due fuggiaschi riuscirono a passare in Corsica sotto il falso nome di Enrico e Carlotta, coniugi Dumont, e di là a Marsiglia, avendo per meta Londra «città eccentrica, libera», (21) dove giunsero il 4 marzo 1847, prendendo alloggio in un albergo di Blackfriars Bridge, nei pressi di St Paul Cathedral.
1847
NELLA LEGIONE STRANIERA
Su pressione della diplomazia napolitana, il governo inglese li invitò a ripassare la Manica. Sempre con passaporti intestati ai Dumont, si trasferirono a Parigi. La polizia francese scoprì che viaggiavano con documenti falsi e li arrestò, incarcerandoli per alcuni giorni. Per guadagnarsi da vivere Pisacane decise di arruolarsi nella Legione Straniera (22) , con destinazione Orano, in Algeria.
Grazie ai buoni uffici del Duca di Montebello,
“in quel tempo ministro per gli affari della marina, il quale aveva conosciuta la famiglia Pisacane quand'era ambasciatore di Francia presso la Corte di Napoli, per le costui raccomandazioni veniva accettato come sottotenente nel primo reggimento della legione straniera, comandato dal colonnello Mellinet. Il Pisacane partiva per Marsiglia; e il 5 dicembre dello stesso anno 1847 faceva vela per l'Africa. Colà, nella rude guerra contro gli Arabi, non gli mancarono occasioni di guadagnarsi la stima e l'affetto dei commilitoni.” (23)
|
Costa Algerina |
Orano, Algeria |
Intanto Enrichetta a Parigi entrava in contatto con gli esuli italiani (tra cui il napoletano Guglielmo Pepe) e, nei salotti liberali, conosceva Henri Dumas, Victor Hugo, e George Sand.
***
Gli avvenimenti di Sicilia e Napoli dei primi mesi del 1848, la guerra dichiarata dal Piemonte all'Austria e la rivolta anti-austriaca scoppiata a Milano il 18 marzo, scossero l'animo di Carlo Pisacane (24) , il quale il 24 marzo 1848 presentò richiesta di congedo al suo comandante, rinunciando al grado, per accorrere in Italia a combattere.
Il colonnello Mellinet, “figlio e nipote di massoni” (25) , considerava la sua partenza una grave perdita per il reggimento e sottopose, a malincuore, la sua domanda al generale Cavaignac. In una lettera, datata 31 marzo 1848, Pisacane scriveva al fratello Filippo (26) :
“Io sono giunto in Marsiglia con un congedo il giorno 28 corrente, ho qui trovato la tua cara lettera, a cui di già la mia Enrichetta avea risposto ed io non ho nulla da aggiungere a quanto lei ti ha scritto.
[...] Ora che ho toccato la terra di Francia, non temo più che l’Italia mi scappi; ma ti assicuro che senza una somma bontà del mio Colonnello, io sarei stato costretto ad attendere lungamente in Africa; lontano dalla mia Enrichetta, e con l’Italia in fiamme sarebbe stata per me pena non lieve.”
1848
AGGREGATO A UNA COLONNA LOMBARDA
L'ufficiale napolitano disertore domandò un salvacondotto per Napoli al Console delle Due Sicilie, al quale chiedeva di voler partecipare alla guerra (27) , col grado suo, nell’esercito comandato da Pepe. Il funzionario girò la pratica al Ministero, ma Pisacane non ebbe pazienza di attendere una risposta, e partì per Milano, dove giunse il 14 aprile. Ivi fece capo a Cattaneo, dal quale venne apprezzato, essendo un militare di mestiere e con idee chiare in testa, a differenza di tanti “volontari spavaldi e ignoranti”((28) ).
Fu accompagnato da Cattaneo dall’anziano generale Lechi (29) e poi fu aggregato a una colonna lombarda comandata dal maggiore Borra. Il 28 aprile 1848 scrisse da Desenzano al fratello Filippo (30) :
“Noi formiamo l’estrema sinistra dell’Esercito, e spingiamo gli avamposti sulla strada di Peschiera. Questa colonna, nella quale io sono capitano, è lombarda, non può chiamarsi corpo organizzato, ma lo sarà appena dopo la guerra, o appena qualche reggimento lombardo già formato possa rilevarci. Allorché giunsi in Milano volevano farmi rimanere come organizzatore, ma siccome io risposi non essere venuto per passeggiare, mi spedirono in questa Colonna, che di tutte è la più esposta e la migliore.”
Nello Roselli, nella sua biografia di Pisacane (31) , riporta il giudizio poco entusiasta (32) sulla conduzione della guerra da parte del re sabaudo Carlo Alberto:
“Lettera al fratello Filippo: Pisacane in complesso è contento; la sua colonna, gli scrive, per quanto non sia per anco organizzata a dovere e gli uomini sappiano a mala pena maneggiare il fucile, può considerarsi tra le migliori. Certo, si vorrebbe fare molto di più, ma bisogna pur rassegnarsi agli ordini emanati dallo Stato Maggior generale e attendere, per cominciare la guerra anche lassù, «il signor Carlo Alberto». E poi, senza eufemismi: «Gli affari della guerra in generale vanno bene, perché non possono andar male; ma Carlo Alberto è una b… [bestia] senza pari; 90000 combattenti arrestati sul Mincio senza ragione. Se gli austriaci avranno forze noi saremo completamente girati dal Tirolo».
Scrive in una nota al suo saggio “Un «conflitto civile privato»”, Silvia Sonetti:
“C. Pisacane al fratello Filippo, 28 Aprile 1848, in Epistolario cit., p. 56. Al quindicesimo rigo della prima pagina si osserva, accanto al nome di «Carlo Alberto», una cancellatura diversa dalle solite di Carlo e quindi verosimilmente effettuata da altri. L’A.P.P. conserva la lettera manoscritta dalla quale si può desumere che la parola cancellata è «bestia», censurata nelle pubblicazioni successive.”
Le operazioni a cui partecipò l’ufficiale napoletano durante gli scontri contro gli austriaci (33) le troviamo raccontate sempre da Rosselli:
“Le colonne di volontari concentrate sulla sponda meridionale del Garda raggiungono una dopo l'altra le posizioni assegnate. Pisacane, che nella colonna Borra comanda adesso una compagnia cacciatori, parte il 28 per Tremosine. Una catena di monti separa quella zona dalla Val di Ledro austriaca; Pisacane, che non può per mancanza di forze occuparne le cime, ne guarda gli sbocchi, numerosi e quasi tutti ad alta quota. Non è la guerra combattuta, come aveva sognato; ma è vita dura lassù, freddo intenso, scarsi ricoveri, viottole impervie; e del nemico, appostato nell'altro versante, ben poche notizie, perciò timor di sorprese, frequenti ricognizioni sui monti soprastanti, apprestamenti difensivi nella vallata; gran difficoltà, poi, per organizzare i servizi. Pisacane è un capitano «pignolo», in moto tutto il giorno, esigente, coscienzioso, autoritario.
Certo che gli brucia sentir solo da lontano fragor di battaglie. Sei maggio, Santa Lucia, primo scacco un po' grave dei piemontesi; e il corpo di Nugent che da Gorizia, sui primi di maggio, s'è portato con rapidissima marcia a Belluno: Verona è a poche tappe! Pisacane si allarma. Le notizie, lassù, giungono con esasperante lentezza, ma si ha la vaga impressione che la guerra cominci a voltar male. Il 29 aprile è stata la doccia fredda dell'enciclica papale; ora, il 15 maggio, è la controrivoluzione a Napoli. Le truppe sarde principiano a scorarsi, i volontari, dimenticati sui monti, danno spettacolo d'indisciplina. Un episodio tipico? Il 28 d'aprile Pisacane, piuttosto scandalizzato, ha scritto al fratello che l'antico compagno d'armi De Turris, capitato in un reggimento scarso d'ufficiali, è stato in tre giorni promosso maggiore. Non passan due mesi che De Turris e con lui altri tre ufficiali danno alle stampe un comunicato recante le loro dimissioni «da quel reggimento... per il cattivo andamento e direzione di quel comandante, digiuno delle necessarie cognizioni di amministrazione interna e di strategia e tattica militare in campo».
Il 25 giugno Pisacane venne ferito al braccio destro, al passo di Bestana, nella zona della valle di Ledro, presso il lago di Garda. Trasportato a Salò, dove gli ospedali non offrivano manco dei pagliericci, volevano amputargli il braccio. Per sua fortuna sopraggiunse un chirurgo, certo Leone, che gli salvò il braccio e, probabilmente, la vita stessa.
Dopo la firma dell’armistizio Salasco del 9 agosto 1848 – tra Piemonte e Austria – diversi volontari raggiunsero la Svizzera (34) e successivamente il Regno di Sardegna, ove furono arruolati nell’esercito piemontese.
Pisacane, in una lunga missiva scritta da Desana in provincia di Vercelli, chiese al fratello Filippo di inviargli le lettere indirizzandole al Capitano nel 3° Battaglione 20° Reggimento (Brigata Lombarda)”. Nella lettera chiedeva anche al fratello di adoprarsi per tentare di definire giuridicamente la situazione di Enrichetta, di “consultare l’avvocato, se venendo in Napoli, Enrichetta potrebbe intentare un giudizio, domandare la separazione di Corpo, e di beni, adducendo per ragioni, l’incompatibilità di caratteri, e la cattiva salute di lui, l’una e l’altra di queste ragioni sono facili a provarsi”. (35)
1849
CAPO DI STATO MAGGIORE NELLA REPUBBLICA ROMANA
Nel febbraio del 1849 chiese il passaggio nello Stato Maggiore, scrivendo al generale Giacomo Durando, ricordandogli non vi fosse combattente in tutta l’armata che non avesse ricevuto un premio per le ferite riportate. Non ottenne nulla, Nel mese seguente si dimise dall’esercito del Re di Sardegna e l’8 marzo 1849 raggiunse Roma con Enrichetta.
A Roma incontrò Mazzini, il quale così lo ricorda (36) :
“Un giorno in Roma, nel 1849, mentr’io era ancora semplice rappresentante del popolo e senza parte nella suprema direzione delle cose, saliva a vedermi un giovine ufficiale napoletano. Era Carlo Pisacane. Mi si presentava senza commendatizie; m’era ignoto di nome, e bench’io ricordassi d’averlo alla sfuggita veduto un anno prima fra quel turbinio d’esuli che la dedizione regia rovesciava da Milano e da tutti i punti di Lombardia sul cantone Ticino; io non sapeva né gli studi teorici e pratici, né la ferita di palla austriaca che lo avea tenuto per trenta giorni inchiodato in un letto, né i principii politici serbati inconcussi attraverso l’esilio e la povertà, né altro di lui. Ma bastò un'ora di colloquio perché l’anime nostre s'affratellassero, e perch'io indovinassi in lui il tipo di ciò che dovrebbe essere il militare italiano, l’uomo nel quale la scienza raccolta con lunghi studii ed amore non aveva addormentato, creando il pedante, la potenza d’intuizione e il genio, si raro a trovarsi, dell’insurrezione. Da quel giorno in poi fummo amici e concordi nell’opere a pro del paese.
La fronte e gli occhi di Cario Pisacane parlavano a prima giunta per lui; la fronte rivelava l’ingegno; gli occhi scintillavano di energia, temperata di dolcezza e d’affetto. Traspariva dall’espressione del volto, dai moti rapidi, non risentiti, dal gesto né avventato né incerto, dall’insieme della persona, l'indole franca, leale, secura. Il sorriso frequente, singolarmente sereno, tradiva una onesta coscienza di sé e l’animo consapevole di una fede da non violarsi in vita né in morte.
Era la FEDE ITALIANA: la fede nella patria avvenire, nell'unità repubblicana d’Italia e nel popolo per fondarla.
[…] L’ultimo giorno da che ci abbracciammo, gli lampeggiava sul volto quel sorriso di fede ignara del tempo, che mi strinse a lui nel primo nostro colloquio in Roma.”
Pisacane propose a Mazzini un piano in cui si chiedeva all'assemblea la nomina d'una commissione che avesse lo scopo di organizzare l'esercito, eseguire un lavoro topografico, ottenere piani offensivi e difensivi del territorio della repubblica. La proposta di Pisacane – insieme a quella di Bertani sulla organizzazione sanitaria dell’esercito della Repubblica – viene riportata in un testo di Giuseppe Beghelli (37) , il quale si vanta di possederne l'originale (38) :
“Pisacane, allora ignorato, presentava a Mazzini il progetto che noi possediamo in originale e che pubblicheremo tra poco. Piacque a Mazzini il piano di Pisacane e tanto che in analogia ad esso proponeva all'assemblea la nomina d'una commissione che provvedesse alla difesa del paese e Pisacane ne fu l'anima. A noi non compete seguire Carlo Pisacane sino alla sua spedizione di Sapri del giugno 1857 – spedizione che fu poi compiuta più felicemente nel 1860 da Garibaldi – e che al giovane napoletano frutto la morte. Ma si vorrà perdonarci se, di questo scrittore, dottissimo e poco noto, di cose militari, abbiamo voluto più che non comporti l'indole di questa pubblicazione, narrare le vicende fortunose. Delle sue doti militari avremo frequenti saggi nel corso dello Assedio di Roma.”
La commissione, composta da cinque individui, per studiare l'ordinamento dell’esercito e provvedere alla difesa – che il deputato Mazzini aveva proposto nei giorni precedenti – fu eletta il 18 marzo 1848 e Pisacane ne divenne l’anima (39) .
Entrata di Mazzini in Roma - 1849 |
Durante la difesa di Roma Pisacane divenne una figura di statura nazionale, svolgendo il ruolo di capo di Stato Maggiore (nominato il 27 Aprile 1849), ovvero di comandante in capo delle operazioni militari. In questa veste sorsero i dissidi e le differenze (40) nella conduzione della guerra tra un Garibaldi, che in sudamerica aveva fatto esperienza di guerra per bande, e un Pisacane, educato alla scuola militare della Nunziatella, che riteneva doversi inquadrare le milizie popolari in una unica organizzazione dell’esercito a cui dovevano sottostare (41) . Questa differenza di vedute emerge sia da varie testimonianze che dagli scritti dello stesso Pisacane (42) :
"Il generale Garibaldi già si trovava al servizio della repubblica, col grado di colonnello, e stanziava in Rieti. Il non volersi uniformare ai regolamenti, a cui l’armata tutta si sottoponeva, lo rendeva d’impaccio ai partigiani del vecchio sistema, ed era considerato più dannoso che utile. — Ma, uno di quei pochi dotati del genio per dirigere nelle circostanze difficili, e che sanno giovarsi di qualunque elemento, il generale Garibaldi era considerato come un essere esclusivo, ed utile, adoperandolo in modo da non sortire della sua sfera. La commissione di guerra, convinta di questa verità, nel decretare la formazione dell'esercito, e nel dividerlo in due campi, dichiarava il corpo di Garibaldi corpo di partigiani indipendente dell’armata. Ma richiamato in Roma nell'avvicinarsi del nemico, ed avendo il 30 aprile con la sua legione sostenuto il forte del combattimento, Avezzana, allora ministro di guerra, lo promosse generale.
Prode di persona Garibaldi, e di carattere dolcissimo, sempre sul sito del combattimento, dando le disposizioni con la massima calma, era perciò caro ai suoi soldati. Il suo bello aspetto, il suo modo esclusivo di vestire, le sue abitudini l'aveano circondato di un tale prestigio da far credere a lui stesso di avere le capacità di gran generale, mentre egli non avea che il genio del guerrigliero, il quale impegna gli uomini quasi individualmente, senza fare uso delle masse, solo mezzo deciso in guerra; credeva poter condurre un’armata di 30 mila bajonette nel modo stesso che si conducono 300 uomini.
Questi due individui, d’indole tanto diversa, erano alla testa dell’armata. Garibaldi mal soffriva essere subalterno di Roselli, e cercava sempre di emanciparsi, e guadagnare il freno; Roselli cedeva in tutto. Il governo, col suo metodo di dolcezza, cercando amalgamare, non faceva che sempre più favorire l’indipendenza del primo. In tal modo Roselli non era più capace di dare un’ordine, né era ubbidito ove comandava Garibaldi.
Ora, dando pari autorità ai due generali, non si faceva che dichiarare Garibaldi generale in capo, dappoiché Roselli, incapace di lottare contro di lui, sebbene superiore, non poteva certamente conservare la sua indipendenza come uguale. L'armata tutta sentiva ciò. La legione formata dal generale Garibaldi, avea inaffiato le mura di Roma del suo sangue patriottico, ed un tal corpo per valore e per travagli durati era al certo il più benemerito della Repubblica.
Ma disgraziatamente nella generalità di questo corpo regnavano dei pregiudizi nati dalla mancanza di cognizioni militari dei capi, che facevano disprezzare tutto ciò che era regolare e tradizionale. Ed i militi della legione non aveano rispetto veruno per gli uffiziali di altri corpi, e però l’armata temeva l’immediato contatto della Legione. Garibaldi conosceva ciò e cercò ottenere individualmente quello che non poteva ottenere dalla massa, e difatti moltissimi individui abbandonarono il corpo per arrolarsi nella sua legione, e la sera del 2 luglio al cader del sole sortì da Roma da porta S. Giovanni, con 3000 fanti e 500 cavalli.”
PATRIOTI NAPOLITANI E PATRIOTI ITALIANI
Risale a questo periodo la eventualità che Filippo Pisacane e Carlo Pisacane si scontrassero sul campo, nella battaglia di Velletri, militando su due fronti opposti, quello “napolitano” e quello “italiano”. Ci piace riportare qui, su tale eventualità, le considerazioni, che condividiamo appieno, di Nello Rosselli (43) :
“Del resto, mi si consenta la digressione, pare a me che si possa e si debba ormai (son passati ottant'anni) guardare con uguale rispetto al Pisacane «italiano» e a quello accanitamente borbonico; e infatti se l'uno contribuì direttamente alla formazione unitaria del nostro paese, l'altro — e con lui gl'innumerevoli dimenticati e vilipesi che fino all'ultimo e con personale sacrificio sostennero i regimi ritenuti legittimi — lasciò un esempio, sempre valido, di coerenza ideale, di dirittura, di serietà, di fedeltà a un principio e nella sua fortuna e nella sua definitiva disgrazia.”
Nonostante la onesta considerazione del Rosselli vogliamo sottolineare l’espressione “accanitamente borbonico” per descrivere un soldato (Filippo) che, semplicemente, combatteva per la patria napolitana e per il suo Re, mantenendo fede ad un giuramento. Un giuramento prestato anche dal fratello Carlo, come Alfiere del Corpo Reale del Genio di Sua Maestà il re Ferdinando II, il 30 giugno 1842 in Pescara, (44)
Se volgiamo lo sguardo indietro, alle narrazioni della storiografia patriottarda degli eventi che precorsero e caratterizzarono il risorgimento italiano, non possiamo non farci delle banali domande: chi era il patriota? Filippo, che continuava a militare nel proprio esercito, con onore e dignità, oppure il fratello Carlo, disertore da oltre due anni?
Nel 1799 chi erano i patrioti? Coloro che seguirono il Cardinale Fabrizio Ruffo (45) oppure chi parteggiava per Championnet?
Nell’ottobre del 1860 sul Volturno chi erano i patrioti? Le raccogliticce bande garibaldesche (46) , tra cui soldati piemontesi finti disertori, (47) oppure i soldati regolari dell’esercito napolitano?
A Gaeta erano patrioti quelli cadevano sotto le bombe per difendere la propria terra oppure chi li bombardava senza neanche aver loro dichiarato guerra?
Durante la guerra civile – passata alla storia come “brigantaggio”– chi furono patrioti? I membri della Guardia Nazionale e l’esercito sabaudo che sparavano sui briganti?
***
Se vi capita, leggete le lettere che si scambiano i due fratelli nel settembre 1849. Nonostante le polemiche sul dissidio con le scelte di Garibaldi, dissidio riportato da numerosi autori (48) , pur di dimostrare la superiorità militare e l’ardore nel combattimento delle armate repubblicane, in una lettera così scriveva a Filippo (49) :
“benché tu mi parli della fuga di Garibaldi io però lo trovai anche padrone del campo, esso con la sola avanguardia vi avea respinto in Velletri; [...] appena mi assicurai della vostra ritirata, io dava già gli ordini per appoggiare alla vostra sinistra, filare per le alture, e venire a piombare nel mezzo della vostra marcia di fianco sotto Cisterna, ti assicuro che sarebbero stati guai, voi eravate in pessima posizione.”
Più avanti, non risparmiava critiche ai soldati napolitani e al fratello, secondo lui asservito a Re Ferdinando:
“da per tutto, l’armata Napoletana è tenuta a vile; [...] io provo il bisogno di pensare liberamente, di parlare liberamente, di esser sicuro sulla mia libertà individuale pronto ad impugnar la spada per l’Italia, [...] sono sempre per le leggi e pel popolo. Tu non provi tutti questi bisogni, senti solamente il bisogno, di essere l’istrumento, del più vile di tutti gli esseri.”
In queste righe al fratello Filippo trasuda tutta quella insopportabile presunzione, convinzione della superiorità morale delle proprie scelte rispetto a quelle altrui. Convinzione tipica di certi cospiratori (convinzione ereditata poi dai movimenti di sinistra e libertari), per i quali tutto quanto non rientri nei loro parametri culturali sia da buttare nella discarica della storia.
***
Ai fini della comprensione della personalità del Pisacane interessante anche la lettura di quanto egli scriveva al generale francese, reo di voler abbattere la Repubblica Romana! (50)
Ne riportiamo un estratto, ve ne consigliamo la lettura integrale:
“GÉNÉRAL,
L'amour pour le métier des armes et l’amour pour la vérité me poussent à vous écrire cette lettre, où je tâche de prouver votre incapacité militaire, et de mettre au jour les mensonges que vous avez dits.
[…] Vous avez dit que le peuple Romain désirait le retour du Pape; donc, vous étiez parfaitement décidé à renverser la République romaine, à abattre le drapeau Italien et la hisser celui du Pape. Vous avez laissé flotter a Civita-Vecchia notre drapeau et briller les couleurs italiennes avec l’arbre de la liberté jusqu'au 15 juillet, pour cacher vos intentions, et pour nous tromper. Ce n’est pas à la tête d’une armée qu'on fait cela.
Vous avez marché tout droit sur Rome avec 6 ou 7 mille hommes. Nous pouvions disposer de 12 mille hommes. Si à Rome on avait suivi mon avis de confier la ville, à la garde nationale et de vous tourner, avec nos troupes disponibles, du côté de Viterbe, vous auriez été acculé la une grande ville ennemie, en face d’une année presque double, et coupé complètement de votre base.”
CADUTA DELLA REPUBBLICA ROMANA
A luglio le truppe francesi riuscirono a penetrare nella città. Carlo Pisacane venne fatto prigioniero e rinchiuso in Castel Sant’Angelo. Fu solo grazie all’intercessione di Enrichetta, che come infermiera aveva soccorso anche soldati francesi feriti, se riuscì a riconquistare la libertà.
Con la caduta della Repubblica Romana ricominciò l’ondata migratoria italiana (51) :
“I più, come l'anno innanzi, riparano in Isvizzera; molti forse obbedendo all'ingenuo eppur tanto comprensibile desiderio di non lasciarla troppo, l'Italia, che troppo spazio di cielo, troppa difformità d'idioma e di costumi non si frappongano fra loro e l'Italia. Eppure, non è più l'estate del '48, quando, per tanti segni evidenti, si rivelava imminente agli esuli la possibilità del ritorno. Ora, da un capo all'altro della penisola, l'orizzonte è abbuiato; due anni di lotte, dopo aver tutto sconvolto, non hanno giovato in ultima analisi a mutare d'un palmo la carta d'Italia. Ora, è l'esilio per davvero. Ma l'illusione regna benefica fra gli emigrati.
Poveri quasi tutti, affittano stanzucce mobiliate a Losanna, a Ginevra, a Lugano, a Capolago, a Locarno; molti s'aggruppano, per paesi d'origine e più per concordanza d'idee, in una stessa casa o alla stessa mensa, assieme discutendo il recente passato, leggendo gli stessi libri e giornali e riviste, arrabattandosi a scovar lezioni o impiegucci provvisori o traducendo o scrivendo. I giorni di festa si ritrovano in brigata in qualche casa ospitale, o alla Castagnola dai Cattaneo, o a casa Airoldi da Grillenzoni, o presso il poeta Dall'Ongaro.
[..] A Losanna, sulle sponde del lago, si riuniscono a vita comune in una modesta villa (Montallegro) Mazzini, l'ex triumviro Saffi, Mattia Montecchi, più tardi il veneziano Varè; brevi soggiorni vi fanno Filippo De Boni e Maurizio Quadrio, per qualche giorno v'abita lo stesso Pisacane, fissatosi da prima a Ginevra. «Da sessanta a settanta franchi al mese per testa — racconta il Saffi — bastavano al nostro mantenimento... Spendevamo la giornata a scrivere articoli..., a tener viva una vasta corrispondenza epistolare, a promovere, per quanto dipendeva da noi, l'ordinamento della parte nazionale all'interno e fra gli esuli. Le prime ore della sera erano date al conversare, a ricevere amici, al giuoco degli scacchi, di cui Mazzini molto si dilettava...» E Mazzini, di Pisacane: «Ci ricongiungemmo a Losanna dove io lo vedeva ogni giorno, sereno, sorridente nella povertà, com'io l'aveva veduto in mezzo ai pericoli».”
In Svizzera, Pisacane fu attratto dalle idee di Bakunin e si avvicinò al socialismo utopistico e libertario. Dopo Losanna, Pisacane ed Enrichetta partirono per Londra (52) , dove giunsero il 20 novembre 1849. Si presume che, nei sette mesi di permanenza nella capitale inglese, Pisacane abbia avuto occasione di incontrare personaggi di rilievo. A tal proposito Nello Rosselli scrive (53) :
“Non capitava proprio tutti i giorni la possibilità d'incontrare in un miglio quadrato gente della risma d'un Blanc, d'un Leroux, d'un Ledru-Rollin, d'un Cabet, d'un Dupont; né d'imbattersi, tra i banchi del British Museum, col celebre autore del Manifesto dei Comunisti. Chi di costoro riuscì Pisacane a avvicinare?
[...] Nel luogo e nell'ambiente in cui un Marx andava studiando ed esponendo le cause economiche dello scoppio rivoluzionario del '48, e un Ledru-Rollin dipingeva nella sua opera sulla Decadenza dell'Inghilterra un quadro impressionante delle condizioni del proletariato britannico; in cui si compilavano, per seminarli poi in tutto il continente, giornali e riviste ispirati al socialismo; in cui si formavano tra gli esuli delle varie nazionalità clubs socialisti e comunisti; in questo luogo e in questo ambiente Pisacane, all'indomani del '48-'49, non poteva trascorrere sette mesi senza che il suo orientamento spirituale ne risentisse profondamente.”
In quei mesi Enrichetta soffri molto a causa del clima londinese, ne parlò con Filippo Pisacane in una lettera (54) :
«La mia salute era colà molto migliorata, ma, ritornando qui fra questa maledetta nebbia sono ricaduta coll’infiammazione alla gola e mi ero persuasa di ciò che dicono i medici, cioè che se passo un’altra cattiva stagione in Inghilterra finirei per essere tisica, invece se ritornassi ora in Italia, sarei immediatamente guarita».
Nel giugno 1850, gli esuli decisero di lasciare Londra. Con passaporto intestato a James Stansfeld ((55) ), tornarono in Italia. Lasciata la sua compagna a Genova, Pisacane si recò a Lugano. Sui motivi di questo viaggio in Isvizzera, si interroga Rosselli (56) :
“Ma perché poi, munito di un passaporto sotto mentito nome, quello di Giacomo Stansfeld, lasciasse Londra per tornare ancora una volta a Lugano, è un mistero. Forse una missione affidatagli da Mazzini? Oppure Cattaneo e Macchi o qualcun altro gli hanno trovato un provvisorio impiego? Silenzio dei biografi: anzi Mazzini scrive che da Londra ripartì per l'Italia e nei Cenni premessi ai suoi postumi Saggi si legge che nel giugno '50 si trasferì dall'Inghilterra a Genova. E non è vero.
***
In una nota al testo lo stesso Rosselli afferma di aver ricostruito gli spostamenti consultando non solo tutti gli scritti di Mazzini e di Macchi ma anche quelli del Record Office di Londra. Secondo il nostro modesto parere, la distruzione del carteggio fra i due amanti Enrichetta e Carlo (57) , impedisce di porre alcuni tasselli mancanti o incerti della biografia di Pisacane.
Risale a questo periodo la breve infatuazione tra Enrichetta e Cosenz (amico e compagno d’arme alla Nunziatella del Pisacane). Cosi viene decritto dal Rosselli la sbandata sentimentale della donna di Pisacane (58) :
“Mentre ella si trova in questo tristissimo stato, lontano il suo Carlo e forse unicamente assorto nella stesura del suo libro, tra quei che la frequentano, uno — il Cosenz, coetaneo e amico d'infanzia di Pisacane — s'invaghisce di lei. Enrichetta, pur non cessando di amare il suo Carlo, sente che una irresistibile forza la trascina suo malgrado a ricambiar quell'affetto. È come se ella non avesse più volontà sua; segue con la lucidità di un'allucinata il progredir del suo male, ne fa una spietata diagnosi come se si trattasse di un'altra persona, non sa reagire; i suoi sensi tendono irresistibilmente verso quel nuovo tepore; la ragione, che si ribella, crea il conflitto interiore, tormentosissimo. Leali fino allo scrupolo, i due non nascondono all'amico lontano il loro dramma, che è il suo dramma. Gliene descrivono le fasi con fredda imparzialità, come se si trattasse di un problema difficile da risolvere: che fare? Cosenz dovrebbe sposarsi di lí a poco, ma come lo potrebbe onestamente?
Pisacane risponde: maledice, minaccia, vitupera? Macché. È straordinaria la capacità che certi sentimentali dimostrano di notomizzare il proprio sentimento affettando indifferenza pei resultati che l'esame darà: Pisacane (lo s'intende dalla lettera di lei) non scongiura neanche; probabilmente, riconosciuta la libertà che ad Enrichetta compete di cercarsi la felicità ove meglio ella creda, si limita alla parte del consulente. Nello stesso modo che, italianissimo com'è, ha fatto un bilancio severo dei recenti avvenimenti italiani, fa adesso, impassibile, il bilancio, che potrebb'essere di liquidazione, della sua esperienza d'amore: come se tutto ciò non fosse in carne viva... Non ha diritti, non ha dunque pretese; ragiona solo nell'interesse di lei. Ma le cose che dice, lui che nell'animo di Enrichetta ha imparato — ormai da dieci anni — a leggere come in un libro aperto, son cose che aiutano lei a veder chiaro, a distinguere, nella crisi, gli elementi puramente sentimentali dai molt'altri di diversa natura: solitudine, malinconia, nostalgia della casa e dei figli. Non è forse possibile che Enrichetta abbia esagerato il suo male a forza di tormentarcisi su? Che ingenuamente abbia veduto nel Cosenz, avvicinatosi quando la crisi aveva raggiunto il suo apice, il deus ex machina che ne l'avrebbe tratta fuori, quando invece nessuno fuorché il suo io profondo avrebbe potuto placare la tempesta interiore? La risposta di Pisacane, comunque, suona ad Enrichetta come la voce amica che la risveglia dall'incubo. Finalmente si muove, reagisce al fatalistico abbandono cui ha ceduto sinora, resiste alla corrente che stava portandola via, nessuno sa perché. Cosenz è un amico provato, capisce, si allontana.
1850 – 1857
IL ROMITO DI ALBARO
Il 12 novembre 1850 Pisacane ritornò a Genova e vi restò, insieme a Enrichetta, fino a giugno del 1857, in una dimora ad Albaro (59) , una collina separata da Genova dal Bisagno. Nella città ligure in quegli anni vi erano centinaia di profughi politici da ogni parte d’Italia (60) :
“Genova formicolava allora di emigrati politici di tutte le regioni italiane. Qualche anno più tardi una statistica ufficiale ne censiva, tra stabiliti in città e dispersi in provincia, ben 1500! A Torino non minore affollamento, con questa differenza: che mentre a Genova, sempre repubblicaneggiante e non per nulla la patria del Mazzini, convergevano per lo più gli uomini di sinistra; nella capitale, attirati dalle maggiori probabilità di cacciarsi in qualche pubblico impiego, affluivano piuttosto gli elementi temperati e costituzionaleggianti. Gran daffare e grattacapi d'ogni genere, pel governo, questi emigrati: su cento che ne giungono ottanta non recan con sé di che campare otto giorni. Conviene per altro aiutarli, mostrar loro che solo il Piemonte, il quale in certo modo rappresenta l'Italia di domani, prende interesse a loro; a trattarli bene, c'è da convertirli tutti pian piano al regime costituzionale e farne amici provati, checché stia per succedere, del regno sabaudo. Bisogna per altro andar cauti per non urtare la gelosa suscettibilità degli altri governi italiani. Eterna questione dell'asilo ai fuorusciti: il Piemonte la risolve con molta abilità, con molto tatto. Stanzia un sussidio annuo in pro degli emigrati affidandolo, per la distribuzione, a un Comitato apposito, col patto che li sorvegli e tenga in freno; spalanca le porte dell'Università a taluni meridionali illustri nelle scienze; rispetta il più che può le mille iniziative di quest'accolta un po' turbolenta d'ingegni senza patria, lascia che impiantino giornali e riviste, procura che il censore li tormenti quanto meno è possibile; si oppone d'altra parte alle manifestazioni collettive in genere, vorrebbe che smorzassero tutti un poco la voce.
Se gli emigrati gli costano molto, se a volte gli suscitano grossi guai all'interno e pericolosi incidenti diplomatici, un grandissimo bene ne viene in ultima analisi al regno ospitale. Si può dire che il tono della vita culturale piemontese venga rinnovato, sveltito, sprovincializzato dal contatto con questa «intelligenza» italiana. Il brio, la prontezza, la versatilità degl'ingegni meridionali ad esempio (e solo di napoletani e siciliani ve n'erano presso che un migliaio) esercita senza dubbio la più benefica influenza sul massiccio, grave, qualche volta un po' tardo temperamento dei pedemontani. La stampa di Torino, di Genova diventa in pochi anni, non senza merito loro, strumento agilissimo, vivace, battagliero di lotta politica; l'insegnamento superiore acquista in modernità e spregiudicatezza; la letteratura politica in profondità varietà e abbondanza. Talune nuove correnti ideali vengono addirittura importate e propagate per opera quasi esclusiva di emigrati, molti dei quali, viaggiando sovente e tenendo con l'estero assidua corrispondenza, contribuiscono a far del Piemonte, assai più che non fosse, una provincia d'Europa.”
***
Gli anni tra il 1850 al 1857 furono dedicati alla “riflessione filosofica, storica, etica, economica, politica, sociologica ed antropologica” e allo studio “come egli stesso raccontò al fratello il 19 maggio 1853” in una delle lettere pubblicate nel 2015 da Ernesto Maria Pisacane (61) :
“mi alzo alle cinque del mattino e passo due o tre ore al tavolino, quindi un’oretta di esercizio, e poi sino alle quattro studio; il dopo pranzo lo passo con Enrichetta, leggiamo insieme qualche opera classica [...]. La sera vado a letto alle 9, qualche volta anche prima [...]. Ho avuto la fortuna che il padrone di casa, professore del collegio nazionale, mi ha lasciato a disposizione una libreria di circa 700 volumi, quindi studio a mio bell’agio.”
Dei suoi studi si fa cenno anche in una nota al testo “La spedizione di Sapri poemetto epico-lirico” di Eliodoro Lombardi (62) :
“Degli studi sociali e filosofici del Pisacane possono far fede, come indicammo nella prefazione, i suoi Saggi storici, politici e militari e il suo libro Sulla guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49, dettato nel ritiro di Albaro, e pubblicato a Genova nel 1851, per cura dell'editore Giuseppe Pavese. Da quel libro, e meglio anche dai Saggi, traspare, con evidenza, come egli si fosse già reso strenuo propugnatore di quella che addimandasi Religione razionale.”
PROGETTI DI SBARCO NELLE DUE SICILIE E GUERRA DI CRIMEA
In quegli anni diversi cospiratori, fra cui Pisacane, maturarono il progetto di fomentare la ribellione nel Regno delle Due Sicilie.
Lo stesso Mazzini già dal dicembre 1850, in uno scambio epistolare con Crispi (63) , descriveva gli abitanti della Sicilia come popolazioni «cosi stanche da cacciarsi in braccio a qualunque dia loro un principio d'azione».
Il 10 ottobre 1851 il Comitato centrale di Sicilia, con sede a Palermo, informava il Comitato Siciliano in Genova di avere richiesto a Mazzini che, in previsione di un probabile moto insurrezionale nell'isola, scendesse colà «uno stuolo di emigrati risoluti e capitanato da famoso condottiero» e si faceva espressa indicazione che questo fosse Garibaldi, il valoroso difensore di Roma (64) .
Mazzini nel novembre successivo ne informò Garibaldi che si trovava a New York (65) , e nel febbraio 1854, quando questi sbarcò a Londra dalla nave Commonwealth e andò a trovarlo, gli propose una spedizione in Sicilia.
Leggiamo cosa scrive George Macaulay Trevelyan (66) :
“And so when, in February 1854, the captain of the Commonwealth landed in London docks and went to find his old friend and teacher, Mazzini was in fact face to face with one of his supplanters. But his only thought was at once to use him and all that his name was worth to initiate another revolt.
Garibaldi, he wrote on February 16, is here; ready to act. Garibaldi's name is all powerful among the Neapolitans, since the Roman affair of Velletri. I want to send him to Sicily, where they are ripe for insurrection and wishing for him as a leader.
It appears, however, that Garibaldi's readiness to go to Sicily was entirely conditional on the Sicilians first rising themselves and calling on him to come over and help an insurrection already afoot. These were the conditions on which he absolutely insisted, both now and on every later occasion when the scheme was proposed, until its successful execution in 1860. Indeed, in August 1854, only six months after this interview with Mazzini, he wrote to the Italian papers to warn the youth of his country against rash enterprises initiated by men deceiving and deceived, which only serve to ruin or at least discredit our cause.
But whatever really passed between the two men with regard to Sicily, the most significant word spoken by Garibaldi to Mazzini at this time in London was that related for us by an ear-witness, Alexander Herzen. It would not, said Garibaldi, be well to offend the Piedmontese Government, for the main object now was to shake off the Austrian yoke, and he doubted greatly whether Italy was as ripe for an United Republic as Mazzini supposed.
Garibaldi spent more than a month in London, making some close friendships, and forming those strong ties of mutual attachment which ever afterwards bound him to our country.”
La risoluzione di Garibaldi – accettare di mettersi a capo di una spedizione verso il Regno delle Due Sicilie solo per andare a dare manforte ad una insurrezione già avviata da elementi locali – spiega sia il rifiuto che egli porrà alle proposte di Pisacane, (67) sia le titubanze dell’aprile 1860, titubanze superate grazie a Crispi, agente di Mazzini, anzi degli inglesi, come sostengono taluni (68) .
***
La vulgata, che circola in ambienti identitari, secondo cui egli sarebbe stato un pupazzo senza alcuna qualità politica, una delle tante pedine manovrate da Cavour, a nostro avviso, è inconsistente. Di sicuro egli aveva un senso degli accadimenti e delle scelte da fare (69) nonché della guerra per bande, di cui difettava certamente il “romantico” Pisacane.
Già in una lettera a Manin, datata “Torino, 1º dicembre 1855”, Pallavicino scriveva: «Anche Garibaldi è con noi. Ho veduto una sua lettera a Valerio, in cui si loda il nostro pensiero.» (70) Una ulteriore comprova che, diversi anni prima della Spedizione dei Mille, Garibaldi si era convinto che, per realizzare l’unità d’Italia, occorresse puntare sulla monarchia piemontese (71) ; ciononostante, egli continuava a mantenere rapporti con numerosi mazziniani.
***
Chissà se l’invitto, durante l'incontro di fine maggio 1857, motivò il suo diniego a capitanare la spedizione nel Cilento, magari svelando che, nell’agosto 1856, aveva incontrato Cavour (72) e che era giunto alla determinazione si dovesse agire di concerto con Casa Savoia!
“In un colloquio che ebbe in Genova, il 6 di agosto [1856], coll'intimo amico suo Felice Foresti, il generale Garibaldi disse esplicitamente che, istigato da molti patrioti emigrati o dimoranti nell'Italia Centrale e nella Sicilia a mettersi alla loro testa per incominciare un ardito movimento nazionale, non aveva creduto né credeva poterlo fare perchè, secondo lui, si doveva far tesoro delle forze piemontesi regolari e volontarie. Il Garibaldi soggiungeva che la spinta al movimento, almeno indiretta, doveva partire dal governo sardo, e che, se questo era disposto a non frammettere indugio al compimento del gran disegno, egli offriva fin d'allora il suo braccio, la sua vita all'Italia «e per essa alla Corona Sabauda.» E conchiudeva: «Vorrei vedere preparativi, udire assicurazioni d'appoggio: maneggi, movimento, vita!... Giorgio Pallavicino e gli altri, che più facilmente avvicinano il Re ed i ministri, si dieno le mani attorno; che mettano insieme de' mezzi, che non mi lascino così sull'arena...» Il 13 agosto seguente il generale Garibaldi, venuto in Torino, fu ricevuto dal conte di Cavour. In una lettera, in data di Genova 15 agosto, del Foresti al Pallavicino, è fatta menzione di questo importante colloquio dei due grandi italiani:
Il nostro Garibaldi era a Torino il 13 del corrente, ed io ve l'accompagnai. Cavour l'accolse con modi cortesi e famigliari ad un tempo: gli fece sperar molto, e l'autorizzò ad insinuare speranze nell'animo altrui. Pare ch'ei pensi seriamente al grande fatto della redenzione politica della nostra penisola, ma, diceva esso, il solo ostacolo grave in cui intoppa l'azione, è la presenza dei Francesi in Italia; tolta questa, tutto procederà avanti bene e presto. Insomma Garibaldi si congedò dal ministro come da un amico che promette ed incoraggia a un'impresa vagheggiata.
L'adesione, sebbene non illimitata, di uomini, come il Manin e il Garibaldi, al programma nazionale del Piemonte fu un gran trionfo pel conte di Cavour.”
L’unico tentativo – prima della impresa dei Mille – in cui riuscirono a coinvolgere il nizzardo fu quello della “The Isle of Thanet”, nave acquistata grazie alla collaborazione tra Antonio Panizzi ed eminenti uomini politici inglesi, per far evadere dal carcere di S. Stefano nell’isola di Ventotene (73) , Luigi Settembrini, Silvio Spaventa ed altri patriotti. La rotta venne tracciata dallo stesso Garibaldi, il quale doveva recarsi a Londra e prenderne il comando. Una tempesta provvidenziale lo beneficiò da un probabile insuccesso! L’imbarcazione naufragò sulle coste dell'Inghilterra, al largo di Yarmouth (74) e il piano fallì.
***
Di un progetto di sbarco nella parte meridionale d’Italia scriveva Enrico Cosenz a Giorgio Pallavicino (75) , in una lettera, datata “Torino, 11 giugno 1856”:
“Pregiatissimo Signore,
Ecco quanto mi viene assicurato da fonte sicura e da vari altri canali, cioè che la parte meridionale è disposta a muoversi, qualora non fosse affatto deficiente d’armi. Certo, non fuvvi mai opportunità migliore di questa, essendovi l'approvazione di tutti i patriotti italiani, a qualsiasi partito politico essi appartengano. Qualora poi si potessero introdurre armi, o, ciò ch'è meglio, un poderoso numero d’armati, non è a dubitarsi che il paese tosto non insorga. Dal di fuori non si potrebbe iniziare un movimento di qualche importanza senza l'appoggio di una potenza. Or, ci si fa credere che l’Inghilterra lascierebbe fare, facendosi cautamente; ed anzi permetterebbe che la legione Anglo-Italiana venisse imbarcata; su che vennero di già iniziate le necessarie pratiche. Per poter meglio ciò eseguire, vi abbisognerebbero due vapori; e siccome ne vennero proposti due, ed a buon prezzo, cosi ci fa mestieri, prima d’inoltrarci nelle pratiche, sapere se in tempo utile avremmo disponibile una certa somma. Garibaldi sarebbe fra i caldi promotori di questa impresa; ha già visitati i vapori, e li ha trovati adatti allo scopo. Egli si ripromette molto della riuscita, se le cose saranno realmente nelle condizioni suindicate.”
Nel giugno 1857, Cosenz, come Garibaldi, decise di non partecipare alla spedizione di Sapri, lasciando che Pisacane andasse da solo incontro al proprio destino. Appena tre anni dopo, nel luglio del 1860, organizzò la III spedizione in soccorso di Garibaldi in Sicilia (76) .
Da leggere alcuni testi ed epistolari (77) che documentano i legami di Garibaldi con Cavour, Pallavicino, Valerio, Fabrizi ed altri. Dalla lettura emerege l’attenzione che egli mostrava al mantenimento del proprio prestigio fra i cospiratori o patrioti che dir si voglia (vedi lettera a Dell’Ongaro datata New Castle, 26 mars 1854 e lettera a Macchi, datata Caprera, 31 ottobre 1858).
***
Col sopraggiungere della guerra di Crimea (78) cospiratori ed esuli si interrogarono sul da farsi. Cattaneo si rivolse a Pisacane chiedendo lumi sulle ricadute della guerra nella politica dei vari stati italiani. Riportiamo le illuminanti parole di Nello Rosselli (79) , il quale definì “colpo di genio” la scelta di Cavour di partecipare della coalizione anglo-francese a favore della Sublime Porta:
“Ma se Cattaneo era al buio, figurarsi Pisacane; il quale una cosa sola allora capiva, che cioè quella guerra, in sé e per sé estranea affatto agl'interessi italiani, avrebbe forse potuto fornire un'occasione preziosa per la soluzione italiana della questione italiana: distraendo l'attenzione di Francia e d'Austria dal famoso equilibrio nella penisola, così caro ad entrambe, e soprattutto decongestionando l'Europa di truppe. Non aveva egli scritto quattr'anni innanzi che, supposta l'Italia sgombra dagli stranieri, non era poi tanto difficile di provocarvi lo scoppio della rivoluzione integrale? Perciò a Cattaneo che lo incitava a partir per la guerra «poco importava se coi Turchi o coi Russi, purché potesse acquistarvi esperienza delle guerre grandi e reputazione», egli rispose di no: quello era un momento da non lasciare l'Italia.
Né egli solo la pensava così: era presentimento abbastanza diffuso, seppure indeterminato, che da quel conflitto anche a noi sarebbe derivato qualcosa. Ridda di vaticini; ma certo eran pochi quelli che s'aspettavano la mossa del ministro Cavour, partecipazione cioè del Piemonte alla guerra a fianco delle potenze occidentali. Colpo di genio che la parte democratica, in blocco, fraintese, scagliando contro di esso il furore appassionato delle sue proteste.”
***
Diversi cospiratori avanzarono il progetto di far sbarcare, in Calabria o in Sicilia, la Legione anglo-italiana che avrebbe dovuto compiere la traversata da Genova a Malta, in rotta per i campi di Crimea, Tra essi Benedetto Musolino (80) e Giuseppe Garibaldi (81) .
Il nizzardo si rivolse direttamente a Vittorio Emanuele, tramite un messaggio allegato ad una lettera a Valerio, datata “Nizza 4 Febbraio 55” (82) . Egli proponeva al re di arruolare 15mila uomini per la Crimea e altri 10mila da sbarcare in Sicilia, per scatenare una rivolta e conquistare l’isola. Risalgono a quel periodo quelli che storici del calibro di Romeo hanno giudicato semplici maneggi cavourriani, invece si trattava di una vera e propria pianificazione di uno sbarco sulle coste del Regno delle due Sicilie.
GITTARE IN ARIA IL BOMBA
Non solo qualche cospiratore, ma lo stesso Cavour accarezzò l’idea di uno sbarco (83) , in occasione degli arruolamenti per la guerra di Crimea. Ne scrive Roberto Martucci (84) riprendendo il testo del 1941 L’opera politica del conte di Cavour (1848-1857), di Adolfo Omodeo:
“Compulsando le Memorie storico-politiche del discusso agitatore Giovanni La Cecilia (1878, 327 ss.), Adolfo Omodeo vi evidenzia un riferimento a contatti intercorsi tra Cavour, l’intermediario La Cecilia e i patrioti calabresi Stefano Romeo, Domenico Mauro, Antonino e Agostino Plutino - risalenti alla «terza decade di febbraio 1854» (Omodeo 1941(2), 239), molto prima che lo statista entri in rapporto con Giuseppe La Farina - contatti finalizzati allo sbarco sulle coste della Calabria di cinquecento bersaglieri smobilitati con cento ufficiali, un fondo-cassa di due milioni di lire e un carico di cinquemila fucili militari (Omodeo 1941(2), 238): al fine di avviare una violenta azione destabilizzatrice, destinata a provocare locali fenomeni insurrezionali anti-borbonici suscettivi di espandersi a macchia d’olio. Se vogliamo riandare al contesto della crisi italiana dei primi anni ’50 del XIX secolo, si sarebbe trattato di una Spedizione di Sapri pensata molto meglio di quanto non avrebbe fatto Carlo Pisacane il 25-28 giugno 1857... ma non se ne fece nulla.
“L’interesse precoce di Cavour alla destabilizzazione e al successivo assorbimento per annessione del Regno delle Due Sicilie, viene confermato anche dal Diario manoscritto del generale Giacomo Durando, ministro della Guerra sardo durante il conflitto di Crimea. Secondo l’autorevole testimonianza, riesumata anch’essa da Adolfo Omodeo, lo statista subalpino aveva immaginato una sosta «tecnica» - a Napoli o Palermo - della spedizione La Marmora diretta in Crimea; le navi a vapore noleggiate dal governo sardo, per asserita mancanza di carbone, avrebbero dovuto entrare in rada sbarcando immediatamente i diciottomila soldati piemontesi, al fine di neutralizzare o annientare il dispositivo militare napoletano (Omodeo 1941(2), 239-240).
“Progetto anch’esso sfumato, a causa del timore per l’efficienza bellica della Marina militare napoletana; per altro, si tratta di un disegno avventurista che va incontro al veto opposto da Napoleone III: infatti, l’imperatore intende coinvolgere nell’alleanza di Crimea lo stesso re Ferdinando II delle Due Sicilie, chiedendogli di mettere a disposizione dei feriti alleati anglo-francesi l’ospedale militare di Brindisi. Ma il Borbone, in eccellenti rapporti con la Corte di Pietroburgo e mal consigliato, non se la sente di operare quel ribaltamento diplomatico che, contribuendo a rompere l’isolamento internazionale del suo Regno lo avrebbe probabilmente salvato, o, quanto meno, ne avrebbe ritardato di molto il collasso.”
***
L’interesse cavouriano ad avviare una azione destabilizzatrice nel Regno elle Due Sicilie è testimoniato anche dal progetto (85) di invio di Nicotera in Sicilia nel 1856:
“Nel 1856 il Cavour, volendo conoscere l'entità dell'insurrezione di Sicilia, chiedeva al La Farina un giovane per inviarlo nell'isola, e per la proposta di Antonino Plutino si rivolse al Nicotera, che senza esitare accettò il pericoloso incarico, quantunque su lui pesasse la condanna in contumacia di ventotto anni di ferri per la parte presa nella rivoluzione del 1848. Munito di passaporto con altro nome e con credenziali della casa Bolmida, per negozi di commercio, arrivò in Genova per imbarcarsi, ma contemporaneamente giungeva la notizia della impiccagione del martire Bentivegna, capo dell'insurrezione siciliana, ed il Nicotera fu richiamato a Torino dal conte di Cavour.”
Questa missione che il barone di S. Biase avrebbe dovuto svolgere in Sicilia darebbe ragione a chi sospetta che Nicotera fosse un uomo di Cavour sul Cagliari – ovviamente la nostra è solo una supposizione logica, non suffragata da riscontri documentali – ne fa cenno anche lo storico siciliano Rosario Romeo (86) il quale scrive che la notizia è «in qualche misura confermata dalle ricerche ulteriori».
Di un intervento nel regno di Napoli, anche con ricorso a “mezzi extralegali”, Cavur scriveva in una lettera del 10 aprile 1856 a Urbano Rattazzi (87) :
«Nell'uscire, gli dissi: Mylord, lei vede che non vi è nulla da sperare dalla diplomazia, sarebbe tempo di adoperare altri mezzi, almeno perciò che riflette il re di Napoli. Mi rispose: Il faut s'occuper de Naples et bientôt. Lo lasciai dicendogli: J'en viens causer avec vous.
Credo potere parlargli [a Clarendon] di gittare in aria il Bomba. Che direbbe di mandare a Napoli il principe di Carignano! O se a Napoli volessero un Murat, di mandarlo a Palermo? Qualche cosa bisogna pur fare. L’Italia non può rimanere nelle condizioni attuali. Napoleone ne è convinto e, se la diplomazia fu impotente, ricorriamo a mezzi extralegali. Moderato, di opinioni, sono piuttosto favorevole ai mezzi estremi ed audaci. In questo secolo ritengo essere soventi l’audacia la migliore politica. Giovò a Napoleone, potrebbe giovare anche a noi.»
***
Sui giornali circolò la notizia che 18.000 soldati napolitani si preparavano a partire da Napoli per la Crimea ma non se ne fece nulla. Il Regno delle Due Sicilie scelse una neutralità (88) che ne segnò il destino, fornendo agli alleati pretesti per accelerarne la fine.
Cavour, invece, si inserì nella vicenda, ottenendo quella che Martucci definisce «straordinaria tribuna internazionale» (89) :
“L’altro grande campo d’intervento è dato dalla complessa Questione d’Oriente, apertasi nel 1853 e che fornisce a Napoleone III il pretesto per mettere in discussione gli equilibri geopolitici sanciti a Vienna nel 1815.
Al momento, ne fa le spese la Russia zarista; l’Austria non sa cogliere l’opportunità di rafforzare il suo controllo sul bacino danubiano; il governo di Torino, ultimo venuto, ne otterrà una straordinaria tribuna internazionale da cui uscirà paladino dell’opinione nazionale italiana.
Posto di fronte a una richiesta britannica di fornire mercenari sardi per combattere in Crimea, colmando un imprevisto deficit di fanterie, Cavour riesce a forzare la situazione, creando le premesse di un’«accessione» sarda al trattato di alleanza franco-britannico, su di un piede di parità rispetto alle due Grandi Potenze.”
MAZZINIANI – MURATTISTI – IL GRANDE PARTITO ITALIANO
In quegli anni sulla scena dell’indipendentismo si muovevano mazziniani, murattisti e il partito nazionale, fondato da Manin-Pallavicino.
Intorno a Mazzini ruotava una galassia composita, una vera palestra per cospiratori che transitavano nei vari Stati Italiani, Londra, Parigi, Corsica, Malta. Citiamo qualche nome (anche di non mazziniani) che partecipò direttamente o indirettamente alle vicende che andiamo narrando: Carlo Pisacane, Nicola Fabrizi, Teodoro Pateras, Giuseppe Fanelli, Luigi Dragone, Giuseppe Garibaldi, Benedetto Musolino, Eleuterio Felice Foresti, Daniele Manin, Enrico Cosenz, Giovanni Nicotera.
La caduta della Repubblica Romana del 1849 e i moti del 1853 e del 1855 portarono molti aderenti o simpatizzanti della Giovine Italia ad allontanarsi e ad immaginare altre strade verso l’indipendenza e l’unità d’Italia. Per arginare la fuga Mazzini e frenare il sabaudismo dilagante innalzò la cosiddetta «bandiera neutra». Probabilmente nel giugno del 1856 il Mazzini la propose al Governo piemontese e il Cavour autorizzò il suo soggiorno a Genova e pare che i due restassero in contatto per qualche tempo.
Il Curatulo esclude contatti fra Cavour e Mazzini (90) :
“Si è da qualcuno parlato di trattative corse fra lo statista e il cospiratore, e che il primo gli avesse permesso di visitare Genova; ma l'affermazione non ha fondamento.”
Secondo Montanelli-Cervi, dopo il fallimento dei moti di Milano del 1853, per Mazzini tentò di risalire la corrente, attraverso una impresa faticosa, che in realtà era soltanto “un adeguamento tattico per recuperare i transfughi” (91) :
“Ora Cavour ne offriva un’altra: la rivoluzione senza rivoluzione, inquadrata nell’ordine costituito del Piemonte liberale. Era con questo avversario, molto più pericoloso dell’Austria, che l’Esule doveva vedersela.
[...] Fu per questo che a un certo punto egli inalberò la famosa «bandiera neutra» di cui abbiamo già detto, e che i più intransigenti fra i suoi seguaci gli rimproverarono come un tradimento.”
***
Intanto anche il muratismo (92) , non osteggiato apertamente da Cavour, si organizzava e tramava per insediare, sul trono di Napoli, al posto di Ferdinando II, Luciano Murat, cugino di Napoleone III (93) .
Scrisse il Maineri nel Proemio a “Daniele Manin e Giorgio Pallavicino - Epistolario politico” (94) :
“Si videro allora emissari andare e venire da Parigi a Torino, a Genova, a Napoli; ma se ebbero pochi seguaci, riuscirono però a trarre dalla loro molti prigionieri politici, languenti nelle galere e nelle carceri giudiziarie; sdegnosi rifiutarono Carlo Poerio, Spaventa, Mauro, Bianchi.... ed altri che aveano preso parte importante nella rivoluzione e nelle cospirazioni. S'intinse della trista pece anche Giuseppe Montanelli, anima perennemente incerta, e lo stesso Sirtori, al quale poscia l'amaro scrupolo annebbiava per poco la eletta intelligenza.
Ragioni e circostanze di tempi debbono temperare i giudizi dello scrittore; ma il vero insegna che quasi tutti i Napolitani emigrati in Piemonte, e specie gli stanziati a Torino, accostavansi alla strana parte, fra' quali primeggiavano Pisanelli, Scialoja, Massari, Caracciolo marchese di Bella.... frequentatori delle sale del pretendente; e con essi il prode Francesco Stocco, nella sollevazione calabra compagno al Ricciardi, indi generale garibaldino, poi deputato al Parlamento nazionale. Nella gita fatta in Ginevra dal Principe, compagno il Saliceti, vuolsi si recassero ad ossequiarlo, anche a soddisfazione di Camillo Cavour, Romeo di Reggio di Calabria, patriotta notissimo e audace uomo di azione, Cesare Correnti, splendida e coltissima intelligenza, ed altri che nei fasti del 1818 e 49 ebbero bella parte; non saprei se per atto di semplice cortesia o se per tastare il terreno, o se per simpatia di partigiani interessi. Questo fatto accese le ire de' più caldi nella emigrazione napolitana, occasionando fiera e minacciosa protesta; e trarrò testanti o italianissimi, come per celia allora venivano detti dai Murattisti, trovavansi Cosenz, Pisacane, Nicotera, De Sanctis, Le Piane, Miceli, Mauro, Salomone, ed altri, trentacinque circa. Gli ufficiali napolitani già alla difesa di Venezia e allor sulla Dora, dichiaravansi contrari al Murattìsmo, tranne Luigi e Carlo fratelli Mezzacapo; il signor Francesco Trincherà ebbe l’infelice coraggio di levarsi in iscritti contro alla nobile protesta. In generale s’accostarono alle idee del Saliceti quasi tutti coloro che vennero poscia qualificati consorti nel governo dell'inaspettato regno d'Italia; e taluni, i più teneri a Murat, poi più arrabbiati nella parte che aveva affannosamente afferrato il potere.”
Da leggere ciò che scrisse lo scrittore legittimista napoletano Salvatore Cognetti Giampaolo, il quale parlava dell'esistenza “d’una vasta cospirazione murattista, alla quale Cavour, se non tenea mano, lasciava fare”. Secondo Cognetti se “Vittorio Emanuele non avesse accettata la corona offertagli dalla setta unitaria, questa avrebbela concessa a Murat! Il tanto celebrato repubblicano Manin, veneto, in quel tempo era a Parigi, e di là soffiava continuamente pel Murat!” (95) ; le trame murattine sarebbero proseguite, per Cognetti, fino alla disfatta di Sedan.
Sul sostegno di tanti cospiratori al muratismo si soffermò anche Demetrio Salazaro in una sua opera sugli avvenimenti del 1860 (96) :
“L'emigrazione italiana nell'anno 50 e 51 era divisa in partiti. Repubblicani gli uni, Murattisti ed Autonomisti costituzionali gli altri. I primi, come sempre, erano ispirati da Mazzini, che per quanto onesto e strenuo difensore dell'unità nazionale, per un certo spirito settario, era, co' suoi, ostile a quanto s'operava in Piemonte dalla Corona e dalla Camera, e riuniva a sé la più eletta parte dell'emigrazione, sia per ingegno sia per posizione sociale.
I costituzionali del Regno delle due Sicilie erano quasi tutti propensi per l'impossibile Luciano Murat, il quale in quell'anno si trovava come Ministro plenipotenziario della Repubblica Francese alla Corte di Torino; il che provocò molta gelosia negli altri governi d'Italia.
Ed il Governo di Luigi Napoleone rispettando i dritti dei governi amici richiamò dalla corte di V. Emanuele il suo cugino, il quale lasciò sulle sponde del Po un comitato, per i pretesi interessi della sua corona!...
Il terzo partito era l'autonomista: non aveva un concetto chiaro di ciò che voleva, ne l'ebbe mai; accettava però un re d'una dinastia qualunque, fosse nazionale o straniera, non sene affannava. Questo partito più tardi fu il nucleo della consorteria!”
Ci è capitato di leggere che il “generale" Carmine Crocco Donatelli fosse in contatto con i murattisti, ma non sappiamo se esistono riscontri documentali.
***
Un altro movimento – il cosiddetto partito nazionale – che fini per incidere nel processo unitario fu quello guidato dal veneto Manin e dal patrizio lombardo Pallavicino. In esso confluirono anche il siciliano La Farina (97) e Garibaldi.
Sulla questione italiana Manin interviene, da Parigi il 22 gennaio 1856, con una lettera al Diritto, nella quale innalza la bandiera del grande partito nazionale italiano (98) :
“Il primo punto essenziale, sul quale tutti i patriotti italiani sono d'accordo, è l'indipendenza. Ma perchè l'indipendenza sia solidamente costituita e conservata, è necessario che l'Italia, cessando d'essere una espressione geografica, diventi una individualità politica. Tre sono le forme possibili d'individualità politica: unità monarchica, unità repubblicana, e confederazione repubblicana. La parola unificazione comprende queste tre forme. Dunque il secondo punto parimente essenziale è l'unificazione. Questi due punti sono reciprocamente connessi ed inseparabilmente legati: l'Italia non può essere unificata se non è indipendente, e non può durare indipendente se non è unificata. Ecco pertanto i cercati due termini della formula, ecco l'iscrizione della bandiera nazionale: Indipendenza ed unificazione.
[...] La monarchia piemontese, per essere fedele alla sua missione:
Dee sempre tenere dinanzi agli occhi, come regola di condotta, lo scopo finale, consistente nell'italiana INDIPENDENZA ED UNIFICAZIONE;
Non dee a verun patto, e sotto a verun pretesto, far mai alcun passo retrogrado, o divergente;
Dee con cura vigilante e vigorosa cercar d'allontanare e rimuovere tutto ciò che in quella via le potesse riescire d'impedimento o d'inciampo;
Dee quindi evitare tutto ciò che in qualunque modo le potesse legare le mani, astenersi da ogni accordo coi perpetui nemici d'Italia, l'Austria ed il papa, e a nessun prezzo prender parte a trattati che confermino o riconoscano quella posizione territoriale e politica ch'essa è chiamata a distruggere;
Dee mantenersi il nucleo, il centro d'attrazione della nazionalità italiana;
Dee impedire che altri nuclei, che altri centri d'attrazione si formino;
Quando la grande battaglia del riscatto nazionale sarà impegnata, dee prendervi parte risolutamente, e non deporre la spada finché l'Italia non sia fatta, arrischiando senza esitazione di PERDERE IL TRONO DI PIEMONTE PER CONQUISTARE IL TRONO D'ITALIA.”
Praticamente la lettera racchiudeva il programma di Gioberti! A quella lettera seguirono varie corrispondenze con altre testate giornalistiche, fino alla “dichiarazione contro l'assassinio politico” che fu “pubblicata in tutti i giornali inglesi, ed in molti giornali tedeschi”, secondo quanto scriveva lo stesso Manin a Lorenzo Valerio, da Parigi il 4 giugno 1856.
Un vero e proprio attacco ai metodi mazziniani, al quale seguì una ampia replica del Mazzini sul giornale “Italia e Popolo” tra giugno e luglio del 1856 (99) .
Con lettera datata “Torino, 15 ottobre 1856”, il Pallavicino intervenne pesantemente nella polemica, in particolar modo contro la bandiera neutra ovvero l’invito di Mazini a superare le divisioni e ad unire le forze:
“Molti vorrebbero, che la futura rivoluzione inalberasse la bandiera neutra perchè bandiera conciliatrice (dicono essi), e quindi atta, più che ogn’altra, a raccogliere in un fascio tutte le nostre forze.
Noi respingiamo la bandiera neutra, giudicando la conciliazione impossibile. La bandiera neutra (diciamo noi) è un tristo espediente, trovato dai diversi partiti per corbellarsi a vicenda. Si accetta oggi la bandiera neutra,... ma col fermo proposito di sostituirvi, alla prima occasione, quella di setta o di municipio.
Guaj a noi, se la rivoluzione inalberasse in qualche parte d’Italia una bandiera, ché non fosse quella del Piemonte Costituzionale! Ove ciò accadesse, avremmo su ’l bel principio la diffidenza, e più tardi la discordia nel nostro campo.
La bandiera neutra accrescerebbe le forze dei nemici d’Italia; ché tanti sarebbero li alleati loro, nel giorno della lotta suprema, quante sono le politiche opinioni che oggi dividono il popolo italiano.
La bandiera neutra significa: murattismo a Napoli — separatismo in Sicilia — republicanismo a Roma, a Genova, a Venezia — bonapartismo a Milano già capitale di florido regno sotto un Bonaparte... ecc. Ripetendosi li antichi errori malgrado le severe lezioni della storia, noi avremmo infallibilmente nuovi conflitti e nuove catastrofi.
Il municipalismo non è piaga soltanto del Piemonte, è piaga d’Italia. Oltre il municipalismo piemontese, noi abbiamo pur troppo un municipalismo lombardo, un municipalismo veneto — ligure — toscano, ecc. Il cancro esiste, bisogna estirparlo.
Non bandiera neutra!....”
Intanto Daniele Manin, in una lettera da Parigi del 4 novembre 1856 al Direttore del giornale l'Unione, si difendeva dalle voci di murattismo (voci a cui credeva anche Cognetti) che stavano circolando sul suo conto (100) :
“Un vostro corrispondente di Parigi mi annovera fra i partigiani del principe Murat. È notizia inesatta, che spero mi permetterete di rettificare. Io seguo la bandiera del partito nazionale, che vuole l'Indipendenza e l'Unificazione d'Italia.
[…] Murat, sul trono di Napoli, sarebbe fatalmente, per la forza inevitabile delle cose, l'emulo, il rivale, l'antagonista della Casa di Savoia; e perciò necessariamente l'amico e l'alleato, segreto o palese, del naturale nemico di essa, cioè dell'Austria.
Chi dice che Murat, diventato re di Napoli, darebbe una Costituzione liberale, farebbe alleanza col Piemonte, e fornirebbe un contingente di soldati per la guerra contro l'Austria, è ingannato od ingannatore.
Queste cose, Murat pretendente, le potrebbe promettere; ma Murat re, non le vorrebbe, non le potrebbe mantenere.
È lungi dalla mia intenzione ogni idea d'offesa personale. Non parlo dell'uomo, che non conosco: parlo della situazione e delle sue condizioni irresistibili.
Riassumo il mio pensiero e l'intima mia convinzione in queste parole:
Chi parteggia per Murat tradisce l'Italia.”
Ad appena un mese dal disastro di Sapri, il partito nazionale italiano, la cui nascita si può far risalire all’intervento di Manin inviato a La Presse del 19 Marzo e pubblicato il 22 Marzo 1854 (101) , si costituisce in Società Nazionale (102) :
“La politica mazziniana ebbe il colpo di grazia il 1.° agosto 1857 con la costituzione della «Società Nazionale» sotto la presidenza di Daniele Manin; il quale, morente, ne sottoscrisse gli articoli e il mese dopo venne sostituito da Giorgio Pallavicino con Garibaldi, vice-presidente e Giuseppe La Farina, segretario generale.”
Alcuni autori ritengono poco influente l’opera della Società Nazionale per lo scarso numero di associati che emergerebbe dai documenti. Non condividiamo questo punto di vista in quanto, a nostro avviso, la sua influenza va misurata soprattutto nella capacità di orientare diversi cospiratori verso posizioni moderate, facendo maturare in essi la convinzione che solo stringendosi a Casa Savoia si sarebbe giunti alla indipendenza (103) :
“Molti scritti del Manin e del Pallavicino, già pubblicati, furono rimessi a stampa in paginette di carta sottilissima, e celatamente introdotti in Lombardia, in Toscana, nei ducati di Parma e di Modena, negli Stati pontificii e nel regno delle due Sicilie, per mezzo degli amici di essi due lodati fondatori, fra i quali sono da nominare principalmente, il Franceschi, toscano, Degli-Antoni, veneto, Salazaro, napoletano. E La Farina, assunta la direzione del Piccolo Corriere d'Italia, diario della società nazionale, ne spediva migliaia di esemplari per tutta la penisola. Alle non lievi spese, nella bisogna occorrenti, provvedeva, per la più parte, il Pallavicino. La quale propaganda di civile rivoluzione fu con tenace assiduità è fervore proseguita, massime da poi che il conte di Cavour, tornato dal congresso di Parigi del 1856, fece intendere, come la diplomazia europea non potesse mutare l'ordinamento degli stati, ma, occorrendo, accetterebbe i fatti compiuti. Adunque,per giungere alla proposta méta, dovevano i popoli insorgere contro i loro governi, ed acclamare, mediante plebisciti,il re Vittorio Emanuele II. Né potevano i potentati d'Europa opporsi a ciò, avendo già riconosciuto il gran plebiscito francese che proclamò imperatore Luigi Napoleone.
Così fermato il disegno dei civili moti in Italia, fu prima la Società nazionale a porlo in atto. Ancora il Pallavicino efficacemente concorse al dissolvimento dei quattro reggimenti svizzeri del re Borbone di Napoli, mediante un patriottico proclama, scritto in tre lingue, tedesca, francese e italiana, e indirizzato ai figli della libera Elvezia; del quale andarono introdotte a Napoli migliaia di copie. E questo fu colpo mortale ad esso re.”
Nel testo riportato si cita il concorso di Pallavicino al dissolvimento dei reggimenti svizzeri, anche Manin con diversi interventi su giornali esteri (104) collaborò a creare un clima ostile alla loro permanenza a Napoli. Riportiamo alcune rughe di una lettera inviata “le 18 janvier 1857” al giornale La Patrie:
“MONSIEUR,
C'est avec regret que je vous adresse cette lettre. Il n'est pas dans mes habitudes de faire de la polémique avec les journaux. Mais la question des mercenaires suisses me paraît si importante pour l'Italie, que je crois devoir saisir cette occasion pour rétablir des faits peu ou mal connus.”
Dopo gli avvenimenti politici del 1820 Francesco Primo aveva stabilito che quattro Reggimenti Svizzeri fossero arruolati al Real Servizio. Questo avvenne in forza di Capitolazioni militari stipulate coi Governi Cantonali. Nel 1859 la Svizzera colse l’occasione della dipartita di Ferdinando II per vietare ai propri cittadini di arruolarsi per servire Francesco II, nuovo re di Napoli (105) :
“Nel 1859 ebbe luogo l'abolizione definitiva del reclutamento mercenario che durava da secoli in Isvizzera. All'assunzione al trono del nuovo re di Napoli, Francesco II, il consiglio federale vietò ai cinque reggimenti svizzeri che stavano al servizio di quella Corte di rinnovare l'ingaggio. Invano il consigliere colonnello Ziegler e Segesser di Lucerna si opposero con eloquenti discorsi a questa deliberazione; i reggimenti svizzeri in Napoli furono sciolti e i soldati, tranne alcuni pochi, fecero ritorno in patria.”
***
Esula da questo testo una analisi di quel decennio orribile (106) che precedette lo sbarco dei mille a Marsala. Indichiamo alcuni dei principali avvenimenti che rappresentano bene il clima di quegli anni. Un clima che mise alle corde il regno di Napoli e ne condizionò la sorte, stretto com’era fra gli interessi contrapposti delle maggiori potenze dell’epoca ovvero Francia e Inghilterra:
1851 – Pubblicazione e diffusione delle lettere di Gladstone, alla cui stesura collaborò anche Giacomo Lacaita, futuro Sir James Lacaita e futuro Senatore del Regno d’Italia nel 1878. Di queste lettere, distribuite alle cancellerie europee, abbiamo contate almeno quattordici differenti edizioni (107) .
1853 – Il barone Francesco Bentivegna da Corleone riunì dei banditi, e tentò un colpo di mano sopra Palermo. Scoperto, venne arrestato, ma subito graziato e messo in libertà.
1854 – De Lesseps presentò al viceré Mohammed-Saïd-Pascià una memoria in cui si concretizzava il progetto del taglio dell'Istmo di Suez (108) .
1855 – Con la guerra di Crimea presero corpo le mene murattiste e nel settembre del 1855, Murat pose apertamente la sua candidatura per il regno di Napoli, incontrando, in Ginevra, Luigi Mezzacapo, Giovanni Andrea Romeo e Francesco Stocco; a Parigi e a Torino si dava per certa la restaurazione murattiana; crescevano le dispute fra gli esuli sull'opportunità di secondare l’ambizione francese (109) .
1855 – Piano per la fuga di Luigi Settembrini dal carcere di Santo Stefano, preparato da Bertani insieme a Panizzi, redatto su schizzo di Settembrini e rotta tracciata dallo stesso Garibaldi, piano che non ebbe fortuna (110) .
1855 – Il direttore della polizia di Napoli, Mazza, nell’agosto del 1855, invitò Fagan a lasciare la Loggia dei direttori al teatro Del Fondo. Una norma vietava a estranei l’ingresso nei palchi dei direttori del teatro, se non per motivi di lavoro o servizio (111) .
1855-1856 – Partecipazione alla guerra di Crimea (112) di un contingente sardo-piemontese – La questione italiana al Congresso di Parigi – “Malgrado le proteste austriache, Lord Clarendon, con l’accordo della presidenza francese, appoggerà la richiesta di dedicare un’intera giornata ai problemi della Penisola: martedì 8 aprile 1856 il conte di Cavour è il protagonista della Sessione italiana del Congresso di Parigi; e lì ha l’abilità di presentare il problema italiano come grande questione di ordine pubblico internazionale, da risolvere al più presto per evitare il caos in Europa.” (113) – Ne seguì l’isolamento diplomatico del Regno delle Due Sicilie (114) .
1856 – Il 13 agosto Cavour si vide con Garibaldi, incontro post-datato dal La Farina di ben due anni! (115) Il successivo 12 settembre incontrò il messinese Giuseppe La Farina. A convincere Garibaldi ad incontrare Cavour era stato l’amico massone Eleuterio Felice Foresti (116) , sbarcato nel porto della città ligure il 17 giugno, proveniente dagli Stati Uniti, paese di cui sarebbe divenuto console a Genova nel 1858.
1856 – Bentivegna tentò di organizzare un’altra rivolta, bruciò archivii pubblici, vuotò le casse dello Stato e dei Comuni. Inseguiti dalle Regie truppe, i rivoltosi furono presi, un Consiglio di guerra li condannò alla fucilazione, che fu eseguita solo per il barone e per un altro capo.
1856 – Parecchi emigrati tornarono in patria per concessione sovrana: tra gli altri il medico Vincenzo Lanza che aveva presieduto la riunione preparatoria dei deputati in Monteoliveto il 15 maggio 1848, l'ex deputato Amodio, il Giannattasio e Liborio Romano. Il De Sivo cita, fra coloro che nel 1856 ebbero facoltà di tornare in patria, lo stesso Pisacane che non volle profittare del permesso (117) .
1856 (8 dicembre) – Agesilao Milano attenta alla vita di Ferdinando II.
1856 (17 dicembre) – Scoppio della polveriera al molo militare avanti la reggia, distruggendo la batteria, uccidendo e ferendo alcuni soldati e ufficiali di guardia.
1857 (4 gennaio) – Esplosione della fregata fregata “Carlo III” (118) , pronta per salpare per la Sicilia, carica di soldati e di munizioni. Diversi membri dell’equipaggio furono salvati dalla pirocorvetta inglese Malacca, che peraltro era sospettata d’aver venduto polvere da guerra nella rada di Napoli.
1857 (25 giugno) – Carlo Pisacane, con 22 compagni, si imbarca sul Cagliari, si impadronisce del piroscafo, sbarca a Ponza il 27 giugno, libera 323 detenuti (119) , poi punta su Sapri, dove sbarca il 29 giugno. Gl'insorti “furono disfatti a Padula e massacrati a Sanza, ed i superstiti furono imprigionati e condannati a Salerno” scrive Michele Lacava (120) .
Padula – Certosa di San Lorenzo |
1857
LA SPEDIZIONE DI SAPRI
Il “romito di Albaro” nei sette anni che trascorse in Genova non abbandonò mai l’idea di una spedizione nel regno delle due Sicilie, prova ne sia una lettera a Musolino (121) , datata “Genova, 8 settembre 1854”, nella quale scriveva:
«Appena è giunto a Torino il generale Inglese, una quantità di uffiziali della passata rivoluzione hanno domandato di essere ammessi nella legione. Il nostro partito, com’era naturale, riprovò quest’indegno procedere trattandoli da mercenari, la stampa liberale ha gridato e ha fortemente protestato contro un simile mercato. Nomi conosciuti non ve n’è che un solo Ribotti del quale, credo, voi non avete buona opinione; Zambeccari, è in Torino quasi cieco quindi non è possibile che gli sia venuto in mente di ascriversi gli altri son quasi tutti quelli che si trovavano nel famoso corpo comandato da Ribotti, che disgraziatamente sbarcò in Calabria. Vedete che tali elementi non sarebbero ottimi, ma forse potrebbesi lavorare con qualche speranza, ma l’Inglese a costoro li ha scartati la maggior parte, ha ritenuto il solo Ribotti, e poi preferisce gli uffiziali Piemontesi, che trovandosi in disponibilità o giubilati, per amor di guadagno, si fanno ascrivere, e chi non è animato da altro sentimento che quello di vendersi per trovarsi alla fine della campagna un peculio, credete che sia possibile trarlo ad una risoluzione ardita e generosa?
[…] «Io martedì 11 del corrente mese ne scriverò a Nicola Fabrizi che trovasi a Malta, di cui voi conoscete la fede, l’operosità e l’abilità in simile negozio, son persuaso che farà quanto può, egli è uomo da dedicarsi completamente a ciò, se ne spera la possibilità, anzi forse senza aspettare l’imbarco della legione potrebbe forse ottenersi anche prima, che un drappello di essi facesse qualche tentativo.
«Il numero, a mio parere, non è cosa importante, esso dovrebbe essere tale da sostenersi nei primi istanti, e da compiere un colpo che menasse rumore, se il paese sollevasi a questo impulso la causa è vinta, se il paese rimane indifferente spettatore allora saremmo vinti sempre a meno che non disponessimo di un piccolo esercito. E per le ragioni medesime il punto di sbarco dovrebbe essere conforme alla ragione rivoluzionaria più che di guerra; il primo problema che dobbiamo risolvere sarebbe quello di far massa, il secondo di dirigere queste in modo di assicurarci la vittoria.».
***
Alcuni eventi – attentato di Agesilao, rivolte di Bentivegna, scoppio della Carlo III, eventualità di una spedizione muratista, in preparazione a Marsiglia (122) – convinsero Pisacane che la situazione fosse propizia ad un colpo di mano che fungesse da miccia per incendiare il regno di Napoli.
Leggiamo nel testo di Alessandro di Lorenzo (123) :
«Il Pisacane, incoraggiato da questi ultimi avvenimenti e, soprattutto, spinto dal principale agente di Mazzini a Napoli, Giuseppe Fanelli, intuisce che il fuoco della rivoluzione è maturo e che basta una semplice scintilla per appiccarlo. Il piano architettato con il Fanelli prevedeva la liberazione dei prigionieri politici detenuti sull’isola di Ponza, per poi continuare il viaggio con essi fino ad una zona a sud di Napoli. Il 16 aprile, il Fanelli scrive al Mazzini a Londra che gli occorrono almeno altre sei settimane di tempo per stabilire una relazione sull'isola di Ponza. La data della rivoluzione viene fissata prima per il 25 maggio, poi per il 10 giugno.»
Nella prefazione al poemetto di Eliodoro Lombardi Francesco dall’Ongaro scrisse (124) :
“L'audace impresa fu maturata in Albaro nella riviera ligure. Sappiamo che Pisacane, non fidandosi delle informazioni che riceveva dal Regno, vi si recasse in persona, travestito da prete, per vedere cogli occhi propri e udire coi propri orecchi lo stato degli animi e l'opportunità della spedizione. Ma il proscritto non vede e non ode sempre la verità, e il popolo è così fatto, che muta proposito da un giorno all'altro, massime quando si tratta d'insorgere contro le superstizioni inveterate e le catene ribadite da secoli. L'impresa fu tentata.”
Più o meno dello stesso parere Palamenghi-Crispi, che scrisse (125) :
“È fuor di dubbio che Carlo Pisacane non ebbe incoraggiamento di sorta da' patriotti dell’interno alla sua disperata impresa. Avvenne con lui nel 1857 quello che era accaduto nel 1844 coi fratelli Bandiera, cioè quello ch’è fatale avvenga quando ad una congiura partecipano temperamenti capaci di esaltarsi e di perdere quindi la visione esatta della realtà.”
***
Ovviamente, appresso, ne “IL PREZZO DELLA REDENZIONE”, evidenzieremo la nostra posizione sul disastro di Sapri. Per ora riteniamo necessario ragguagliare il lettore in merito al dirottamento del Cagliari, piroscafo a vapore della Compagna Rubattino.
IL CAGLIARI E LA COMPAGNIA RUBATTINO
|
1858 THE ILLUSTRATION - Il Cagliari |
Raffaele Rubattino era iscritto alla Giovine Italia (126) , la vulgata del dirottamento del Cagliari è una delle favole patriottarde per ingentilire gli interessi che si muovevano dietro il romanticismo dei cospiratori. Una commedia, come la definisce Edoardo Vitale (127) , che si replicherà nel 1860 col finto assalto di Nino Bixio ai due vapori Piemonte e Lombardo:
“Pisacane infatti ha già contattato la Rubattino, favorito dal fatto che a Napoli ne era rappresentante Carlo Di Lorenzo, padre della sua amata. Si raggiunge un accordo nel senso che a Pisacane sarà consegnato il piroscafo Cagliari, a condizione che la società di navigazione non ne risulti compromessa. Si pongono le basi per la commedia che si consumerà a bordo del natante, stucchevole precedente di quella, analoga, che si replicherà nel maggio 1860 sul Piemonte e sul Lombardo.”
|
La spedizione – da Ponza a Sapri |
Probabilmente è lo stesso Rubattino (come avverrà nel 1860) ad accordasi con Mazzini e Pisacane per l’utilizzo del Cagliari. La tesi, sostenuta per la prima volta dal Codignola nel Rubattino ((128) ), fu confutata da Aldo Romano, studioso dell’epistolario del Pisacane, perchè si basava sul metodo indiziario.
Dalle carte del processo di Salerno sarebbe poi emerso che la Rubattino fosse coinvolta in un traffico di armi (129) . Ovviamente essendo essa una benemerita della patria, per aver dato il Lombardo e il Piemonte al Garibaldi (130) , le seguenti righe non vengono prese in considerazione dagli storici patrii:
“Sorgono dagli atti compilati, gravi argomenti per ritenere che la Società di vapori sardi, sotto la ditta R. Rubattino e Compagni, fosse stata da più tempo in concerto co' macchinatori settarii per far trasportare nei reali dominii armi ed armati, e fin da dicembre 1856 sospettavasi che avrebbe assentito di dare a nolo uno de' piroscafi a' congiurati, onde in qualche momento opportuno fossero stati alla portata di sbarcare sul lido di Sicilia più favorevole al passaggio a Palermo.
Certo si è che da qualche mese prima del 25 giugno, il piroscafo Cagliari servi di mezzo di trasporto di varie casse d'armi da Genova, con la direzione per Tunisi, e si aveva a temere, che lungo la rotta, le armi fossero state trasbordate, e depositate in qualche suolo convenuto, per essere quivi levate pe' dominii di S. M. il Re (N. S.), specialmente lorchè il vapore francese Provence, proveniente da Marsiglia, nel 24 maggio trasbordò nel porto di Genova sul Cagliari 12 casse marcate C. E. contenenti 300 fucili di munizioni e 100 pistole.
I sospetti crescevano, quando osservavasi che la spedizione delle armi con polizze all'ordine, val dire senza indicazione degl'immittenti, né dei destinatarii, per non rivelarsi, in tempo appunto dai rivoluzionari Carlo Pisacane, Rosolino Pilo e qualche altro vedevansi in moto. Non per tanto, per una di dette spedizioni, si potè conoscere quali erano gl'immittenti (caricatori) di Genova, e di 57 casse di armi, una racchiudente lame di sciabole spedivasi direttamente da Rubattino.”
La tesi dell’accordo trova spazio anche nel recente libro sulla storia dei servizi segreti di Mirko Molteni (131) :
“La partenza della spedizione di Pisacane da Genova, la sera del 25 giugno 1857, venne inscenata come un banale sequestro del piroscafo Cagliari, con minacce a mano armata nei confronti del capitano del vascello, Antioco Sitzia, e dei suoi marinai. In realtà era tutta una sceneggiata concordata con Raffaele Rubattino poiché l’equipaggio si arrese subito, senza nemmeno abbozzare una resistenza, a Pisacane e ai suoi 22 compagni. Per di più, guarda caso, i cospiratori ebbero la “fortuna” di trovare nella stiva della nave un carico di 60 fucili e relative munizioni.”
***
Interessante anche il ragionamento di Cristina Contilli (132) , basato sullo studio dei cifrari utilizzati da Pisacane (133) e dagli altri cospiratori:
Per esempio nella frase: "prendere col danaro 104 al 166 il quale fa il suo giro con un pretesto commerciale per poi nel corso del cammino al momento opportuno staccarsi, correre al punto del deposito ed andare al punto che ci indicherete" Se il 104 è il vapore ed è chiaro dal senso della frase il 166 che non è stato decifrato anche se era abbastanza facile è Rubattino la compagnia di navigazione che fornirà nel 1860 anche i due vapori a Garibaldi per l'impresa dei Mille...
***
In effetti dai carteggi emerge che già diversi mesi prima si parlava di utilizzare uno o due vapori per l’impresa e pensare che ci si riferisse a vapori di linea per attuare una cospirazione è da ingenui.
Per il racconto dei preparativi della spedizione ci affidiamo ad un testo di Giuseppe Pupino-Carbonelli pubblicato nel 1889 (134) :
“I casi avvenuti, il fermento della popolazione, la cospirazione estesa nelle provincie, gli arditi disegni, le speranze, tutto era dal Fanelli riferito al Mignogna, il quale col comitato d’azione genovese preparava un colpo maestro su le coste meridionali.
Giunse in Genova di soppiatto Mazzini. La sera del 4 giugno ’57 si tenne segreta adunanza, nella quale, fra gli altri emigrati, intervennero Rosalino Pilo, Pisacane, Cosenz, Nicotera, Castelli, Carbonelli. Né vi poteva mancare Nicola Mignogna, nelle cui mani si raggruppavano i fili della trama insurrezionale fra Napoli, Salerno e Potenza, ordita dal Fanelli, Pateras, barone Galletti, Albini e compagni.
All’ora designata, un lieve picchio all’uscio annunziò la presenza del fatidico Maestro! — Giuseppe Mazzini, chiuso in un lungo pastrano scuro, col cappello a cencio, il volto sereno del giusto, apparve fra’ cospiratori italiani sfolgorante da’ suoi luminosi occhioni che parevano sprofondarsi nell'infinito. Egli volle stringere a tutti la mano, e quando gli fu indicato il Mignogna, l’accolse in un tenero amplesso, gli disse che già lo amava, lo appellò fratello, lo irradiò di quel suo divino sorriso, la cui virtù non può intendere chi non l’ha mai provata.
Mazzini ora venuto da Londra, dove gli amici Stansfeld e Taylor l’aveano fornito di un gruzzolo di 50 mila lire. Era venuto perchè chiamato — non perchè vedova chiaro nella spedizione organizzata dal Carlo Pisacane, il coraggioso emigrato ufficiale borbonico. — Dalla corrispondenza col comitato di Napoli appariva, è vero, che gli animi erano disposti a seguire l’impresa, ma dall’essere disposti all’essere pronti ci corre, dacché fino a quel punto, essendo mancati i danari, a ben pochi preparativi si era potuto mettere mano.
Pure il Pisacane, invaso d’amor patrio, rispose: — No: laggiù si attenta alla vita del re, si dà fuoco alle polveriere, si mandano in aria i vascelli, si cospira nell'esercito, si lotta ogni giorno con la polizia, e noi restiamo con le mani alla cintola? Laggiù ci aspettano, laggiù stanno per sorprendere il forte Sant’Elmo; né volete una pruova? ecco qua una lettera del comitato di Napoli che ci sprona: «Voi sarete come una bandiera che s’inalbera su di un monte per segnale!» — Dunque?.... Dunque, soggiunse Mazzini, partite. — E fu deciso che la notte dell'8 giugno, Rosalino Pilo ed alcuni giovani avrebbero con una barca trasportate le armi, e che il Pisacane e i suoi compagni sarebbero partiti il 10, sbarcando il 12 a Ponza, ed il 13 a Sapri.
Il Mignogna fu incaricato di partecipare al comitato di Napoli le determinazioni prese. La notte dell’8 giugno, Rosalino Pilo ed i suoi erano in mare. Lampeggiava. A poco a poco i flutti s’ingrossarono, il tuono rumoreggiò sul loro capo, si scatenò la tempesta. La barca, perduto il timone, le vele lacero, stava per andare a fondo. Unico scampo, gettare in mare il carico dello armi o avventurarsi all’ira dell'onde frementi. E così fu fatto. La barca, sbattuta sul lido di Portofino, potè guadagnare a mille stenti il porto di Genova, verso la mattina del 9.
La spedizione era bell’e svanita. Pisacane, temendo le conseguenze del contrattempo, col passaporto del Cosenz s’imbarcò alle 4 pomeridiane del 9 giugno su d’un vapore francese, e corse a Napoli, ove giunse la sera dell'11. In quella stessa sera gli venne fatto d’intendersi col Fanelli: la notte si avvertirono tutti i corrispondenti dell’incidente accaduto. Il Pisacane rimase in Napoli fino al 17; prese gli accordi urgenti per la buona riuscita del disegno, ma non indicò il giorno della partenza della spedizione da Genova. L’avrebbe indicato per telegrafo, subito che ogni ulteriore ostacolo fosse stato rimosso.”
A titolo di cronaca, giusto per dare un altro elemento che prova come a Genova, non solo i mazziniani, ma in tanti sapessero di questi tentativi.
Lo sapeva, ad esempio, il filosabaudo Pallavicino, che, per il primo tentativo di spedizione verso Ponza, forni alcune centinaia di fucili, lo leggiamo nelle brevi note “di un taccuino del Pilo pubblicate dall'illustre Prof. Alfonso Sansone nell'Esposizione di Palermo 1891-92 (Treves Editore), e dall'Avv. Emanuele Di Marco nell'opera: Rosolino Pilo precursore dei Mille in Sicilia, Catania, 1892”, riportate nell’Archivio Storico Siciliano nel 1899 (135) :
“Il 6 Giugno 1857 alle ore 8 e tre quarti p. m. lasciai con l'amico Pisani Genova con grandissimo dolore. Abbracciai prima i fratelli Orlando, Mustica, Errante, Terasona, Kirkiner, Bertolami, indi Cianciolo, che trovai presso il caffè della lega Italiana e Pisacane con la sua signora Enrichetta. Alle 9 ore con Giacomo Profumo in carrozza ci portammo a Rivarolo.
Verso le 10 p. m. entrammo in una villa, dove entrarono una ventina d'operai, Angelo Mangini, Conti ed altro Genovese; ed alle 12 e 20 minuti imbarcammo 250 fucili e carabine con munizione corrispondente (quelle che s'erano avute dal Deputato Giorgio Pallavicino, s'imbarcarono 250 daghe e munizione molta e vari utensili, come zappe, pali, casse con mina e corda miccia). Angelo Mangini mi donò per sua memoria un pugnale con manico bianco; altro me lo donò Cianciolo prima di la-sciarmi in casa sua. Angelo Mangini e Profumo vennero in barca fino al bordo, lo schooner (?) lo trovammo alle due ore dopo la mezzanotte allo aggiornare del 7.”
In quelle note di Pilo si citano anche gli Orlando (136) , imprenditori di origine palermitana, poco citati nei libri di storia ma partecipi a molti degli avvenimenti del decennio che precedette la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861. Parteciparono con armi e denaro sia alla spedizione di Sapri di Pisacane che alla spedizione in Sicilia di Garibaldi.
***
Una sintetica descrizione della spedizione del 25 giugno e del suo epilogo tragico, la troviamo nella MEMORIA letta da Lacava, nella tornata del 2 giugno 1895 della Accademia Pontaniana (137) :
“L'idea di dare incentivo alla rivoluzione con approdi di armati sulla costa di Sapri, era da lungo tempo nella mente di Mazzini.
Verso la fine del 1856, Mazzini si recò a Genova e convenne con Pisacane che la spedizione si sarebbe fatta nell'anno seguente.
E nel 1857 più volte si stabili il giorno in cui la spedizione di Sapri avrebbe dovuto effettuarsi: primieramente fu fissata dai 20 ai 22 aprile: e poi dai 25 ai 27 dello stesso mese; ai 25 di maggio, ed ai 10 di giugno per approdare a Sapri il 13.Verso la fine del 1856, Mazzini si recò a Genova e convenne con Pisacane che la spedizione si sarebbe fatta nell'anno seguente.
E nel 1857 più volte si stabili il giorno in cui la spedizione di Sapri avrebbe dovuto effettuarsi: primieramente fu fissata dai 20 ai 22 aprile: e poi dai 25 ai 27 dello stesso mese; ai 25 di maggio, ed ai 10 di giugno per approdare a Sapri il 13.
Mazzini teneva molto che questa spedizione si fosse presto eseguita, sia per distruggere le mene murattiane che facevano capo a Marsiglia, e sia per coordinare questa spedizione ai moti che dovevano succedere in Genova, in Livorno, nell'Ungheria, in Francia, in Ispagna.
Il disegno di Pisacane consisteva nello sbarcare a Sapri, rivolgersi al Vallo di Teggiano, ed ivi accogliere gl'iusorti del Circondario di Lagonegro, del Vallo di Teggiano e di quella parte della provincia di Basilicata contigua a questi luoghi; procedere verso Auletta, ove sarebbe stato raggiunto dal rimanente degli insorti della Basilicata; ed inoltrarsi fino ad Eboli, nel qual luogo si sarebbe unito coi Cilentani e cogli Avellinesi. Costituito un forte nerbo d'insorti, muovere alla volta di Napoli e dar mano alla rivoluzione in questa città, preparata per opera del Comitato.
Il Comitato di Napoli se stimava pronte alla rivoluzione le provincie, e tra queste primissima la Basilicata, non riteneva però pronta la rivoluzione in Napoli per mancanza di mezzi e di armi.
Ma Mazzini e Pisacane, odiando gl'indugi, si imposero.
Tutto fu disposto per lo sbarco in Sapri nel giorno 13 giugno, ed un gruppo di patrioti doveva imbarcarsi sul Cagliari, piroscafo della compagnia Rubattino, per riunirsi a Portofino con una banda armata che già li aveva preceduti di tre giorni; ma questa spedizione andò a monte, quando si seppe che gl'imbarcati di Portofino per violenta tempesta sopraggiunta la notte, erano stati costretti a gettare in mare armi e munizioni, e tornare indietro.
La spedizione ebbe luogo dal porto di Genova il giorno 25 di giugno nelle ore 4 p. m. sul vapore il Cagliari, diretto per la Sardegna, comandato dal capitano Sitzia.
Quello che avvenne, è a tutti noto; ed io ebbi l'onore, due anni dietro, di conferire in questa Accademia sui medesimi fatti. Questa spedizione fece capo ad un disastro completo; gl'insorti furono disfatti a Padula e massacrati a Sanza, ed i superstiti furono imprigionati e condannati a Salerno. Cause principalissime di tanto disastro furono due: una quella di credere preparata la rivoluzione nel Salernitano; e l'altra di non avere avvertito a tempo la Basilicata che era prontissima ad insorgere. Un errore strategico commise il Pisacane e fu quello di volgersi nel Cilento e non scavalcare l'Appennino e gittarsi in Basilicata, quando vide mancare i promessi soccorsi di Padula ed altri paesi.
Perché dar di cozzo alle truppe regie in condizioni di disparità di numero, di armi e di disciplina? Dal Fortino poteva rivolgersi verso Moliterno, passando l'Appennino; ed una volta in Basilicata, trovava monti fatti per le guerriglie e la patriottica ospitalità Lucana; e più di tutto 2000 giovani entusiasti, ed una mente molto capace, quella di Giacinto Albini.
Sul finale risultato di questa rivoluzione, non possiamo né dobbiamo illuderci dopo molta resistenza gl'insorti avrebbero dovuto battere ritirata, onoratissima per altro, perchè avrebbero potuto o capitolare o pure trovar modo di emigrare, non dico tutti, ma almeno i capi. Non approda va a cosa alcuna, massime per l'indeterminatezza della rivoluzione, che dal semplice concetto di dire: Viva l'Italia, non si conosceva se si voleva Repubblica o Monarchia, e le rivoluzioni dovevano avere uno scopo determinato e definito, come fu la rivoluzione del 1860. Nelle idee del Mazzini stava la Repubblica; ma questo nome, non dobbiamo farci illusione, suonava male nei nostri luoghi. La sola rivoluzione possibile sarebbe stata quella o di chiedere energicamente la costituzione, o pure innalzare la gloriosa bandiera Sabauda, e forse cosi anticipare di 3 anni l'unificazione, l'indipendenza e la libertà della patria.”
A chiosa di quanto scritto da La Cava possiamo aggiungere che secondo altri Pisacane avrebbe dovuto buttarsi verso le Calabrie (138) , dove ci sarebbe stata una situazione più favorevole che in Basilicata. Tutte ipotesi che si infrangono contro la realtà storica. La “terra dei tristi” era nota per la insofferenza anti-borbonica, ma per beneficiare di una rete cospirativa occorrono denaro, armi e uomini. Nel 1860 Garibaldi avrebbe avuto non solo denaro, armi e uomini (139) ma anche l’aiuto dell’Inghilterra (140) e degli Stati Uniti (141) , che cercavano di contrastare cosi l’appoggio francese nella annessione del centro-nord della penisola italica al regno sardo-piemontese.
A volte delle banali verità invece che nei libri di storici illustri si rinvengono in sconosciuti testi oppure in opere letterarie, come in un poco noto dialogo di Leopoldo Perez De Vera (Dialogo III), di cui riportiamo alcune battute (142) :
|
PRINCIPALI LUOGHI DELLA SPEDIZIONE – Sapri, Padula, Sanza. |
“S. BEP. – Vel dichiarerò per via di esempi. Come si spiega, che nel 1857 il prode ed infelice Pisacane, sbarcando a Sapri con pochi ardimentosi, levò un grido di rivolta, a cui nessun eco rispose, e invece poco dopo nel 1860 Garibaldi sbarcando a Marsala, ne levò un altro, che valse alenargli dietro nove milioni di persone? CARL. – Oh per diancine! si spiega subito. Pisacane fu tradito, e Garibaldi no. Pisacane non ebbe aiuto dal Piemonte, come ebbe Garibaldi. Per Pisacane non vi fu corruzione dei regi, non comitati intestini, non danaro sonante, come vi fu per Garibaldi; e quindi... “ |
La differente accoglienza, riservata a Garibaldi rispetto a Pisacane, emerge anche in un breve passaggio della critica di Bertani all’epistolario di La Farina pubblicato da Ausonio Franchi (143) :
Giunti salendo ad un piccolo gruppo di case che si chiama Fortino e si trova sulla strada che da Lagonegro per Casalnuovo mette a Sala, vi trovammo alcuni amici politici inviati dalle provincie vicine che venivano a dare informazioni ed aiuti al generale Garibaldi.
I lucani riserveranno a Garibaldi accoglienza diversa anche sul piano finanziario, lo racconta Giuseppe Pupino-Carbonelli (144) :
"Il 5 settembre Garibaldi giunge a Casalnuovo, confine tra la Calabria o la Basilicata. Ivi Nicola Mignogna, in nome della provincia, gli dà il benvenuto; presentandogli l’offerta pecuniaria de' Lucani.”
***
La bufala dei mille garibaldini che scompaginarono centomila soldati napolitani, grazie alle doti miracolistiche del Garibaldi-Nazareno, ha sempre trovato – e continua a trovare – sostenitori di livello. Ne ricordiamo uno per tutti, il Discorso pronunciato nel Politeama Garibaldi di Palermo da Francesco Crispi il 27 maggio 1885 (145) .
IL PREZZO ANTICIPATO DELLA REDENZIONE
|
Morte di Pisacane |
La tragica vicenda di Pisacane si compì il 2 luglio 1857 – sulla sua fine circolarono (e circolano tuttora) varie versioni, dal suicidio per non cadere nelle mani degli odiati borbonici (tesi in linea con l’eroe romantico) alla fucilazione sul posto (tesi riportata in pochissimi testi), al massacro da parte di contadini fanatizzati e ignoranti (146) .
Il disastro di Sapri si agitò nella magmatica sinistra italiana per anni, qualcuno lo ha definito il “prezzo anticipato della Redenzione” (147) . Di sicuro divenne motivo di scontro fra chi addebitava a Mazzini e allo stesso Pisacane una incapacità di lettura della situazione reale del Regno di Napoli e chi, invece, imputava il disastro alla inanità dei moderati e del Comitato Napoletano. Scrive Massimo Nardini (148) :
“uno degli elementi che emerge sempre con forza è quello relativo alle scarse informazioni in possesso del protagonista sulla situazione del Mezzogiorno: egli, autore di studi politico-militari, come molti altri pensatori dell'epoca, riteneva che il Regno delle Due Sicilie fosse un territorio pronto ad insorgere, dimostrandosi così all'oscuro di quella che viene definita come la “questione sociale”. La complessa problematica propria della società del Sud e le consuetudini che regolavano i rapporti tra braccianti e proprietari terrieri, profondamente diverse da quelle della penisola centro-settentrionale, rimasero sempre un elemento difficile da comprendere per chi si trovava a vivere all'esterno di tale realtà.
Pisacane aveva dunque già valutato la possibilità di effettuare uno sbarco prima della rivolta di Francesco Bentivegna, avvenuta in Sicilia il 30 novembre 1856, e dell'attentato operato da Agesilao Milano l'8 dicembre dello stesso anno a Napoli.”
***
Al di là di quali possano essere le convinzioni personali di ognuno di noi, un dato è certo: nella vicenda di Pisacane si intrecciarono questioni personali e spinte ideali, Noi vogliamo sottolineare alcuni elementi che ci hanno particolarmente colpito:
1) Il progetto di uno sbarco nel Regno delle Due Sicilie - fin dal 1854 se ne occuparono Cosenz, Musolino, Garibaldi, Cavour – l’unico sbarco guidato da un napolitano – seppur antiborbonico – fu quello di Pisacane ma le reti cospiratorie restarono a guardare. Tre tre anni dopo le stesse reti sarebbero intervenute con uomini ed armi in soccorso dell'eroe dei due mondi – aiutato, checché ne dicano i patriottardi, dalla perfida albione, che non poteva permettere alla Francia di monopolizzare la unificazione di uno stato al centro del Mediterraneo. (149)
2) l’incontro fra Cavour e Garibaldi, avvenuto nell’agosto 1856 e non due anni dopo come ebbe a scrivere La Farina.
3) I rapporti con l’amata Enrichetta (150) , col fratello Filippo (151) e con l’amico Cosenz, compagno di studi militari alla Nunziatella.
4) Il ruolo del napoletano Fanelli, combattente a Milano come artigliere, quindi con Mazzini nella Repubblica romana, dove conobbe anche Nicola Fabrizi, antico cospiratore, col quale raggiunse Malta;
5) Il ruolo del modenese Nicola Fabrizj dal suo esilio a Malta, controllata dagli inglesi.
6) L’assenza della Lucania da cui dovevano giungere gli aiuti promessi da Giacinto Albini.
7) Il non intervento della polizia a Genova, dove tutti sapevano tutto, compreso Rattazzi, ma lasciarono che la spedizione partisse (152) , come rivelarono i Francesi a cose fatte (153) .
8) Lo scambio di accuse e lo scontro (anche fisico!) tra Fanelli e Nicotera dopo il disastro di Sapri (154)
9) Il rapporto tra Carlo Pisacane e Benedetto Musolino, fratello della madre di Nicotera.
10) La vicenda del sequestro del Cagliari, un vero e proprio affaire che coinvolse direttamente tre stati: Regno di Napoli (155) , Regno Sardo e la perfida Albione. (156)
***
A cose fatte ognuno aveva la sua ricetta per evitare il tragico epilogo di Sanza (157) . Cominciamo dal Fanelli (alias Kilburn) e da Albini.
Il Fanelli, rientrato a Napoli nell’estate del 1853, con l'arresto del Mignogna nel luglio del 1855, si ritrovò nelle mani tutta la responsabilità del Comitato segreto, “un impegno, soprattutto psicologico, al quale forse non era preparato” secondo quanto scrive il Monsagrati (158) . Di sicuro gli mancò la determinazione di ostacolare la partenza. Eppure dalle sue lettere a Pisacane – nei mesi di febbraio, marzo e aprile – si evince con chiarezza (159) che la situazione dei possibili aiuti (in uomini armi e denari) non fosse molto favorevole, anche per arresti operati dalla vigile polizia borbonica. Pressato dalla insistenza di Pisacane (160) e dalle richieste di Mazzini di assecondarlo e di fornirgli relazione su Ponza (161) , lasciò che venisse effettuata la spedizione, organizzata su “progetto” del teggianese Giovanni Matina (futuro colonnello e prodittatore, in Sala Consilina, a fine agosto 1860).
Nella lettera a Pisacane, datata Napoli 10 febbraio 1857, sembrava che in Basilicata vi fossero dei gruppi lucani potenzialmente disponibili ad appoggiare una eventuale rivolta, ma quando arriva Pisacane non si vede nessuno (162) . Nell'opera scritta da Decio Albini, figlio del “Mazini lucano” (cosi Crispi definì Giacinto Albini) si fa una difesa d’ufficio dei lucani e di suo padre Giacinto, citando anche il Racioppi (163) , lucano anch’esso:
«La Basilicata, dunque, nella impresa di Sapri aveva un compito importantissimo e furono circostanze estranee ad essa se questo compito non potè mantenere integralmente.»
Su Albini non possiamo ignorare quanto sostiene Tommaso Pedio, secondo il quale non era iscritto alla Giovine Italia e si trovava in carcere, quindi non in grado di promettere alcunché. Nello studio del dottorando Domenico Morlino (164) si sostiene che dalla consultazione di vari archivi emergerebbe che Albini non fosse in carcere al momento della spedizione di Pisacane:
«Giacinto Albini aveva subito una perquisizione e un mandato d’arresto perché era uno dei destinatari della corrispondenza che preparava la spedizione. Secondo Pedio, invece, Albini non avrebbe mai ricevuto questa corrispondenza.
In conclusione: la documentazione su cui lavorava lo storico Racioppi era vera e non falsa; in Basilicata dopo il 1856 esisteva realmente una setta unitaria, contrariamente a quanto sostiene Pedio, e i suoi membri avevano realmente partecipato alla cospirazione per la spedizione di Sapri.
Se le prove archivistiche qui presentate non bastassero, l’archivio di Potenza ne fornisce anche altre, di cui parleremo diffusamente perché riguardano la vita e la figura del nostro Giacomo Racioppi.»
Con una lettera, datata “Napoli il 26 Aprile 1857”, il comitato chiedeva a Giacinto Albini di tenersi pronto perché stava per giungere il momento dell’azione (165) :
“Ragioni estere ed interne potranno da un giorno all'altro farvi avvisare che l'ora è giunta. Voi tenetevi pronto ad iniziare, perchè la vostra provincia è meglio piazzata che le altre per dare impulso e sostenersi. Noi vi manderemo i capi militari. Se nel momento supremo si crederà più atta ad iniziare altra provincia, cominceremo da dovesi crederà opportuno, e se altri appoggi potremo darvi, lo faremo; ma voi preparatevi per l'iniziativa e state prontissimi. Gli eventi e le cose sono apparecchiate, e sempre più si apparecchiano per modo che la vittoria dev'essere nostra. L'opinione pubblica in Inghilterra è per noi agitatissima, in Francia vi regna il più gran malcontento.”
***
Anche da alcune lettere criptate, della primavera del 1857, di Fanelli a Pisacane, emerge che in Basilicata si potesse contare su squadre di uomini armati pronti all’azione. D’altronde se non fosse stato cosi non si spiegherebbe come mai già nel giugno 1860 dava inizio (“Chi più può, più faccia”) ad una agitazione che avrebbe portato alla insurrezione dell’agosto 1860. Appena tre anni dopo il fallimento di Pisacane, la rete cospirativa Lucania insorgeva, senza aspettare l’arrivo del nizzardo (166) :
È da premettere ancora che fin dall'aprile del 1860 il latitante Giacinto Albini di Basilicata aveva preparato il terreno, mettendo d'accordo i diversi Comitati sub-centrali.
[...] Si era tenuta appena la prima Assemblea del novello Comitato, quand'ecco il 16 agosto perviene un ordine da Napoli del segretario del Comitato Carlo Senise di tener pronti per il 18 agosto i 200 uomini armati dal Comitato offerti nella seduta del 17 luglio in Gioia per muovere verso Potenza, tenendo per Genzano. In pari tempo Nicola Mancusi scriveva da Avigliano che, dovendosi alle ore 19 del giorno 18 piombare su Potenza, bisognava che il contingente Barese si trovasse al confine della Provincia, ove sarebbe rilevato da un drappello della colonna lucana.
Frattanto il 17 agosto il Colonnello Capo dell'insurrezione mise fuori un proclama, con cui avvisava d'essere incominciato il moto insurrezionale di Corleto e che egli alla testa di cinque in sei mila uomini, oltre a quelli che avrebbe raccolto per via e dai paesi circonvicini, marcerebbe su Potenza, ove avrebbe istallato un Governo provvisorio, il quale pronunziar doveva l'annessione al Regno d'Italia sotto lo scettro di Vittorio Emmanuele. Il tutto di pieno accordo con Garibaldi.
Il 18 agosto 1860, in Potenza, gli insorti si scontravano con la guarnigione (composta di 400 gendarmi) e il giorno seguente si proclamava il governo provvisorio, con Pro-Dittatori Nicola Mignogna e G. Albini, ai quali il 31 agosto veniva consegnato il telegramma di Garibaldi (167) :
«Restate fermi ed organizzate la nostra rivoluzione; non fa bisogno venir voi all'incontro. Sarò io che verrò quando parmi fra voi. Dite al mondo che ieri con i miei prodi calabresi feci abbassare le armi a 10 mila soldati, comandati dal Generale Ghio. Il trofeo della resa fu 12 cannoni da campo, 10 mila fucili, 300 cavalli, un numero poco meno di muli ed un immenso materiale da guerra.»
La redenzione tentata inutilmente da Pisacane si stava materializzando! Anche grazie ai pali del telegrafo, che il nizzardo usava sapientemente per informare l’opinione pubblica italica ed europea delle sue gesta (168) .
LO SCONTRO NICOTERA-FANELLI
Chi diede la stura alle polemiche, contro il Fanelli e il comitato napoletano, fu Nicotera, agente di Cavour nella spedizione di Sapri. Per assolvere se stesso dalle responsabilità per il disastro di Sapri, appena liberato da Favignana (169) , rifiutò l'offerta di Garibaldi di un comando di una brigata in Calabria, andò Genova per vedervi Mazzini, poi iniziò ad attaccare Fanelli e il Comitato Napoletano per non essere intervenuti con gli aiuti promessi.
Le mancate promesse fatte al Pisacane dal Comitato Napoletano, quindi dal Fanelli (170) che ne era il responsabile, furono il perno del suo attacco, a partire dall’articolo pubblicato il 3 novembre 1860 su “Il Popolo d’Italia”. In tal modo egli conseguiva due obiettivi: a) scansare l’attenzione da sé per le polemiche sorte in merito al processo di Salerno; b) ergersi a legittimo ed unico depositario della eredità politica dello sfortunato Pisacane.
La polemica assunse toni cosi aspri da provocare una sfida a duello, che fu preparata e poi sospesa in quanto in via Toledo un Fanelli esasperato dagli attacchi aggredì a bastonate il Nicotera. Lazzaro, cognato del Fanelli, si rivolse per un intervento chiarificatore al Fabrizi, il quale preparò un opuscolo indirizzandolo a Garibaldi! (171) .
Si tratta di un documento surreale, nello stile del Fabrizi, il quale si mostrava farraginoso, inconsistente e contraddittorio sul piano scritto, assolutamente intraprendente e risoluto su quello operativo. Prova ne siano le sue capacità nello stabilire relazioni tra le varie reti cospirative, che si muovevano nella penisola e nei diversi paesi europei, vedi Francia e Inghilterra, per la formazione di uno stato nazionale. Egli risiedette vari anni a Malta, era convinto che nel sud della penisola, nel Regno delle Due Sicilie, ci fossero le condizioni per una insurrezione.
Scrive Arnold Cassola, Professore Ordinario accademico di Letteratura Maltese comparata presso l’Università di Malta (172) :
In Malta, he tried to gather weapons and munitions for the insurgents in Italy and, as from 1859, he started travelling to and from Malta on a regular basis. In 1860, together with twenty five volunteers, he crossed over to Sicily to join Garibaldi in his quest and to hand over the weapons collected in Malta. This list of twenty five includes the Maltese Giorgio Balbi and Giuseppe Camenzuli.
Aggiungiamo noi che una parte – circa 700 fucili (173) – delle armi portate il 7 giugno 1860 a Pozzallo in Sicilia, per i garibaldini, erano già nella disponibilità del Fabrizi durante la spedizione di Pisacane, il quale probabilmente fu poco accorto e non si rese conto che non tutti i cospiratori con cui era in contatto remassero a suo favore.
“Per me poi” scrive Enrichetta (174) in una lettera a Nicotera “sta che i più colpevoli sono i corrispondenti di Napoli, che ora se la vivono tranquillamente in Londra, e quei della Basilicata; ma il popolo ignorante cosa sa?”
Di quanto si fosse progettato e riprogettato in quegli anni, Enrichetta era persona sicuramente bene informata, avendo partecipato alle riunioni decisive inerenti la spedizione (175) . Secondo Laura Guidi si tratta di una figura femminile poco indagata al di fuori degli studi su Pisacane (176) :
“Uno storico autorevole come Adolfo Omodeo ritiene, ad esempio, che la crisi dell’amore romantico, in Pisacane “sbattuto e naufrago per una passione amorosa”(1) sia un’indispensabile chiave di comprensione delle sue scelte politiche. Ciò ha condotto Nello Rosselli, Aldo Romano, più recentemente Luciano Russi e tanti altri a occuparsi di lei, lasciandola però sempre sullo sfondo delle loro ricerche.
Al di fuori degli studi su Pisacane, Enrichetta è stata ignorata dagli storici. Eppure svolse un ruolo di rilievo nella Repubblica Romana, in cui, insieme a Cristina di Belgioioso e ad altre patriote, organizzò i soccorsi ai feriti. Documenti emersi di recente sembrano indicare anche una sua posizione di responsabilità nell’amministrazione finanziaria del governo repubblicano.”
***
Nel 1911, sulla rivista storica “IL RISORGIMENTO ITALIANO” vennero pubblicate, a cura di D. Rondini (177) , le Memorie di Giuseppe Daneri, scritte su un quaderno sotto sua dettatura, a detta dei congiunti.
L’estratto, che riportiamo, porterebbe acqua al mulino di chi sostiene che Pisacane sia stato fuorviato dalle rassicurazioni del Comitato di Napoli, che garantivano la presenza su territorio di uomini pronti a dargli manforte (178) :
“Pregato Mazzini a concedermi di fargli una domanda, mi rispose: «dite pure». «Che fiducia avete voi in questa spedizione? Non sarà una seconda spedizione dei fratelli Bandiera?». Ed egli: «Al punto in cui sono le cose, giudicate voi se si deve tentare o no». E mi porse diverse carte dicendo: «Queste sono le ultime corrispondenze del comitato di Napoli; sapete che oltre ciò Pisacane andò a Napoli travestito da prete e ritornò più entusiasmato che mai». Letta la corrispondenza del Comitato, risposi a Mazzini: «Se la centesima parte delle promesse ed assicurazioni che danno è vera, noi siamo colpevoli per avere aspettato tanto».”
Anche Montanelli-Cervi ritengono che Pisacane sia stato lasciato solo dalla rete cospirativa che avrebbe dovuto dare il proprio appoggio con uomini e armi (179):
Il processo non fu, per la causa patriottica, una pagina gloriosa. Nicotera rivelò tutto l’ordito della congiura, e forse fu per questo che la sua condanna a morte fu commutata nella prigione a vita, che si ridusse a tre anni perché nel ’60 fu liberato da Garibaldi. Fanelli, su cui egli scaricò tutte le responsabilità, e che si era messo in salvo con una tempestiva fuga, risultò dall’inchiesta un inetto codardo. E tutto l’apparato insurrezionale perse in quella vicenda il poco credito di cui ancora godeva.
***
A comporre la diatriba Nicotera-Fanelli giunsero le elezioni della primavera del 1865. Durante la campagna elettorale Nicotera si riconciliò pubblicamente con Fanelli, riconciliazione cosi narrata da Luigi De Monte (180) :
“Tutti i più operosi patrioti di Napoli si erano un giorno, al tempo delle prossime elezioni politiche nel 1865, raccolti in adunanza per intendersi e cospirare alla riuscita in senso liberale di sinistra dei nuovi deputati. La divisione o dirò meglio l’esitanza e l’incertezza d’intelligenza cordiale negli animi di molti esisteva come conseguenza precipua della lotta tra Nicotera e Fanelli. Sorta in proposito di una, candidatura una discussione fervida ed animata, non essendovi in fondo niuna ragione di dare l’ostracismo ad un egregio patriota, della cui elezione si trattava, dal Presidente della ragunanza fu fatto un caldo appello alla concordia tra le frazioni sorelle del partito liberale, e mentre gli animi pendevano irresoluti Giovanni Nicotera si leva, e con quella voce squillante ed incisiva che tutti gli conoscono disse: «E’ colpa il non seguire l’invito alla concordia tra noi; in essa sta il segreto del riescire. Tra gente che si stima bisogna stringersi la mano ed amarsi. Io ne offro il primo esempio». Ciò detto si slancia, e con uno di quegli impeti generosi e schietti, che destano la maraviglia e più la commozione, si accosta al Fanelli, gli stende le mani e cadono l’uno nelle braccia dell’altro. Rinunzio a descrivere il fremito elettrico che invase tutta l’assemblea. Giammai ho dato in mia vita un abbraccio più esultante e più espansivo di quello che io diedi a Giovanni Nicotera in quell’occasione, e gli avvenimenti posteriori sempre più mi richiamarono al cuore l’ineffabile sensazione di quel giorno, quando io vidi con tale sincerità di affetto il Nicotera essere d’allora in poi amico del Fanelli, fino a presentarlo egli stesso agli elettori e farlo risultar deputato in un collegio del Salernitano, allorché per un impensato caso mancò al Fanelli la sua antica deputazione.”
***
La sinistra meridionale consegui un notevole successo elettorale ottenendo la maggioranza nel mezzogiorno. Venne cosi archiviata definitivamente l’era della cospirazione ed iniziò la marcia che doveva portare alla svolta di governo del 1876 (181) , anno in cui la sinistra storica scalzò dal potere la destra storica. Una svolta per il paese ma non per le ex-provincie napolitane, che consegnandosi alla dinastia sabauda, col plebiscito dell’ottobre 1860, si erano perdute per sempre (182) .
Il sogno di quei pochi – Pisacane, Musolino e qualche altro – che avevano immaginato e provato a realizzare un riscatto autonomo del sud fini per essere incarnato dai vari ex-cospiratori – Nicotera, Crispi (183) , tanto per citarne due noti a tutti – divenuti parlamentari della sinistra “italiana”, l’uno divenuto ministro dell’Interno e l’altro Presidente del Consiglio.
Una sinistra che ha mantenuto il mezzogiorno come una carta da gioco della opposizione, da agitare ogni volta che servisse contro i governi di turno – prima governi regi, poi governi repubblicani – senza mai incidere profondamente in quei meccanismi di colonizzazione interna che si formarono nei primi anni e durano ancora oggi. Meccanismi che si condensano sempre nell’essere fuorviati nella propria azione su interessi esterni rispetto a quelli delle ex-provincie napolitane. Basti dire che Gaetano Salvemini, uno tra i ‘migliori’ dei cosiddetti meridionalisti, nel 1914, fosse un interventista! (184) Nell’agosto 1914 meditò di arruolarsi volontario contro l’Austria e il 18 ottobre si complimentò con Mussolini per l’abbandono della linea della neutralità.
DA SAPRI ALL’ITALIA DI GIOBERTI
Giunti quasi alla fine di questa nostra lunga ricerca, di una cosa siamo certi: il maggiore beneficiario della spedizione di Sapri fu Cavour (185) . Diversi cospiratori si convinsero che il tempo delle rivolte era finito, che occorreva guardare con realismo alla situazione della penisola, che servivano uomini, denaro e organizzazione: la Società Nazionale, di cui era presidente La Farina, divenne punto di riferimento di numerosi oppositori nei vari stati, anche se le adesioni formali furono poche. L’egemonia sabauda nel movimento unificatore ne usci rafforzata.
In una lettera a Valerio del 22 gennaio 1856, Manin ex-dittatore della Repubblica veneta aveva delineato la direzione da seguire (186) :
«Come pensatore, ed a priori, credo che la repubblica sia il migliore dei governi e che l'esercizio della libertà sia più largo e sicuro con la forma federale.
«Come uomo politico, vado con paziente cura cercando quello che è praticamente possibile; e quando parmi averlo trovato, m'ingegno d'indirizzare la mia azione per la via che stimo ad essa pratica possibilità conducente.
«Ho lungamente meditato sull'arduo problema del riscatto italiano, ed ho diligentemente analizzate le varie opinioni, apparentemente tanto diverse, delle varie frazioni di patriotti. Le pratiche conclusioni, che mi è sembrato poterne tirare, sono queste:
«1º Le varie frazioni di patriotti italiani sono concordi nei punti essenziali.
«2° Bisognare constare questa concordia, trovare una formola che chiaramente ne esprima i termini, inscrivere questa formola sopra una bandiera, rannodare intorno a questa bandiera le varie frazioni di patriotti, e costituire così il grande partito nazionale.
«Il primo punto essenziale, sul quale tutti i patriotti italiani sono d'accordo, è l'indipendenza. Ma perchè l'indipendenza sia solidamente costituita e conservata, è necessario che l'Italia, cessando d'essere una espressione geografica, diventi una individualità politica. Tre sono le forme possibili d'individualità politica: unità monarchica, unità repubblicana, e confederazione repubblicana. La parola unificazione comprende queste tre forme. Dunque il secondo punto, parimente essenziale, è l'unificazione. Questi due punti sono reciprocamente connessi ed inseparabilmente legati: l'Italia non può essere unificata se non è indipendente, e non può durare indipendente se non è unificata. Ecco pertanto i cercati due termini della formula, ecco l'iscrizione della bandiera nazionale: INDIPENDENZA ED UNIFICAZIONE.
«[...] Il partito piemontese ed il partito mazziniano, hanno entrambi, a mio avviso, il torto d'essere troppo esclusivi. Il primo rifiuta il concorso dei repubblicani, ed il secondo rifiuta il concorso dei realisti. L'uno pare che dica: Più dell'Italia amo la dinastia di Savoia; e l'altro pare che dica: Più dell'Italia amo la forma della repubblica.
Siccome le parole sono pietre e finiscono per guidare le persone sulle cui gambe camminano, dopo la dipartita di Manin 22 sett. 1857, prevalse la linea filo sabauda di Pallavicino (187) e nel 1860 alla parola unificazione subentrò la parola unità.
Le profetiche parole scritte da Gioberti nel 1851 (188) , “Imperocchè tengasi per fermo che LA MONARCHIA SARDA PERIRÀ INFALLIBILMENTE NELLE FUTURE VICISSITUDINI DI EUROPA, SE NON CERCA LA SUA SALUTE NEL RISCATTO D'ITALIA.” stavano per avverarsi!
Lo stato sabaudo, col suo re Vittorio Emanuele, diventava l’unica speranza d’indipendenza, anche per tanti cospiratori repubblicani.
A meno di tre settimane dalla fine di Pisacane, in una lettera, datata “Parigi, 21 luglio 1857”, G. Ulloa scriveva a G. Pallavicino (189) :
“Or che Mazzini è caduto nel più grande e generale discredito, bisogna attivare il partito nazionale. Il vostro progetto è ottimo.”.
Nella voce su Manin, che Michele Gottardi ha compilato per il Dizionario Biografico degli Italiani, leggiamo (190) :
“Secondo il Manin la scelta dei Savoia si coniugava all'idea di convocare un'Assemblea rappresentativa della volontà della nazione di proclamare re Vittorio Emanuele II; sostituendosi progressivamente al Manin alla guida del Partito nazionale, anche per l'affievolirsi delle sue forze, Pallavicino e G. La Farina imposero invece la linea cavouriana.
Comunque, dopo il fallimento della spedizione di C. Pisacane e di altri tentativi mazziniani, il movimento di liberazione si identificò sempre più con il partito voluto dal Manin, anche se nell'agosto La Farina ne mutò il nome in quello di Società nazionale italiana: per il peggioramento delle proprie condizioni fisiche il Manin anziché opporsi preferì dare la propria adesione.”
Il realismo e la lungimiranza dei fondatori (191) del Partito Nazionale, trasformatosi in Società Nazionale Italiana trionfarono.
Vengono in mente le parole del programma che il 14 dicembre 1854 Giorgio Pallavicino Trivulzio – influenzato in maniera determinante dal Gioberti del Rinnovamento – aveva pubblicato nell'Unione di Bianchi-Giovini (192) :
«La vita di un popolo non è la libertà, ma l'indipendenza. Vivono i Turchi malgrado il Sultano, e vivono i Russi malgrado l’Autocrate: noi non viviamo ancora.
«Italiano, anzi tutto, io cerco forze italiane per la santa guerra della nostra indipendenza. Non basterebbe a tal uopo l'insurrezione popolare; noi lo vedemmo: un popolo insorto può conseguire vantaggi momentanei fra le mura delle sue città, ma non saprebbe, senza un miracolo, combattere e vincere truppe regolari in aperta campagna.
«Per vincere cannoni e soldati, occorrono cannoni e soldati: occorrono buone armi: buone armi e non ciance. Il Piemonte ha soldati e cannoni: dunque io sono piemontese.»
|
Reggia di Caserta - Interni |
Sei anni dopo, l’11 ottobre 1860, durante una riunione nella Reggia di Caserta, presenti “Crispi, il ministro dell'Interno di Sicilia, Cattaneo ed uno sconosciuto” (193) , lo stesso Pallavicino, di fronte alle intemperanze dei repubblicani, rassegnava i suoi poteri e dichiarava che l’indomani avrebbe abbandonato Napoli (194) .
Con quella sua fermezza, avrebbe convinto Garibaldi (segretario della Società Nazionale) a far svolgere il plebiscito (195) . fra l’altro già indetto formalmente da “Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO”, con decreto dell’8 ottobre 1860 (196) .
L'idea che era stata di Manin – ovvero la convocazione di un’Assemblea nazionale (197) rappresentativa della volontà della nazione per ratificare le unioni al Piemonte e proclamare Vittorio Emanuele re d'Italia – naufragava per sempre.
Con la conferma dello svolgimento del plebiscito noi napolitani, tra illusioni e tradimenti, raccattammo una libertà presunta, svendendo una indipendenza vera. Questa fu la nostra redenzione (198) .
Cosi nacque – dal cosiddetto Risorgimento – un’Italia che, durante alcune appassionate conversazioni nell’estate del 2005, Nicola Zitara definì ’Italia di Gioberti”. La mia sorpresa di allora era dovuta tutta a semplice ignoranza, la mia, ovviamente; l’ho ben compreso ora che son giunto in fondo a questo lavoro, durato molti mesi. Indagando sulla vita, sul pensiero e sulle illusioni di Carlo Pisacane, mi sono ritrovato in una sorta di domino, dove un personaggio tirava l’altro, sbalzandomi avanti e indietro nel tempo.
Una manciata di anni, – dal 1848 al 1857 – durante i quali Pisacane, il “napoletano qualunque” non diventa solamente un “fervido patriota”, come sentenzia con una certa spocchia Nello Rosselli (199) , ma scrive una serie di opere su tematiche militari, per le quali verrà apprezzato più all’estero che in Italia, con traduzioni in francese e in tedesco (200) .
Alcuni saggi – su Pisacane teorico militare – verranno pubblicati anche in Italia, nel 1910 dalla «Nuova Rivista di Fanteria» (201) , nel 1977 dalla rivista Belfagor (202) , nel 1981 dall’Ufficio Storico dell’Esercito Italiano (203) .
Una sintesi di quegli avvenimenti che portarono alla consegna delle provincie napolitane al quel re che, non a caso, conservò la numerazione dinastica sabauda, la fa Salazaro in una opera che vi consigliamo di leggere (204) :
“Il 7 settembre del 1860 fu l’opera della spada di Garibaldi; il 21 ottobre 1860 fu l’opera dell’intelligenza di Pallavicino: l’un prodigio ebbe compimento dall’altro: a questi due grandi fattori dell'Unità Italiana presedeva da regioni più serene e quiete la nobile anima di Daniele Manin, e s’allegrava di vedere adempiuto il sublime suo voto per mezzo del braccio di Garibaldi, del senno di Pallavicino.”
BENEDETTO MUSOLINO E CARLO PISACANE
Vogliamo chiudere questo nostro lavoro facendo qualche considerazione sui rapporti fra il colonnello calabrese Benedetto Musolino (zio di Nicotera) e il colonnello napoletano Carlo Pisacane, rapporti poco documentati per quel che ne sappiamo noi, che non abbiamo né risorse né modo per girare per archivi, come possono fare coloro che di mestiere fanno gli storici di professione.
Ci soffermiamo su due date e su due testi, che vi invitiamo a leggere con attenzione:
1) 8 settembre 1854 – Lettera a Benedetto Musolino, di Carlo Pisacane (205) , Genova.
2) 11 luglio 1857 – Pisacane e la Spedizione di Sapri, di Benedetto Musolino (206) , Parigi.
Intanto notiamo che nella lettera di Pisacane, del settembre 1854, si parla di un eventuale uso della Legione anglo-italiana per una sollevazione nel Regno delle Due Sicilie, argomento citato nelle sue Memorie storico-politiche dal 1820 al 1876 da La Cecilia e snobbato dagli storici di regime – ovvero il progetto cavourrista di uno sbarco (207) sulle coste della Calabria, di alcune migliaia di arruolati per la guerra di Crimea.
Pisacane probabilmente non sa dei maneggi di Cavour, si dichiara abbastanza scettico, anche perché – scrive nella lettera – una cospirazione generale non sarebbe possibile, “né sarebbe prudente con gli elementi che l’accorto Inglese sceglie, e sceglie con la massima oculatezza” (208) . Promette a Musolino che martedì 11 del mese corrente di settembre ne scriverà “a Nicola Fabrizi che trovasi a Malta, di cui voi conoscete la fede, l’operosità e l’abilità in simile negozio” ((209) ).
Non sappiamo se Pisacane scrisse dell’argomento a Fabrizi e se ne ebbe risposta – di sicuro sappiamo che non se ne fece nulla. Adolfo Omodeo prese sul serio le “rivelazioni” del La Cecilia ma non trovò riscontri che le suffragassero nell’Archivio di stato di Napoli nelle carte Canofari e del console napoletano di Genova (210) .
A pochi giorni dalla tragica fine di Pisacane, l’11 luglio 1857, da Parigi, Benedetto Musolino interviene sul disastro di Sapri. Il suo intervento viene pubblicato, nell’anno 1908, sulla rivista Il Risorgimento Italiano, diretta da Beniamino Manzone (211) . Nel testo riportato, a nostro avviso, vi sono passaggi sorprendenti. Ad esempio difende il suo progetto sulla legione anglo-italiana che Pisacane avrebbe prima osteggiato, poi si sarebbe convinto, e scrive:
“La legione partì in dettaglio da Genova per riunirsi tutta in Malta. Quivi fu incaricato Fabbrizi a continuare le trattative cogli ufiziali; ma queste dovettero essere condotte con poca abilità e prudenza; giacché i legionari ed alcuni fra gli stessi ufiziali si permisero degli atti che suscitarono loro contro le popolazioni arci-cattoliche e superstiziose di Malta; sicché ne nacquero le collisioni, che ricorderete; conseguenza delle quali fu lo scioglimento della legione. Un battaglione che acconsentì di restare al servizio inglese partì da Malta per la Granbretagna e nella traversata, essendo in faccia alla Sicilia, Anghera ch’era luogotenente nello stesso corpo tentò di fare il colpo; arringò i soldati; pose addosso le mani al comandante; ma la maggior parte dei militi rimase inerte, e disarmato fu messo in carcere. La passò bene, perché fu solamente licenziato. Anghera era malvisto nel battaglione come quello che veniva accusato di orgoglio e di violenza; ed ecco perché il suo tentativo non ebbe adesione.
Questa prima idea di colpo di mano ha potuto suggerire (almeno lo credo) a Pisacane l’altra d’impossessarsi del Cagliari carico di armi pel bey di Tunisi.”
Dopo aver stigmatizzato la scelta di liberare i detenuti di Ponza e lo sbarco a Sapri, aggiunge:
“In effetti appena il Governo seppe l’approdo del Cagliari che diè ordine a due fregate a vapore di mettersi in corso. Fu data la caccia al Cagliari che muoveva verso mezzogiorno; e come la celerità delle fregate napolitano era maggiore, Pisacane temendo di essere arrivato e catturato sopra mare si affrettò di sbarcare a Sapri invece di arrivare in Calabria, per dove avrebbe dovuto essere a preferenza diretto, giusta gli antecedenti discussi tra noi, come luogo dove potevasi trovare più adesioni e concorso.”
“[...] Pisacane mi diceva che mi avrebbe avvertito di tutto; ma il fatto sta che io non ne seppi più nulla. Egli è partito con un pugno di gente; sbarcò dove non doveva sbarcare; e l’esito non poteva essere certo felice.”
Le parole di Musolino, “giusta gli antecedenti discussi tra noi”, in merito al luogo di sbarco (doveva essere in Calabria e non a Sapri), cozzano contro il contenuto delle lettere scambiate alcuni mesi prima fra lo stesso Pisacane, Fanelli e Mazzini. Quest’ultimo in una lettera del 6 marzo 1857 (212) chiede a Fanelli di preparare una relazione su Ponza da consegnare a Pisacane (213) .
Sul fatto che Musolino non ne sapesse nulla, basti dire che Nicotera era un suo nipote, figlio della sorella!
Se i membri del “Comitato Dragone” (214) non mentirono spudoratamente a Pisacane (215) , durante il suo sopralluogo a Napoli, ci chiediamo come abbia potuto pensare, uno con la sua intelligenza e i suoi contatti, che a Ponza vi fossero centinaia di detenuti politici pronti ad essere liberati? Oltretutto che non ve ne fossero molti glielo aveva scritto anche Fanelli.
Dobbiamo credere che Pisacane, spinto dalla foia di un intento pedagogico – volto ad offrire agli altri cospiratori ed al mondo intero un esempio di immolazione in nome dei suoi principi di libertà –, sia rimasto cosi obnubilato da andare incontro ad un fallimento sicuro?
***
In merito alla decisione, leggendo le pagine sul Risorgimento di Antonio Gramsci (216) , al di là di alcuni schematismi che non condividiamo, troviamo alcune intuizioni, sulla figura di Pisacane e sulle sue scelte, che meritano di essere riportate:
“Una quistione che il Rosselli non pone bene nel Pisacane è questa: come una classe dirigente possa dirigere le masse popolari, cioè essere «dirigente»; il Rosselli non ha studiato cosa sia stato il «giacobinismo» francese e come la paura del giacobinismo abbia appunto paralizzato l’attività nazionale.
Non spiega poi perché si sia formato il mito del «Mezzogiorno polveriera d’Italia» in Pisacane e quindi in Mazzini. Tuttavia, questo punto è basilare per comprendere Pisacane e l’origine delle sue idee che sono le stesse che in Bakunin ecc.
Così non si può vedere in Pisacane un «precursore» in atto del Sorel, ma semplicemente un esemplare del «nichilismo» di origine russa e della teoria della «pandistruzione» creatrice (anche con la malavita).
L’«iniziativa popolare» da Mazzini a Pisacane si colora delle tendenze «populiste» estreme. (Forse il filone Herzen indicato da Ginzburg nella «Cultura» del 1932 è da approfondire). Anche la lettera ai parenti dopo la fuga con una donna maritata potrebbe essere sottoscritta dal Bazàrov di Padri e figli (la lettera è pubblicata integralmente nella «Nuova Antologia» del 1932): c’è tutta la morale dedotta dalla natura come la rappresenta la scienza naturale e il materialismo filosofico.
Deve essere quasi impossibile ricostruire la «cultura libresca» del Pisacane e fissare le «fonti» dei suoi concetti: il solo modo di procedere è quello di ricostruire un certo ambiente intellettuale di una certa emigrazione politica di dopo il ’48 in Francia e in Inghilterra, di una «cultura parlata» di comunicazioni ideologiche avvenute attraverso le discussioni e le conversazioni.
[...] Il Pisacane è da avvicinare ai rivoluzionari russi, ai narodnichi, e perciò è interessante l’accenno fatto dal Ginzburg all’influsso di Herzen sugli emigrati italiani.
Che Bakunin, più tardi, abbia avuto tanta fortuna nel Mezzogiorno e in Romagna non è senza significato per comprendere ciò che il Pisacane espresse al suo tempo, e pare strano che proprio il Rosselli non abbia visto il nesso.”
Herzen era in rapporti di amicizia con diversi patrioti esuli a Genova, Pisacane ebbe occasione di frequentarlo con una certa assiduità per alcune settimane, nell’estate del 1852 (217) . Scrive argutamente Gramsci che è “quasi impossibile ricostruire la «cultura libresca» del Pisacane e fissare le «fonti» dei suoi concetti: il solo modo di procedere è quello di ricostruire un certo ambiente intellettuale di una certa emigrazione politica dopo il ’48 in Francia e in Inghilterra, di una «cultura parlata», di comunicazioni ideologiche avvenute attraverso le discussioni e le conversazioni”.
Il ruolo della volontà umana e l’aspirazione ad una maggiore libertà individuale, visti da Herzen come motori del cambiamento sociale, li ritroviamo anche in alcune lettere di Pisacane al fratello Filippo. In esse si fondevano gli ideali rivoluzionari e il desiderio di vivere appieno la propria vita, con una donna per la quale aveva abbandonato tutto, affetti familiari, averi e carriera militare.
***
Attraverso la lettura di vari carteggi e di epistolari, alla ricerca di notizie su Pisacane, ci siamo imbattuti in una serie di personaggi che ci hanno costretto a riscrivere decine di volte alcuni paragrafi e ad inserirne altri. Leggere una lettera di sicuro non spiega la “grande” storia ma aiuta ad entrare nella dimensione umana di chi scrive e a cogliere sprazzi di luce in certi accadimenti e in certe scelte, che altrimenti resterebbero poco comprensibili. Aiuta a rendersi conto che a volte anche gli storici blasonati finiscono per girare in un circolo chiuso, dove tutti copiano tutti, per abitudine, per risparmiare tempo, per ignavia o mancanza di coraggio nel mettere in discussione tesi consolidate da firme prestigiose, contro le quali meglio non mettersi se si vuol far carriera in ambito universitario e nella ricerca storica.
Giunti in fondo a questo lavoro, Pisacane ci appare come una sorta di agnello sacrificale lasciato andare incontro al suo destino, stretto fra personaggi come Mazzini, Fanelli, Albini, Fabrizi, Mignogna ed altri.
La sua fine tragica servi ai filo-sabaudi alla pallavicino per accreditarsi come i soli in grado di unire il paese e al partito d’azione per turarsi il naso (218) . Perchè è indubbio che la schiera di cospiratori allevati nell’area mazziniana, nel 1860, diede un contributo notevole alla riuscita dell’impresa garibaldina.
NOTE
(1) Cfr. Gli ideali del Risorgimento e dell'Unità, Antologia a cura di Giuseppe Talamo, Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche, 1961.
(2) Cfr. Canti di LUIGI MERCANTINI, Fava e Garagnani, Bologna, 1864.
(3) “Nel marzo 1849 raggiunse Roma, dove era stata proclamata la repubblica romana; nominato capo di stato maggiore, ebbe contrasti con Garibaldi, poco incline a sottostare alla rigida organizzazione che Pisacane cercava di trasmettere all'esercito repubblicano. L’esperienza romana e le polemiche interne al movimento repubblicano furono documentate nel volume La guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849 (1851).” Cfr, Pisacane Carlo (Napoli, 1818 – Sanza, Salerno, 1857) https://www.150anni.it/
(4) “L’arrivo della corrispondente inglese in Italia costituisce l’ultimo tentativo di far affidamento sulla cooperazione attiva di Garibaldi in un incontro che si tenne a Torino alla fine di maggio ’57. Oltre a Pisacane, Garibaldi e la stessa White, erano presenti Enrico Cosenz, Giovanni Nicotera, Giovambattista Falcone, Rosolino Pilo. Si discusse dell’insurrezione nel Cilento e dell’uomo che avrebbe dovuto guidarla. Garibaldi, acclamato da tutti, declinò l’invito in quanto ritenne privo di esito positivo il movimento insurrezionale proposto.” Cfr. Nello Rosselli e la valenza del sacrificio di Carlo Pisacane di ANGELO MARTINO - https://www.angelomartino.it/nello-rosselli-e-la-valenza-del-sacrificio-di-carlo-pisacane/ - 13 Novembre 2022.
(5) Qualche decennio fa lessi che i moderati gli avevano promesso che avrebbe trovato cinquemila uomini armati in quel di Sala Consilina (nel Vallo di Diano, prospiciente l’attuale Autostrada del Mediterraneo) – purtroppo non ricordo la fonte. Al di là dei miei ricordi viene riportato da taluni autori che nei pressi di Sala circa 2500 insorti avrebbero dovuto attendere Pisacane.
(6) «non vi era da fare assegnamento sul contingente offerto da Ponza, che grande fiducia non potea ispirare una marmaglia di relegati per delitti comuni; e di militi parte indisciplinati e parte cammorristi, salvo pochissime eccezioni; l'Isola non contenere condannati politici, tutti gli altri trovarsi a Ventotene, a S. Stefano e a Procida, nonché a Montesarchio». Cfr. Un episodio sullo sbarco di Carlo Pisacane in Ponza, VINCENZO DE LEO, Tipografia di Giuseppe Carluccio, Vico Carogioiello a Toledo, 17, Napoli, 1868, pag. 14.
(7) Cfr. Risorgimento rivoluzionario, PAUL GINSBORG, 9 Settembre 2020, https://www.vocedellasera.com/
(8) Cfr. Spagna 1808: la genesi della guerriglia moderna. 2. Fenomenologia della guerriglia spagnola e suoi riflessi internazionali di VITTORIO SCOTTI DOUGLAS in “Spagna contemporanea”, 2001, n. 20; pp. 73-167.
(9) Qualche autore riporta questa frase di Pisacane: «Sino ai cocchieri delle carrozzelle da nolo sono in Napoli repubblicani».
(10) Cfr. Scritti editi ed inediti (1857-1860) di GIUSEPPE MAZZINI, Ricordi su Carlo Pisacane, Volume XI, Forlì - Tip. e Lit. Democratica, 1882, pag. 25-52.
(11) Cfr. La Spedizione di Sapri e il Comitato di Napoli - Al Generale Garibaldi, Relazione di NICOLA FABRIZJ, Tipografia dell'Arno, Napoli, 1864.
(12) Cfr. La spedizione di Sapri e la provincia di Basilicata,DECIO ALBINI, Roma tipografia delle Terme Diocleziane, 1891
(13) Cfr. “La polemica sulla spedizione di Sapri – Un aspetto della crisi del mazzinianesimo nel Mezzogiorno”, A. CAPONE, Rassegna Storica Salernitana, Anno XXVII (1966), pagg.79-97.
(14) Cfr. Storia di dodici anni narrata al popolo italiano, G. LOMBROSO E D. BESANA, Milano, 1861.
(15) “Pisacane era un Napoletano di famiglia blasonata, figlio cadetto del Duca di San Giovanni che lo iscrisse al collegio militare della Nunziatella per farne un ufficiale di re Ferdinando, cui era egli stesso devotissimo. Era una buona scuola, una delle migliori d’Italia, perché era all’Esercito che Ferdinando dedicava tutte le sue cure, convinto che bastasse a difendere il suo trono.” Cfr. L'Italia del Risorgimento – 1831-1861, INDRO MONTANELLI, MARIO CERVI, Rizzoli Editore, Milano, 1972.
(16) Cfr. Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015, pag. 33.
(17) Cfr. Enrichetta di Lorenzo storia di una famigliai>, di ALESSANDRO DI LORENZO, seconda edizione, Tipolitografia «DEL PRETE», Frattaminore (Napoli).
(18) “Siamo nel 1846: al giovane intelligente ufficiale chi non avrebbe predetto, con la sua capacità, col suo nome, una brillante carriera? Eppure, nel giro di pochissimi mesi, tutto è perduto senza rimedio; l'esperienza militare appena iniziata si conclude bruscamente. La notte dal 12 al 13 ottobre il tenente Pisacane vien raccolto dinanzi alla sua porta di casa, svenuto e sanguinante per gravi ferite di pugnale nel ventre ed al petto. Mentre i medici accorsi dànno ben poche speranze, la polizia inizia le indagini: nessun testimonio del fatto; ma Pisacane, che ha una stupefacente ripresa, dichiara, e fa dichiarare dai suoi, che un ladro di strada, sotto minaccia della vita, ha tentato di derubarlo: egli si è ribellato e nella mischia seguita ha riportato quelle ferite. La convalescenza si prolunga, lentissima, fin verso la fine dell'anno. Poco dopo la polizia ha nuovamente occasione di occuparsi di Pisacane: l'8 febbraio '47, infatti, sotto mentito nome celato come un malandrino inseguito, egli s'imbarca sul postale francese diretto a Livorno. Con lui, che ha così dato definitivamente l'addio alle spalline borboniche, è una signora: Enrichetta Di Lorenzo, moglie di Dionisio Lazzari, madre di tre bambini.” Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 13.
(19) “Proprio per questa sua relazione, il Pisacane fu aggredito da emissari del Lazzari nottetempo e colpito al ventre e al torace con un lungo coltello. L'episodio avvenne la notte tra il 12 e il 13 ottobre 1846, lungo la strada di San Gregorio Armeno, giunto all’altezza di San Lorenzo Maggiore, gli si avvicinò un barbone che lo colpì ripetutamente durante la colluttazione. Lasciato esanime in una pozza di sangue, venne portato a casa della madre, dove la di Lorenzo l’avrebbe segretamente e amorevolmente assistito. Tutto ciò ci è noto attraverso la denuncia che una zia del Pisacane fece all’allora Ministro degli Interni del Carretto.” Cfr. Enrichetta di Lorenzo - storia di una famiglia, ALESSANDRO DI LORENZO, Istituto di Studi Atellani, 2012, pag. 44, http://www.iststudiatell.org/ .
(20) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 14.
(21) “Il mio piano è ben troppo concepito per temere intoppi: noi arriveremo a Londra, città eccentrica, libera, con la rapidità che può giungerci una lettera; quindi siamo all’ombra della folta giubba del leone britannico. Ma supponiamo che potrete farci fermare: qual è il vantaggio? Il rimedio sarà assai peggiore del male. Voi otterrete questo, giacché noi ci rivolgiamo in caso di violenza alla nostra ancora speranza, le pistole. Il nostro piano è fatto: io venderò a caro prezzo la vita, e spero che il prezzo sia alto, Enrichetta si ucciderà; quindi pace sia fra noi. ” Cfr. Carlo Pisacane, Epistolario, a cura di ALDO ROMANO, Società anonima editrice Dante Alighieri (Albrighi, Segati & c.), 1937 – pag. 33.
(22) “Può sorprendere che un uomo delle sue idee chiedesse l’arruolamento nella Legione straniera per una guerra imperialista come la conquista dell’Algeria. A spingervelo furono certamente il bisogno e la smania d’avventura.” Cfr. L'Italia del Risorgimento – 1831-1861, INDRO MONTANELLI, MARIO CERVI, Rizzoli Editore, Milano, 1972.
(23) Cfr. Carlo Pisacane e Giovanni Nicotera, o La spedizione di Sapri, FELICE VENOSTA, Barbini Editore, Milano, 1876, pag. 24.
(24) Ovviamente condividiamo appieno la osservazione di Omodeo, riportata da Leopoldo Cassese: Pisacane torna anche per stare vicino alla propria donna, visto che hanno perso la figlioletta da poco. Se c’è un punto fermo in ciò che abbiamo imparato nel corso dei decenni vissuti fin qui, è proprio il peso degli questioni personali sulle scelte ideologiche. L’eroe romantico che si batte contro tutto e tutti si infrange spesso contro il muro della banalità del vivere quotidiano, fato di affetti o di esigenze piccole ma vitali, come il mettere insieme pranzo e cena.
“Il momento passionale e quello politico in questo caso probabilmente coincidono nella anima di Pisacane; ma ciò non toglie efficacia all’acuta osservazione dell’Omodeo, clic «il momento politico e in lui non solo posteriore, ma anche in parte avventizio sulla crisi dell'amore romantico. È un tentativo di far rifiorire una vita spezzata: la passione politica è men profonda di quanto si può credere, non ostante il tono più radicale». Cfr. Critica, 1933, p. 282 recensione al libro del Rosselli.” Cfr. Nota 2 in “Note intorno alla biografia di Carlo Pisacane” di LEOPOLDO CASSESE, Estratto da: Rassegna storica del Risorgimento, A. 23., fasc. 6, giugno 1936 – https://www.liberabit.unisa.it/ .
(25) “Figlio e nipote di massoni, Mellinet fu egli stesso iniziato alla massoneria nella loggia di Mars et les Arts all'Oriente di Nantes nel 1815, all'età di 16 anni. 50 anni più tardi, divenne gran maestro del Grand'Oriente di Francia il 9 giugno 1865, dopo la morte del maresciallo Bernard Pierre Magnan. Vigile sui principi della massoneria, non si presentò nel 1870 per un secondo mandato malgrado la certezza di una sua rielezione a tale carica.” Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Èmile_Mellinet .
(26) Cfr. Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015, pag. 52.
(27) “Carlo, insoddisfatto della vita monotona in caserma, scrisse il 4 dicembre del 18481, da Vercelli, una lettera a Mariano D’Ayala, suo maestro di balistica della Nunziatella, chiedendo di poter far parte dell’armata che, come ministro della guerra del governo provvisorio toscano, stava organizzando.” Cfr. Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015, pag. 59.
(28) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 23.
(29) “Carlo giunse a Milano il 14 aprile: il tempo per solidarizzare con Carlo Cattaneo, per conoscere l’anziano generale Lechi, per scrivere un breve memorandum “Sul momentaneo ordinamento dell’esercito lombardo in aprile 1848”, richiestogli proprio dal Cattaneo al fine di organizzare una massa di volontari, accorsi alle armi sì per amor patrio, ma privi di cognizioni belliche, e per partire il 19 aprile arruolato nell’esercito lombardo con il grado di Capitano d’infanteria, reggimento della morte, colonna Borra, compagnia Cacciatori, e con destinazione Tirolo.” Cfr. Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015, pag. 53.
(30) Cfr. Epistolario, a cura di ALDO ROMANO, Società anonima editrice Dante Alighieri, Milano-Genova, 1937, pag. 56.
(31) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag..
(32) Cfr. Nota 28, pag. 158, MERIDIANA: Crolli Borbonici, N, 81, Viella, 2014.
Per dovere di cronaca informiamo i lettori che la parola “bestia” compare integralmente nell'opera “Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015. ” a pag. 54.
(33) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 24.
(34) “Nel Liceo di Lugano insegnarono Carlo Cattaneo, Atto Vannucci, il senatore Zini, i fratelli Cantoni e Pavesi, ora a Pavia, Alborghetti, Rodriguez ed altri. Cattaneo era cittadino ticinese e mori a Castagnola nel 1869. Mazzini tenne stanza quasi continua sulle amene sponde del Ceresio. Dall'Ongaro, De Boni, Arrivabene, Belgiojoso, Arconati, Porro, Carcano, Grillenzoni, Allemandi, Pisacane e mille altri passarono men tristi i giorni e gli anni dell'esilio sul territorio svizzero. Confalonieri morì alle falde del Gottardo. Si rinfaccia tuttora alla Svizzera, ed anche con ragione, l'obbrobrio dei suoi figli venduti ai Papi ed ai Borboni. Ma, per Dio, vedemmo nel 1848 più d'un carabiniere ticinese (notiamo un Vincenzo Vela) scendere dai monti. per fare il suo colpo e ben mirato, contro l'austriaco. E piangemmo estinto a Somma Campagna Francesco Calloni, animoso ed esperto tiratore,e sotto Roma l'eroico giovinetto Emilio Morosini, amicissimo del Manara. Giovanni Stoppani mori a Milazzo. Arcioni, Lentulus, Debrunner, Hofstetter,Vicari, i Ciani sono svizzeri e cancellano le infamie di Perugia. Marco Monnier lo strenuo difensore della «terra dei morti» è ginevrino. Meminisse jucabit. Ma tutto ciò oramai è di dominio della storia, e noi qui dobbiamo far semplicemente della bibliografia. Ci si perdoni lo sfogo, scevro da rancore. L'Italia ora è fatta e marcia sicura avanti. Viva l'Italia! E durino inalterate le sue amichevoli relazioni colla vicina Elvezia.” Cfr. Le Tipografie del Canton Ticino dal 1800 al 1859, BOLLETTINO STORICO della svizzera italiana, Anno VI, maggio 1884, N. 5.
(35) Cfr. Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015, pag. 58.
(36) Cfr. Scritti editi ed inediti di GIUSEPPE MAZZINI, Ricordi su Carlo Pisacane, Volume, Imola, Cooperativa tipografico-editrice Paolo Galeati, 1931, pag. 197-198.
(37) Giuseppe Beghelli (Briga Marittima, 11 settembre 1847 Nizza, 17 febbraio 1877), scrittore e giornalista, nel 1866 si arruol come volontario garibaldino nel Corpo Volontari Italiani di Giuseppe Garibaldi e combatt in Trentino nella terza guerra d'indipendenza.
(38) Cfr. La repubblica romana del 1849 con documenti inediti e illustrazioni per Giuseppe Beghelli, Volume Primo, Società Cooperativo-tipografica, Lodi, 1874, pag. 275.
(39) “Membro della Commissione di difesa e dello Stato Maggiore, certamente Pisacane dimostrò di avere idee più chiare sia di Mazzini, che del ministro della Guerra Avezzana, del generale Roselli e dello stesso Garibaldi, coi quali fu subito in rotta.” Cfr. L'Italia del Risorgimento – 1831-1861, INDRO MONTANELLI, MARIO CERVI, Rizzoli Editore, Milano, 1972.
(40) “Per una imperdonabile trascuraggine non erano state mandate le munizioni di riserva della fanteria e, lagnandosi, il generale in capo doveva attendere anche tale spedizione.
L’Intendenza inoltre non avendo eseguiti gli ordini, Roselli trovavasi senza viveri — epperciò nella necessità di temporeggiare.
Se Garibaldi avesse fatto riflesso a questa e a tante circostanze, non avrebbe certo esposta la repubblica romana a un grave pericolo. E coloro che vollero assumersi lo incarico di giustificare l’atto d’indisciplina di Garibaldi, lamentando le lentezze di Roselli, potevano risparmiarsi così fatte polemiche, ove fossero stati penetrati delle supreme difficoltà che attraversavano l'impresa.
«Il movimento — scriveva il 18 maggio da Zagarolo Pisacane ai triumviri — il movimento che avremmo dovuto operare è arrestato per mancanza di viveri; dopo tante promesse dell'Intendente, io stentava a persuadermi che non avesse eseguito quanto doveva. L’armata poco numerosa, cittadini triumviri, e a poca distanza dal nemico non deve mancar del bisognevole.»
«Non solo, soggiungeva in altra lettera Roselli, non solo l’Intendente ha mancato di far seguire l’armata da viveri, ma ha impedito ai capi dei corpi di fornirsene. Con le date disposizioni l'esercito avrebbe dovuto essere fornito per tre giorni e invece manchiamo di viveri a una tappa da Roma e i paesi percorsi sono impotenti a somministrare le necessarie sussistenze.»” Cfr. La repubblica romana del 1849 con documenti inediti e illustrazioni per Giuseppe Beghelli, Lodi, Società' Cooperativo-tipografica, 1874, pag. 219-220.
(41) Nel marzo 1849 Pisacane raggiunse Roma, dove era stata proclamata la Repubblica; nominato capo di stato maggiore, durante la difesa della citt ebbe dei contrasti con Garibaldi, poco incline a sottostare alla rigida organizzazione che lo stesso Pisacane cercava di trasmettere allesercito repubblicano.Cfr. Pisacane, Carlo, https://www.treccani.it/ .
(42) Cfr. Rapido cenno sugli ultimi avvenimenti di Roma dalla salita della breccia al di 15 luglio 1849, CARLO PISACANE, Losanna, Societ Editrice lUnione, 1849.
(43) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 40.
(44) Nel 1842 intanto, il 30 giugno, a Pescara, Carlo prometteva e giurava fedelt ed ubbidienza a Sua Maest il re Ferdinando Secondo, e pronta ed esatta assicurazione ai suoi Sovrani ordiniCfr. Carlo e Filippo Pisacane. Un «conflitto civile privato» nel Mezzogiorno borbonico di SILVIA SONETTI, in MERIDIANA, N 81,Viella, Via delle Alpi, Roma, 2014, pag. 155-156.
(45) Vogliamo qui ricordare le parole “In ricordo di Fabrizio Ruffo eroe dissacrato della nostra indipendenza” che Nicola Zitara pose a dedica nella sua ultima opera: L'INVENZIONE DEL MEZZOGIORNO Una storia finanziaria, Nicola Zitara, Editore Jaca Book, 2011.
(46) “A dispetto della “vulgata”, in realtà appena 150 di loro indossavano la classica camicia rossa, la maggior parte erano in abiti civili, mentre Bixio aveva l’uniforme da colonnello dell’esercito piemontese e 59 carabinieri genovesi avevano la loro giubba d’ordinanza.” Cfr. Storia dei servizi segreti - La verità su chi veramente governa il mondo, MIRKO MOLTENI, Newton Compton Editori, 2022.
(47) Una deputazione di molti notabili calabresi, alcuni de' quali facevano parte della prima spedizione, si presentata al generale dicendogli, il paese esser pronto a riceverlo e la Calabria attenderne con impazienza l'arrivo.
É il 2 agosto, e se la posizione non è interamente cambiata, è modificata alquanto, perchè i difensori della cittadella sono scorati, si parla di resa, le diserzioni continuano e gli ammalati crescono per l'acqua malsana.
Per contrario nella città si risveglia la vita commerciale e negli animi degli abitanti la confidenza, si organizza la guardia nazionale e la coscrizione procede alacremente; i soli artiglieri mancando per le batterie di posizione.
Il generale Türr, guarito quasi della sua ferita, essendo arrivato a Messina qualche giorno innanzi con un distaccamento di volontari, ne parte bentosto, menando seco un quattro in cinquemila omini, per mettersi in comunicazione con gl'insorti di Potenza. Si approntano battelli a vapore per il trasporto dei garibaldini e di munizioni. Disertori piemontesi ed inglesi formato l'equipaggio dell'Anita, già Queen-Of-England, guarnito della sua batteria, non che di due grossi cannoni, secondo il sistema Amstrong.
L'Indipendente, di maggior velocità che non l'altro, è armato di due pezzi da 68 e di due altri da 32.
Dall'arsenale di Palermo arrivarono ogni giorno proietti, artiglierie ed ogni maniera di utensili da guerra lasciati colà da' regii, il perchè al compimento della impresa non manca né il materiale, né uomini, né ardire.
Nel porto poi è sempre l'Imperiale e due fregate, inglese l'una, piemontese l'altra, Il Veloce, l'Alba, il Duca di Calabria sono in crociera, addetti al trasporto tra il continente e l'isola.” Cfr. Garibaldi capitano del popolo, ALFREDO BIANCHI, Roma, Edoardo Perino, Editore-Tipografo, 1892.
(48) “Nasce in questo periodo un contrasto teorico e pratico, intessuto di avversione personale, che impedirà per sempre un qualsiasi accordo fra Garibaldi e Pisacane e indurrà quest’ultimo a giudizi eccessivi e ingiusti sul suo antagonista.” Cfr. Carlo Pisacane teorico militare, VINCENZO GALLINARI, Ufficio Storico SME - Roma 1981.
(49) Cfr. Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015,pag. 68.
(50) Cfr. Lettre du Chef de l'État-Major de l'armée de la République Romaine au Général en Chef de l'armée française en Italie, Société Éditrice de l’union, Lausanne, 1849, pag. 5-6.
(51) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 43.
(52) Pisacane, nel mese di luglio, aveva chiesto a Mazzini di introdurlo fra le sue conoscenze londinesi. Riportiamo una lettera indirizzata a Emilie Ashurst e tratta da “Mazzini’s Letters to an english family 1844-1854, Edited and with An Introduction by E. F. Richards, London: John Lane, The Bodley Head New York: John Lane Company, MCMXX”:
To Emilie, at Tavistock House
From Rome, July loth, 1849
Dear Emilie,
Pisacane is a friend, one of ours. He has been "chef d'Etat Major" in our Roman army, and he has behaved bravely, gallantly, and patriotically. I like him very much, and I am sure you will do so too. Will you introduce him to all your family and to all those amongst your friends who are likely to prove useful to him? He must, of course, look for occupation; and he is worthy finding one, either as an "ingénieur" or otherwise. I know it is very difficult; still, it is well to try. I hope to see you before or after you will have received this.
Your friend
Jos. Mazzini.
(53) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 18.
(54) Cfr. Rassegna storica del Risorgimento, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Volume 20, 1933, pag. 80.
(55) Sir James Stansfeld nacque il 5 marzo 1820, ad Akeds Road, Halifax, figlio unico di James Stansfeld Senior e di Emma Ralph. Sposò il 27 luglio 1844, Caroline (fu sostenitrice della "Society of the Friends of Italy", fondata a Londra nel 1851 da Mazzini, dopo la pubblicazione del pamphlet William Gladstone’s Two Letters to the Earl of Aberdeen), seconda figlia di William Henry Ashurst. Nel 1847, conobbe Giuseppe Mazzini e fra i due nacque una profonda amicizia. Fu simpatizzante del movimento Cartista e profondo conoscitore di Robert Owen, uno dei primi socialisti, facente parte della corrente nata nella prima metà dell'Ottocento che ebbe il nome di socialismo utopico.. Dopo il '48 convennero presso la Swan Brewery, da lui fondata, Aurelio Saffi, Medici, Carlo Pisacane, Maurizio Quadrio, Campanella e più tardi Enrico Cosenz.
(56) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 50.
(57) La sorella di Nicotera, dopo la morte del fratello e di Silvia Pisacane-Nicotera, mossa da scrupoli religiosi, diede alle fiamme l'epistolario d'amore Carlo-Enrichetta, conservato dalla loro figlia fino al termine della sua breve vita. Si ipotizza che furono distrutti anche dei manoscritti inediti di Pisacane.
(58) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 52.
(59) “Tra Genova ed Albaro scorre un fiumicello: il Bisagno. Dove questo si getta nel mare, è un villaggio di pescatori; questa frazione del comune di San Francesco è detta la Foce. Il regio Cantiere dal quale uscirono le nostre migliori navi da guerra la rende animata, ma il luogo di per sé spira melanconia. Una piccola spiaggia, un mare severo, una chiesuola, un cimitero sono le sole cose che possono attirare l'attenzione del viaggiatore.” Cfr. La spedizione di Sapri poemetto epico-lirico, Eliodoro Lombardi, Milano, Edoardo Sonzogno Editore, via Pasquirolo. 1885, pag. 147.
(60) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 55.
(61) Cfr. Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015, pag. 81.
(62) Cfr. La spedizione di Sapri poemetto epico-lirico, Eliodoro Lombardi, Milano, Edoardo Sonzogno Editore, via Pasquirolo. 1885, pag. 148.
(63) A FRANCESCO CRISPI, GENOVA
27 dicembre 1850.
Fratello,
Due parole appena, perché mi manca assolutamente il tempo. Ebbi la vostra del 2 dicembre —Parlai, prima della vostra, ad Amari del progetto di conversione in Cartelle: annuiva. A Laf[arina] non ne parlai. Fate di sollecitare l’organizzazione vostra definitiva, e rinvio d'Interdonato in Londra. Sono convinto — benché da Malta e da altrove si scriva diversamente —che avete ragione nel modo di vederle cose di Sicilia: quelle popolazioni devono esser cosi stanche da cacciarsi in braccio a qualunque dia loro un principio d'azione. Per questo appunto, è necessario che lavoriamo a che l'iniziativa parta da noi: e se compiremo l'Imprestito, partirà. Avete difficoltà a trasmettermi un nome del Comitato di Palermo? Accettata una volta l'ispirazione concentratrice del Comitato Nazionale, è naturale che si conosca da noi o almeno uno o due di noi un nome almeno d'ogni nucleo importante dell'interno. Molti casi possono accadere pei quali rimanga tagliato e perduto un lavoro: e inoltre, una occasione può presentarsi colla quale il Comitato Nazionale possa mandare direttamente una parola d'incoraggiamento.
Credetemi sempre vostro
GIUSEPPE.
LA RIPOSTA DI FRANCESCO CRISPI
«Fratello,
Rispondo alla vostra del 27 caduto. E comincio manifestandovi la mia soddisfazione dal conoscere che siete d'accordo con me sul veder le cose di Sicilia. E veramente, riflettendo ai fatti altrui, ed alle recenti violazioni del dispotismo in quell'infelice paese, non si può pensare altrimenti. Quindi scongiuro tutti i buoni a voler affrettar ogni opera, onde, nella prossima crisi europea, l'Inghilterra o altri non ci prevenga. Se tanta sventura ci colpisse nel riordinamento della Nazione, troveremmo un ostacolo difficile a sormontarsi; dalle spiagge della Grecia alla Corsica saremmo cinti da isole occupate da stranieri, che impedirebbero nei mari ogni slancio alla nostra potenza commerciale e guerriera. Avrete saputo a quest'ora il risultato delle elezioni del nostro Comitato provinciale. I componenti di esso non tarderanno molto a costituirsi. Io da questa elezione ne ho desunto una grande verità, della quale ero incerto sino ad un mese fa: la grande maggioranza degli esuli Siciliani son pel trionfo della democrazia e per l'Italia unita. Abbiamo scritto in Pal[ermo] il vostro desiderio di mettervi in comunicazione con uno decomponenti quel Comitato interno. Come avremo risposta di là, saprete il segno e l'individuo, perché possiate facilmente dirigervi sul luogo. Abbiam voluto praticare in tal modo perché in ogni evento noi di qui fossimo al sicuro da qualunque responsabilità, e non avessimo la taccia di incendiarii.
Salute e fratellanza.»
Cfr. SCRITTI EDITI ED INEDITI, Giuseppe Mazzini, Volume XLV – Epistolato Vol. XXIV, Imola, Cooperativa Tipografico-Editrice, Paolo Galeati,. 1926. pag.101.
(64) Cfr. Il dissidio tra Mazzini e Garibaldi - La storia senza veli, Documenti inediti, GIACOMO EMILIO CURATULO, A. Mondadori, Milano – 1928, pag. 135.
(65) A GIUSEPPE GARIBALDI A NEW YORK.
[Londra] 14 Novembre 1851
Fratello,
Non so dove siate: ma se queste linee vi giungono, rispondete. Tra qui e il maggio, il nostro moto è sicuro; legato col moto europeo. Data l’ipotesi. che vi s'affidasse la Direzione del moto in Sicilia, accettereste?
Il moto di Sicilia è d’una importanza vitale per noi, perché il Napoletano e buono, disposto, ma disorganizzato; o almeno organizzato meno dell’altre Provincie Italiane. E bisogna porlo tra l’insurrezione siciliana e quella del Centro. Più, perché la Sicilia, comeché organizzata ora con noi e sotto un Comitato Centrale in Palermo nostro, cova per antico abito tendenze separatiste che voi vincereste. Repubblica Italiana unitaria è sempre la nostra bandiera e, confido, la vostra.
In Sicilia vi chiedono.
Voi non dovreste se non agire in conformità col disegno generale espresso del Governo d'Insurrezione Italiana qualunque ei sarà.
Operazioni marittime sono contemplate che, vinta la questione dell’isola, compireste.
Volete?
Scrivete una parola all'indirizzo: Caroline Stansfekl, 2. Sydney Place, Brompton, London.
Discutiamo il passato. L'era Italiana comincia. Addio.
Vostro
Gius. Mazzini.
Cfr. SCRITTI EDITI ED INEDITI, Giuseppe Mazzini, Volume XLVII – Epistolato Vol. XXV, Imola, Cooperativa Tipografico-Editrice, Paolo Galeati,. 1927, pag. 87-89.
(66) Cfr. Garibaldi and the thousand by George Macaulay Trevelyan, Long Mans, Green, and Co., London, 1909, pag. 25.
(67) “L’arrivo della corrispondente inglese in Italia costituisce l’ultimo tentativo di far affidamento sulla cooperazione attiva di Garibaldi in un incontro che si tenne a Torino alla fine di maggio ’57. Oltre a Pisacane, Garibaldi e la stessa White, erano presenti Enrico Cosenz, Giovanni Nicotera, Giovambattista Falcone, Rosolino Pilo. Si discusse dell’insurrezione nel Cilento e dell’uomo che avrebbe dovuto guidarla. Garibaldi, acclamato da tutti, declinò l’invito in quanto ritenne privo di esito positivo il movimento insurrezionale proposto.” Cfr. Nello Rosselli e la valenza del sacrificio di Carlo Pisacane di ANGELO MARTINO - https://www.angelomartino.it/nello-rosselli-e-la-valenza-del-sacrificio-di-carlo-pisacane/ - 13 Novembre 2022.
Anche Jessie White Mario parla del rifiuto di Garibaldi e lo fa risalire al febbraio 1857:
“The hope of those who had hoped against hope began to flag; Medici refused to listen to any further projects; Bertani himself was disheartened. And when Carlo Pisacane and Rosalino Pilo, having secured Mazzini's adhesion to a fresh project for revolutionizing the south, appealed to Garibaldi, he for the first time gave a point-blank refusal. I could not believe this when it was told to me, and my letter to the general probably expressed my surprise. He answers on February 3, 1857 ” Cfr. Autobiography of Giuseppe Garibaldi, by Jessie White Mario, Vol. III, Supplement. Bern Walter Smith And Innes, 1889, pag. 139-141.
La lettera di Garibaldi a Jessie White Mario potete leggerla nell’originale inglese in “Autobiography of Giuseppe Garibaldiby JESSIE WHITE MARIO Vol. III. Bern Walter Smith and Innes,
1889”.
(68) “Anche questo personaggio era, perciò, al “servizio di Sua Maestà” e il suo vero nome, quello con cui sarà poi, successivamente, Presidente del Consiglio dei Ministri del neo costituito Regno d’Italia, era Francesco Crispi (1808-1901).” Cfr. Ippolito, Ercole e Oliphant nella spedizione dei mille di GIUSEPPE ESPOSITO, https://www.fattiperlastoria.it - 15 Novembre 2023.
“Crispi, da buon agente inglese, indossava una redingote buona per cavalcare ma tanto stretta sulla vita da mostrare le corde.” Cfr. 1861, Antonella Grippo, Giovanni Fasanella, 2011, Pag. 69.
(69) Di esempi ne potremmo riportare a decine, ci limitiamo alla lettera inviata da Messina a Nicola Mignogna il 31 luglio 1860:
“Caro Mignogna, Io prima del 15 di Agosto spero di essere in Calabria. Ogni movimento rivoluzionario, operato nelle provincie napoletane in questa quindicina, sarà non solamente utilissimo, ma darà di più una tinta di legalità in faccia alla diplomazia, al mio passaggio sul continente. Qualunque uffiziale dell’esercito napoletano che si pronuncii per il movimento nazionale sarà accolto fraternamente nelle fila di questo esercito, col proprio grado, e promosso secondo il merito. Dite ai nostri prodi del continente napoletano che presto saremo insieme a cementare la sospirata da tanti secoli nazionalità italiana. G. Garibaldi.”
Cfr. Nicola Mignogna nella Storia dell’unità d'Italia,GIUSEPPE PUPINO-CARBONELLI, Stab. Tip. del Cav. A. Morano, Napoli, 1889, pag. 198.
(70) Cfr. Memorie di Giorgio Pallavicino dal 1852 al 1860, pubblicate per cura della figlia, Volume Terzo, Editori Roux Frassati e Co., Torino, 1896, pag. 152.
(71) Ecco la lettera datata“Nizza 4 Febbraio 55 “:
“Caro Lorenzo,
t'invio una mia idea al Re, che presenterai, se trovi a proposito. Leggila. Avessimo la fortuna di far qualche cosa per questa misera patria!
Io credo, non possa capitare occasione più propizia. Adoperati, con quell'anima tua caldamente Italiana, riesci, e dimmi alcunché di buono.
Noi faremo più che non si crede, mio caro Valerio, se ci permettono d'inoltrarci sulla scena d'azione.
Tuo
G. Garibaldi
394. TBP, IX, 9, 10. Edita in Epistolario di Giuseppe Garibaldi, III, cit., p. 96.
1. Il messaggio che Garibaldi voleva che Valerio inoltrasse eventualmente al sovrano (già edito in Epistolario di Giuseppe Garibaldi, III, cit., p. 96, nota) era il seguente:
«Sire,
ho concepito un'idea, ch'io credo bene manifestarvi.
Voi dovete inviare 15 mila uomini in ajuto degli Occidentali; invece di 15, se ne preparino 25 mila (in questi tempi, ne' paesi nostri, non è la gente esperta a determinare il numero d'una massa di truppa). I dieci millabz'c] sieno imbarcati nella squadra nostra, e comandati da un'hz'c] Ufficiale di vostra fiducia, e godente d'alcuna popolarità.
La spedizione deve necessariamente costeggiare la Sicilia, d'una parte, o dall'altra; i 15 mila continuano la loro corsa a levante, i 10 sbarcano nel porto determinato.
In due mesi, Sire, un esercito di dugento mila Italiani giunge sul Po, e vi proclama Re d'Italia. E un fatto compiuto! Gli occidentali acquistano un contingente di 100 mila uomini, in luogo di 15. Voi, Sire, avrete la benedizione di questo povero popolo, che tace, ma che freme nell'aspirazione d'una vita, che Voi solo potete darle.
Sire, Italia è assai più preparata ad un movimento serio, che non si crede. Austria, Francia, Inghilterra, poco, o nulla ponno intervenire nel presente.
L'occasione è propizia; ed a chi altro che a Voi, che gloriosamente pugnaste per la regenerazione di quella terra, tocca capitanarla ? Gl'Italiani, Sire, altro non chiedono, che d'avervi a capo, fatti nazione. Io, e gli uomini che mi credono, gettiamo a' vostri piedi quanto vagliamo. Senza condizioni, almeno colla sola, che ci facciate combattere per l'Italia, e per Voi.
Guarantigie di fedeltà, Sire, non ve ne diamo: Voi le troverete nel nostro cuore generoso, al cospetto della più santa dell'imprese.
Sono con rispetto
G. Garibaldi»
Visto il contenuto della missiva, Valerio decise evidentemente di non inoltrarla e di conservarla presso di sé.”
Cfr. LORENZO VALERIO CARTEGGIO (1825-1865)Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi – V (1850-1855) Edito a cura di ADRIANO VIARENGO, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 2010, pag. 557.
(72) Cfr. Lettere edite ed inedite raccolte ed illustrate da LUIGI CHIALA, deputato al parlamento, Vol. II, Torino Roux e Favale 1883, pag. CLXXXIX.
(73) Cfr. “I tentativi per far evadere Luigi Settembrini all’ergastolo di Santo Stefano negli anni 1855-56” di GAETANO CAPASSO - Il Risorgimento Italiano - Rivista Storica (organo della “società nazionale per la storia del risorgimento italiano”), diretta dal prof. BENIAMINO MANZONE, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1908.
(74) “Yet this prospect of peace and rest, which appealed to him for the first time in his life, did not deter him from throwing himself heartily into the scheme planned between Sir William Temple, the English ambassador at Naples, Sir James Hudson, English minister at Turin, and Anthony Panizzi, of the British Museum,for securing the escape of the political galley-slaves of King " Bomba." For this purpose, Sir James Hudson had consulted his friend, Dr. Agostino Bertani, well knowing that for such a risky affair he must apply to the " Party of Action, " and Bertani had lost no time insecuring Garibaldi's consent. Medici, the defender of the Vascello in the siege of Rome, came to England and purchased a vessel—the Isle of Thanet—but it got wrecked off Yarmouth, and a considerable time was lost.” Cfr. The birth of modern Italy, Posthumous papers of Jessie White Mario, edited with an introduction by the Duke Litta-Visconti-Arese. London. T. Fisher Unwin, 1909.
“The interest caused by Gladstone’s pamphlet died down— all Britain’s energies became involved in the Crimean war,— and Settembrini and his friends still languished on the island of Santo Stefano. Panizzi, however, did not lose heart; and in 1855 he eagerly embraced a scheme—apparently suggested by Settembrini himself—to rescue the prisoners by means of a vessel to be sent to the island. On 3 August 1855 he wrote:
The affair promises well, and the difficulties are enormous, but as I have found money beyond what I had hoped, I am of good courage... The sum needed is enormous, and is required for the chartering of a steamer which is to be found. Time presses. Mr. Gladstone has behaved wonderfully, or properly speaking Mrs. Gladstone, who has given me £100 of her own, and found £200 more amongst her friends.”
Cfr. Lord Palmerston and the Secret Service Fund, Gavin B. Henderson, The English Historical Review, Vol. 53, No. 211 (Jul., 1938), https://www.jstor.org/
(75) Cfr. Daniele Manin e Giorgio Pallavicino - Epistolario politico (1855-1857), con note e documenti per B. E. MAINERI, Milano, Tipografia Editrice di L. Bortolotti e C., 1878, pag. 400-401.
(76) “Partito Medici, il colonnello Enrico Cosenz si accinse ad organizzare una terza spedizione. Ricostituì l'Ufficio Militare dividendo il lavoro col tenente colonnello Damiano Assanti e col Cressini, al quale (come già pratico) affidò specialmente la direzione del personale. Sistemò i Comitati d'arruolamento nelle principali città.
[...] Si adottò in quest'Ufficio la massima che tutti avessero le loro dimissioni, e che nei corpi volontarii ottenessero l'ultimo grado avuto nell'esercito regolare.” Cfr. Le spedizioni di volontari per Garibaldi - Cifre e documenti complementari al resoconto Bertani, Estratto dal Corriere Mercantile, Genova, Tipografia e Litografia dei Fratelli Pellas e C., Piazza Santa Marta, 1861, pag. 9.
(77) Ad esempio:
EPISTOLARIO di Giuseppe Garibaldi,Vol. III 1850 -1858, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1981.
LORENZO VALERIO CARTEGGIO (1825-1865)Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi – V (1850-1855) Edito a cura di ADRIANO VIARENGO, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 2010.
Autobiography of Giuseppe Garibaldiby JESSIE WHITE MARIO Vol. III. Bern Walter Smith and Innes, 1889.
Vita di Giuseppe Garibaldi di LUIGI PALOMBA, Edoardo Perino Editore, Roma, 1882.
MEMORIE DI GIORGIO PALLAVICINO dal 1860 al 1860, Pubblicate per cura della figlia, Volume Terzo, Roux Frassati e C. Editori, Torino, 1895.
(78) “Quasi esattamente 160 anni fa, il 28 marzo del 1854, scoppiò quella che molti ricordano, dai libri di scuola, come la guerra di Crimea. Gli storici la considerano il primo conflitto moderno della storia: per la prima volta vennero utilizzati su larga scala il telegrafo, le navi a vapore e le ferrovie. Per la prima volta il fronte venne visitato dai corrispondenti dei giornali, che pubblicarono regolari resoconti delle azioni, mentre vennero scattate le prime fotografie di guerra (con l’eccezione di alcuni scatti fatti qualche anno prima in un remoto conflitto in India; molti di questi primati si attribuiscono spesso alla guerra civile americana, che cominciò sette anni dopo). Ma soprattutto fu un conflitto scoppiato per motivi incredibilmente stupidi, in cui quasi tutti i partecipanti, diplomatici e militari, brillarono per incompetenza e incapacità.” Cfr. L’altra guerra di Crimea di DAVIDE MARIA DE LUCA, 2014 https://www.ilpost.it/ .
“Da tempo gli studi sulle origini della guerra hanno fatto giustizia delle presunte mire aggressive dello zar Nicola I, e dimostrato che più volte egli cercò di evitare lo scontro, una volta constatata l’infondatezza delle sue previsioni iniziali sull’acquiescenza dell’Inghilterra. Da parte sua, raramente il governo inglese aveva avuto alla testa un avversario della guerra così convinto come lord Aberdeen, pacifista autentico per ragioni religiose e morali, che non riuscirà mai a perdonarsi di non aver saputo impedire tanto spargimento di sangue.” Cfr. Cavour e il suo tempo (1854-1861), ROSARIO ROMEO, vol. 3°, Gius. Laterza & Figli, 2012. pag. 135.
Vedi anche: “Guerra ad Oriente dalla guerra di Crimea alla guerra d’Ucraina” di ZENONE DI ELEA, 2022, https://www.eleaml.org/.
(79) Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 81.
(80) Benedetto Musolino da Pizzo Calabro, merita una trattazione a parte e ci proponiamo di farlo prima o poi. Per darvi una idea della vastità dei suoi interessi culturali, indichiamo solamente alcuni testi:
1848 - Al popolo delle Due Sicilie, Napoli
1848 - L'Inghilterra e l'Italia, Roma
1863 - Il prestito dei 700 milioni e la riforma delle imposte, Torino
1951 - La Gerusalemme e il popolo ebreo, Roma [questo libro fa di Musolino un precursore del sionismo politico, fu pubblicato un secolo dopo la sua composizione, per iniziativa del Presidente dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, Raffaele Cantoni, e di Dante Lattes, con una ampia introduzione dello storico Gino Luzzatto].
(81) Cfr. EPISTOLARIOdi Giuseppe Garibaldi, Vol. III, 1850 -1858,
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1981, pag. 96.
(83) Cfr. L'opera Politica del Conte di Cavour,ADOLFO OMODEO, V ol. III, Nuova Italia Editrice, 1945, pag. pag. 237.
(84) Cfr. Cavour e la «scommessa italiana», ROBERTO MARTUCCI, Quaderni costituzionali, Nº 2, 2012, pag. 339-367.
(85) Cfr. Biografia di Giovanni Nicotera (estratto dalla Storia del Parlamento Italiano), Vol. III, Matteo Augusto Mauro, Nocera Inferiore, Tipografia Editrice della Vesuviana, 1886, pag. 7.
(86) “Che a Torino si guardasse con favore all’iniziativa meridionale in preparazione a Genova si può dunque immaginare senza alcuna forzatura: e in questo senso va anche ricordata l’affermazione della White, ben nota nella letteratura pisacaniana e in qualche misura confermata dalle ricerche ulteriori, che il Nicotera avesse partecipato alla spedizione nel Sud addirittura in qualità di agente cavouriano.” Cfr. Cavour e il suo tempo (1854-1861), ROSARIO ROMEO, vol. 3°, Gius. Laterza & Figli, 2012.
“I fatti di Lunigiana (25-26 luglio 1856), con il coinvolgimento di esponenti moderati, la tolleranza sulla presenza clandestina di Mazzini a Genova per preparare un moto insurrezionale nel Mezzogiorno e in Sicilia nell'estate del 1857 (su cui peraltro già dal 1855 lavorava lo stesso La Farina), la partecipazione di G. Nicotera alla spedizione di Sapri in qualità di agente cavouriano, testimoniano a sufficienza che, almeno sino all'attentato di F. Orsini a Parigi (gennaio 1858), la strategia cavouriana sembrò produrre effetti positivi.” Cfr. Giuseppe La Farina, ANTONINO CHECCO, Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, 2004.
(87) Vedi Storia documentata della Diplomazia europea in Italia dall’anno 1814 all'anno 1861, per Nicomede Bianchi, Vol. VII, 1870, p. 626 e seg.
(88) Cfr. Diplomatic study on the crimean war (1852 to 1856), RUSSIAN OFFICIAL PUBLICATION, Vol. II. London:W. H. Allen & Co., 13 Waterloo Place Publishers To The India Office, 1882, pag. 84-86.
(89) Cfr. Cavour e la «scommessa italiana», ROBERTO MARTUCCI, Quaderni costituzionali, Nº 2, 2012, pag. 339-367.
(90) Cfr. Il dissidio tra Mazzini e Garibaldi - La storia senza veli, Documenti inediti, GIACOMO EMILIO CURATULO, A. Mondadori, Milano – 1928, pag. 157.
(91) Cfr. L'Italia del Risorgimento – 1831-1861, INDRO MONTANELLI MARIO CERVI, Rizzoli Editore, Milano, 1972, Cap. XXXIII.
(92) Movimento politico eterodiretto dai francesi che voleva insediare sul Regno di Napoli Luciano Murat, nato a Milano nel 1803 e cresciuto a Napoli, figlio di Gioacchino Murat e di Carolina Bonaparte. Luciano Murat ottenne il titolo di principe nel 1853 e fu Gran Maestro della Massoneria dal 1852 al 1861, quando lasci la carica per dissidi sorti col cugino imperatore sullassetto della penisola italica, in particolare sul destino del Regno delle Due Sicilie.
(93) L'impero napoleonico restaurato, aveva fatto risorgere in Napoli un vecchio partito, il murattista, che mettea radice nelle memorie di un regno brillante e fastoso, divenuto specialmente caro ai Napoletani per la malvagità di quelli che seguirono. Questo partito era rappresentato in Parigi da un gruppo dei nostri esuli, fra' quali per zelo distinguevasi il duca di Cirella e Pietro suo fratello, per antico affetto e devozione legati alla casa di Murat; e mano mano vi aderivano Francesco Trinchera, Francescantonio Mazziotti, Giovanni Andrea Romeo, Francesco Stocco ed altri esuli che erano in Piemonte ed in Toscana, disperando di poter redimere altrimenti la più bella parte della penisola da una dominazione fattasi definitivamente nemica di libertà e d' indipendenza. A dar maggior forza a questo partito ed a destare a suo pro le simpatie del paese, Napoleone III, che divisava di porre in atto il decreto dato da Berlino del grande suo zio contro i Borboni, incaricava il conte Arese di avere un illustre Napoletano per insegnare ai due figli di Luciano Murat le leggi, l'amministrazione, la storia delle due Sicilie. L'Arese ne scrisse al Salvagnoli, e questi alla baronessa Begani ch' era in Pisa, vedova del generale che mantenne sulla rocca di Gaeta la bandiera che con la vittoria aveva fatto il giro del mondo ed era caduta a Waterloo. Unanime fu il parere di Roberto Savarese e degli altri, che in casa Begani si riunivano, di affidare questo delicato uffizio ad Aurelio Saliceti, il quale, caduta la repubblica romana, era passato dalla seggiola di triunviro a correggere stampe in una tipografia. Fu adunque da Giacomo Coppola chiamato il Saliceti in Toscana, ed ivi giunto, gli amici gli fecero premura ad accettare il delicato uffizio, onde sotto il patrocinio del nuovo impero la dinastia dei Murat cacciasse da Napoli quella dei Borboni.” Cfr. Gli ultimi trentasei anni del reame di Napoli (1824-1860), Volume Secondo - Ferdinando II, NICCOLA NISCO, seconda edizione riveduta ed ampliata, Napoli cav. Antonio Morano, Editore 1889, pag. 404-405.
(94) Cfr. Daniele Manin e Giorgio Pallavicino - Epistolario politico (1855-1857), con note e documenti per B. E. MAINERI, Milano, Tipografia Editrice di L. Bortolotti e C., 1878, pag. 61.
(95) Cfr. Le Memorie dei miei tempi, SALVATORE COGNETTI GIAMPAOLO, Napoli Stabilimento Tipografico A. Manzoni nell'Ex-Collegio Medico, 1874, pag. 140-142.
(96) Cfr. Cenni sulla rivoluzione italiana del 1860, DEMETRIO SALAZARO, Napoli, Stabilimento Tipografico di R. Ghio In S. Teresa agli Studi, 1866, pag. 4.
(97) Cfr. Epistolario di Giuseppe La Farina, Raccolto ubblicato a AUSONIO FRANCHI. E. Treves & C., Editori, Milano, 1869, pag. 40 e 78-79.
(98) Cfr. Dichiarazioni di aniele anin sulla quistione italiana,Pubblicate ne' giornali di Francia e d'Italia dal marzo 1854 al febbraio 1856, Stamp. dell'Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1856, pag. 6-8
(99) Cfr. Italia e popolo giornale politico, Anno VI n. 169, Genova Giovedi 19 Giugno, Italia e popolo giornale politico, Anno VI n. 180, Genova Lunedi 30 Giugno, Italia e popolo giornale politico, Anno VI n. 188, Genova Martedi 8 Luglio.
(100) A titolo di curiosità facciamo notare che il testo di questa lettera non corrisponde esattamente a quello contenuto nella edizione del 1859.
Cfr. Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino con note e documenti sulla Quistione Italiana, Torino, Unione Tipografico-Editrice, dicembre 1859, pag. 176.
Cfr. Daniele Manin e Giorgio Pallavicino - Epistolario politico (1855-1857), con note e documenti per B. E. MAINERI, Milano, Tipografia Editrice di L. Bortolotti e C., 1878, pag. 590.
(101) Il 13 marzo 1854, nella Camera de' Comuni d'Inghilterra durante il dibattito sulla sollevazione della Grecia, ad una domanda del deputato Monckton, John Russell, fra l’altro rispose:
“I have nothing further to say, except that there was an allusion in the hon. Gentleman's speech which perhaps I ought to notice; namely, that we ought not to be a party to any agreement or arrangement for suppressing political movements in Italy.
I say distinctly with regard to Italy what I have just said with regard to Greece, that, feeling as I do, with the people of Italy, I do not believe they could take a course more obstructive of the attainment of the very result which they desire, than that of rising at the present moment against the Austrian Government.
I believe, on the contrary, that if they remain tranquil, the time will come when that Government will be not only more humane, but will concede many more popular privileges than would be the case if Italy were to rise in insurrection against the military forces of Austria.” Cfr. HANSARD'S PARLIAMENTARY DEBATES: Third Series,, Vol. CXXXI Comprising the period from the twenty-eighth day of February, tο the twenty- eighth day of March, 1854. Second volume of the Session, London, Published by Cornelius Buck, At the Office for Hansard's Parliamentary Debates, 32, Paternoster Row, pag. 712.
(102) Cfr. Il dissidio tra Mazzini e Garibaldi - La storia senza veli, Documenti inediti, GIACOMO EMILIO CURATULO, A. Mondadori, Milano – 1928, pag. 158.
(103) Cfr. Memorie di Giorgio Pallavicino dal 1796 al 1848, pubblicate per cura della moglie, Volume Primo, Ermanno Loescher Editore, 1882, PROLOGO, pag. XVIII-XIX.
(104) Cfr. Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino con note e documenti sulla Quistione Italiana, Torino, Unione Tipografico-Editrice, dicembre 1859, pag. 177-180 e pag. 185-186.
(105) Cfr. Storia universale degli ultimi quattro anni, 1856-1860, WOLFGANG MENZEL, Editrice Guigoni, 1861, pag. 26.
(106) Cfr. Il decennio orribile delle Due Sicilie (1850-1860) https://www.eleaml.org/
(107) Cfr. Lettere di Gladstone Gladstone's Letters https://www.eleaml.org/
(108) “Il signor De Lesseps, figlio del console generale di Francia in Egitto, ivi lo era stato egli stesso dall'anno 1832 al 1838, ed in quell'intervallo profondamente studiò la questione del passaggio tra i due mari. Godendo l'amicizia dell'erede presuntivo al trono, Mohammed-Saïd-Pascià, seppe ispirare a quel principe i sentimenti che lo animavano rispetto all'impresa del Bosforo egiziano, discutendo i vantaggi che tale opera arrecherebbe non solo all'Egitto, ma a tutti quei paesi che con esso sarebbero posti in comunicazione. MohammedSaïd, divenuto viceré nel 1854, graziosamente invitava l'amico suo a recarsi in Egitto, ed in un viaggio fatto da Alessandria al Cairo, chiedeva al signor De Lesseps una memoria sul progetto del taglio dell'Istmo. Tale memoria veniva nel 15 novembre 1854 diretta al viceré dal campo di Marèa (deserto della Libia), ed in essa il progetto era concretato, per modo che nel dì 30 novembre successivo il principe emanava un firmano di concessione col quale autorizzava l'illustre francese, con facoltà esclusiva, a costituire una Compagnia formata di capitalisti di tutte le nazioni, avente per oggetto il taglio dell'Istmo e l'esercizio d'un canale tra il Mar Mediterraneo ed il Mar Rosso sotto il nome di Compagnia universale del Canale marittimo di Suez.” Cfr. La questione commerciale d'Oriente L'italia e il Canale di Suez, Pier Luigi Barzellotti Tipografia Eredi Botta, Firenze, 1869, pag. 131-132.
(109) “Cfr. «Il Diritto», a. II, n. 226, 23 settembre 1855. Nello stesso numero, poi, compariva un lungo articolo, Napoleone I e Napoli, volto a mettere in evidenza che il regno meridionale era stato, per la Francia napoleonica, soltanto terra di conquista e sfruttamento. Nei numeri del 25 e del 26 settembre, inoltre, il giornale pubblicava solenni proteste di esuli meridionali. La prima, di quelli che risiedevano a Genova, era aperta dalle firme di Enrico Cosenz e Carlo Pisacane, ed assommava ad una trentina di sottoscrizioni. La seconda, i cui primi firmatari erano Domenico Mauro, Giovanni Nicotera e Francesco De Sanctis, era sottoscritta solamente da una decina di esuli, ai quali si aggiunsero, nel numero del 3 ottobre, le analoghe proteste di Giuseppe Del Re e di Giuseppe La Masa.” Cfr. Nota 420 nel Carteggio, Lorenzo Valerio, Edito a cura di Adriano Viarengo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 2010.
(110) Cfr. “I tentativi per far evadere Luigi Settembrini all’ergastolo di Santo Stefano negli anni 1855-56” di GAETANO CAPASSO - Il Risorgimento Italiano - Rivista Storica (organo della “società nazionale per la storia del risorgimento italiano”), diretta dal prof. BENIAMINO MANZONE, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1908.
(111) “Temple approfittò dell’occasione, per trarre profitto e scrisse:
“Il direttore della polizia napoletana, Mazza, ha intimato alla popolazione di non intrattenere alcun rapporto amichevole con gli ambasciatori inglesi” (Acton 1962:374.).
Gondon descrive la strumentalizzazione di questa faccenda sulle pagine della stampa inglese.
“Certi giornali sempre pronti a ingigantire i malintesi che possono sorgere con il governo italiano, hanno raccontato che il signor De Fagan, uno degli attacchè più eccellenti dell’ambasciata inglese a Napoli, è stato offeso dal ministro della polizia nel teatro Del Fondo“ (Gondon 1861:21).
Se Mazza non sarà sollevato dall’incarico, non ci si può aspettare nessun miglioramento delle condizioni interne del Paese e la delegazione inglese non potrà mai essere sicura che un caso simile non si ripeterà più (cfr. ibid.). Palmerston riportò ovviamente l’episodio in Parlamento (cfr. Camopolieti 2001:394). In Inghilterra gli animi furono ulteriormente infiammati dalla stampa. Il Times richiese una spedizione punitiva nei confronti di Napoli.” Cfr. Il ruolo della Gran Bretagna nella caduta del Regno delle Due Sicilie, Tesi di laurea di Martin Kohler, https://www.eleaml.org/sud/storia/martin1_tesi.html
(112) Cfr. “Guerra ad Oriente - dalla guerra di Crimea alla guerra d’Ucraina” di ZENONE DI ELEA, 2022, https://www.eleaml.org/.
(113) Cfr. Cavour e la scommessa italiana, ROBERTO MARTUCCI, Quaderni costituzionali, N 2, 2012, pag. 339-367.
(114) Isolamento a cui contribuirono, con i loro articoli e le loro pubblicazioni, gli esuli napolitani rifugiati in Piemonte, esuli che secondo noi costituivano buona parte di quegli oltre trentamila uomini, che pi meno stabilmente, si fermarono in Piemonte nel decennio 1850-1860 trentamila una stima fatta dal Furiozzi. Cfr. L'emigrazione politica in Piemonte nel decennio pre unitario, G. B. FURIOZZI, Firenze, 1979.
(115) Cfr. Epistolario di Giuseppe La Farina, Raccolto ubblicato a AUSONIO FRANCHI. E. Treves & C., Editori, Milano, 1869, pag. 40 e 78-79.
(116) Cfr. Vita di Giuseppe Garibaldidi UIGI PALOMBA, Edoardo erino ditore, Roma, 1882, pag. 228-231
(117) “E per mostrar di graziare spontaneo, fece molte grazie ne’ consigli di stato del 28 e 30 luglio, dopo informazioni prese sulla condotta d’alquanti esuli e condannati; però ridonò la patria a parecchi, fra’ quali noto il medico Lanza, proclamatore della decadenza della monarchia, il poi famosissimo traditore Liborio Romano, e Francesco Pesacane disertore, ch’avea combattuto a Velletri contro l'arme patrie. Altre grazie largiva a 3 ottobre, fra cui quelle dell’ex deputato Amodio che l’avea chiesta, ed altre appresso. Rientrarono adunque tanti felloni il più per ricongiurare, come si vide. Solo il Pesacane non se ne valse, e si restò fuori: e’1 perchè presto sfolgorò.” Cfr. Storia delle due Sicilie dal 1847 al 1861, Giacinto de' Sivo, Volume primo, Trieste, 1868, pag. 332.
(118) “Sicuramente doloso era stato, pel Console inglese a Napoli, lo scoppio del Carlo III. «Questa — egli scriveva al Clarendon il 6 gennaio '57 — è una situazione spaventosa, milord, che cagiona a tutti molta paura e ansietà»; e suggeriva che, a rinforzo del Malacca già ancorato a Napoli, vi s'inviasse altra nave da guerra, a protezione dei residenti inglesi. Il qual desiderio, avallato dal comandante il Malacca, venne prontamente soddisfatto, coll'invio, da Malta, dell'Osprey. (Record Office, F. O., 70 | 289, 292).” Cfr. Nota 214 pag. 155 in Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927.
“Un superstite del Carlo III, Carmine Gallo di Molfetta, afferma oggi che quell'avvenimento, l'attentato del Milano e lo scoppio della polveriera fossero eseguiti per opera della Giovane Italia. E narra ch'egli fu ritenuto complice; interrogato, arrestato per due mesi e poi congedato prima che scadesse la ferma. Il Gallo è vecchio, ed è verosimile che ubbidisca ad un senso di vanità postuma.” Cfr. La fine di un regno Il regno di Ferdinando II, Raffaele de Cesare, Citta di Castello, Casa Tipografico Editrice S. Lapi, 1908, pag. 221.
(119) Cfr. ATTO DI ACCUSA proposta dal Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Principato Citeriore contro Giovanni Nicotera ed altri molti detenuti imputati degli avvenimenti politici verificatisi in Ponza, Sapri, ed altri paesi del Distretto di Sala e Decisione emessa dalla G. C. su di essa, Dicembre 1857, Pag. 28-33.
(120) Cfr. Nuova luce sullo sbarco di Sapri, Memoria letta nella tornata del 19 novembre 1893 dal socio MICHELE LACAVA - Volume XXV degli ATTI della Accademia Pontaniana, Tipografia Della Regia Università, Napoli,1893, pag. 27.
(121) Cfr. Benedetto Musolino, GIUSEPPE BERTI, Studi Storici, Rivista trimestrale, Anno I 1959-60 n. 4, luglio-settembre 1960, Istituto Gramsci Editore - http://www.benedettomusolino.it/ .
(122) “Del risvegliamento murattista insospettirono i mazziniani del napoletano. Il loro comitato, che Niccola Fabrizii da Malta aveva messo in diretta comunicazione con Giuseppe Mazzini a Londra e con Carlo Pesacane a Genova, illuso dalle lettere dell'Albini e di altri entusiasti sulle preparate forze rivoluzionarie, specialmente nella Basilicata e nel Salernitano, e temendo che il connubio trattato ad Aix potesse esser messo in esecuzione, promosse una spedizione ardita; la quale se non riuscisse a rovesciare Ferdinando, rovescerebbe certamente la impresa murattiana che si stava organizzando a Marsiglia. Capitani di questa spedizione mazziniana erano Carlo Pisacane, già ufficiale di artiglieria napoletana e valoroso capo dello stato maggiore dei combattenti per la difesa di Roma; Giovanni Nicotera di S. Biase in Calabria, che in giovanissima età era con animo ardente entrato nel campo politico, aveva combattuto nella rivoluzione di Calabria, e, fuggito con quel comitato, s'era arrolato fra i battaglioni della repubblica romana; e Giovambattista Falcone, l'amico di Agesilao Milano: tre uomini in cui l'ardimento era sostenuto da uno slancio che non conosceva ostacoli.” Cfr. Gli ultimi trentasei anni del reame di Napoli (1824-1860), NICCOLA NISCO, Cav. Antonio Morano, Editore s. Sebastiano, Napoli, 1894, pag. 364.
(123) Cfr. Enrichetta di Lorenzo storia di una famiglia, di ALESSANDRO DI LORENZO, seconda edizione, Tipolitografia «DEL PRETE», Frattaminore (Napoli), pag. 68.
(124) Cfr. Studio critico che può servire di prefazione al presente poemetto, Francesco dall'Ongaro, in LA SPEDIZIONE DI SAPRI, poemetto epico-lirico di Eliodoro Lombardi, Milano, Edoardo Sonzogno, Editore, 1885, pag. 12.
(125) Cfr. Il Risorgimento Italiano, Rivista Storica diretta da T. PALAMENGHI CRISPI, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1914, pag. 324
(126) Cfr. Rubattino, ARTURO CODIGNOLA, Licinio Cappelli, Bologna, 1938, pag. 35.
(127) Cfr. Pisacane proibito (Parte Seconda), EDOARDO VITALE, Golfonetwork, Villammare (Sa), 2021.
(128) “Rubattino interpellato di rilasciare il Cagliari che è lì in porto al primo momento rifiuta; i suoi precedenti politici non potevano metterlo a riparo delle gravi responsabilità di fronte alla Compagnia e al Governo. Ma, come dice l’A., l’ardore patrio, il disinteresse quasi colpevole, l’ardire generoso ebbero il sopravento sul freddo uomo d’affari, e il rapimento del Cagliari fu dal Comitato d’azione concertato in tutti i suoi particolari col Rubattino stesso, che sapeva quello che rischiava, ma la posta era tropo bella: l’avanzarsi dell’unità d’Italia. Tutto l’equipaggio era a giorno dell’impresa.” Cfr. RASSEGNA BIBLIOGRAFICA, Arturo Codignola, Rubattino, Licinio Cappelli, Bologna, ITALA CREMONA COZZOLINO, in GIORNALE STORICO LETTERARIO LIGURIA, Anno XIV, 1938, pag. 287-295.
(129) Cfr. Atto di Accusa proposta dal Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Principato Citeriore, contro Giovanni Nicotera ed altri, Salerno, Stabilimento Tipografico-Librario di Raffaello Migliaccio, 1857, pag. 17-18.
(130) La Compagnia sarebbe stata lautamente indennizzava, dal Garibaldi, per i furti dei tre piroscafi (Cagliari, Lombardo, Piemonte), ovviamente con i soldi del nostro erario:
“ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
Il DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE
Riconosciute e provate da solenni documenti le gravi perdite che la Società di Navigazione a Vapore Raffaele Rubattino e C. ebbe a soffrire per l'illegale cattura del battello il Cagliari, che servi alla generosa, quanto sventurata, patriottica impresa di Carlo Pisacane;
Decreta
Art. 1. È assegnata alla Società di Navigazione a Vapore Raffaele Rubattino e C. la somma di franchi 450,000 da pagarsi dalla Tesoreria di Napoli, in tante cartelle del debito pubblico, corrispondenti all'effettiva somma suddetta.
Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Caserta 5 ottobre 1860,
Il Dittatore
G. GARIBALDI.
ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
Il DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE
Considerando ch'è giustizia ed obbligo di riconoscenza nazionale, che la Società di Navigazione a Vapore Raffaele Rubattino e C. di Genova venga indennizzata de' danni sofferti per la perdita de' due battelli il Lombardo ed il Piemonte i quali servirono alla prima e fausta spedizione in Sicilia nel maggio ora scorso.
Considerato quindi il prezzo de' due battelli al 5 maggio passato, desunto da stima fatta due anni prima per cura della Società stessa.
Considerato il lucro che poteva recare alla Società l'esercizio di que' due battelli nei mesi trascorsi.
Considerato il danno che venne alla Società per le angustie in cui trovossi mancandole due de' migliori battelli suoi nell'esercizio dell'imprese avviate, e degli obblighi contratti.
Considerata la perdita che soffrirono delle loro robe molti marinari del Lombardo, e tutti quelli del Piemonte.
Sentendo che la Nazione deve equamente proporzionare le ricompense a chi patì per la causa della sua libertà, e che giova si rassodi la confidenza di ogni proprietario ed industriale, nelle imprese per quanto ardite della patria redenzione.
Decreta
Art. 1. Sarà pagata in cartelle del debito pubblico dello Stato una somma corrispondente ad effettivi franchi 750 mila a carico per ¾ parti delle Finanze di Napoli, e ¼ di quelle della Sicilia, alla Società di Navigazione a vapore Raffaele Rubattino e C. di Genova, in compenso della perdita dei Battelli a Vapore il Lombardo ed il Piemonte, i quali saranno riparati e conservati in memoria dell'iniziativa del popolo Italiano, nella guerra d'indipendenza ed unità nel 1860.
Art. 2. Il Ministro delle Finanze di Napoli, e quello dello stesso Dicastero in Sicilia sono incaricati per quanto ad ognuno concerne della esecuzione del presente Decreto.
Caserta 5 ottobre 1860.
Il Dittatore
G. GARIBALDI.
Cfr. Atti del Governo - Estratti dal Giornale Officiale di Napoli, dal 7 Settembre al 31 dicembre 1860, pag. 102.
(131) Cfr. Storia dei servizi segreti - La verità su chi veramente governa il mondo, MIRKO MOLTENI, Newton Compton Editori, 2022.
(132) Cfr. Appunti sul codice cifrato delle lettere di Carlo Pisacane durante l'organizzazione della spedizione di Sapri, CONTILLI CRISTINA, Accademia.Edu - 2024.
(133) Ricordiamo ai nostri lettori che durante gli studi alla Nunziatella Carlo Pisacane aveva dimostrato particolare predisposizione nelle scienze matematiche.
(134) Cfr. Nicola Mignogna nella Storia dell’unità d'Italia, GIUSEPPE PUPINO-CARBONELLI, Stab. Tip. del Cav. A. Morano, Napoli, 1889, pag. 134-136.
Cfr. Archivio storico siciliano, Pubblicazione periodica della Società Siciliana per la Storia Patria, Nuova Serie, Anno XXIV, Tipografia lo Statuto, Palermo 1899, pag.212.
(136) “Il nome dei fratelli Orlando trovasi in ogni pagina della storia patria da quarant'anni in qua. Tutti tre ingegneri, Luigi, Giuseppe e Paolo presero parte cospicua nella rivoluzione della nativa Palermo nel '48. Rifugiatisi poi a Genova impiantarono lo stabilimento metallurgico della Pila e nel loro cantiere fu costrutta la prima macchina navale italiana, la prima nave in ferro! Nessun tentativo di riscatto ebbe luogo senza il loro aiuto, nessuno sventurato fu da loro rimandato a mani vuote. Implicati nel processo di Genova (1857) e proposta la loro espulsione, scrive Cavour all'intendente di Genova:
«Ho interceduto in loro favore a motivo dei servigi che rendono al paese e al governo come industriali. Ma nello stesso tempo chiamato avanti a me Luigi Orlando capo della casa, gli ho dichiarato che al primo moto mazziniano in Genova, sarebbero stati espulsi, avessero o no ad esso partecipato.»
Come niente fosse, Luigi e i fratelli continuarono ad essere gl'intermediari tra i patrioti nell'isola, Fabrizi in Malta e Mazzini. Aiutarono Pilo e Corrao, poi si misero interamente a disposizione di Garibaldi. Nel '60 Giuseppe e Paolo partirono coi mille; il primo condusse le macchine del Lombardo e fu poi capitano di corvetta, il secondo fu ministro dei lavori pubblici, Luigi rimase a Genova per coadiuvare i preparativi per altre spedizioni. Finita la campagna tornarono all'officina, e assunta la direzione dello stabilimento Ansaldo in San Pier d'Arena, ivi costrussero le prime locomotive nazionali. Nel '66 intrapresero il cantiere navale di Livorno ove se oggi l'orgoglio nazionale può chiamarsi soddisfatto, il cuore di ognuno esulta pel benessere degli operai e l'armonia perfetta che regna tra essi e i venerandi padroni i quali coi figli di Luigi ancora dirigono. «Patria e lavoro» è l'arme gentilizia di quella santa famiglia. Vera gloria è la loro di certo! ”
Cfr.Agostino Bertani e i suoi tempi,JESSIE WHITE MARIO, Vol. II - Firenze, Tipografia di G. Barbera, 1888, pag. 32.
Cfr. La Basilicata nella istoria del Risorgimento Nazionale,Memoria letta nella tornata del 2 giugno 1895
dal socio MICHELE LACAVA - Volume XXV degli ATTI della Accademia Pontaniana, Tipografia Della Regia Università, Napoli,1895, pag. 26-28.
(138) Cfr. “Giudizi d’un esule su figure e fatti del risorgimento” di IVANO RAULICH - Il Risorgimento Italiano - Rivista Storica (organo della “società nazionale per la storia del risorgimento italiano”), diretta dal prof. BENIAMINO MANZONE, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1908, pag. 456.
(139) Cfr. Spedizione dei mille?...se credete ancora alle favolette! di ZENONE DI ELEA, 2010 – https://www.eleaml.org/ .
(140) “Innumerevoli sono i documenti che dimostrano la rivoluzione italiana essere stata opera di gente straniera, e i nostri popoli averla soltanto subita. Per dir solo dei Napoletani, basti fin d'ora ricordare la confessione fattane dall'infelice Bixio in pubblica Camera di Torino, nella tornata 9 dicembre 1863, e la dichiarazione solenne di Garibaldi nel pomposo ricevimento fattogli in Inghilterra nell'aprile del 1864, dove, innanzi a 30,000 spettatori, Ministri,membri del Parlamento e Lordi, ebbe a dire: «Napoli sarebbe ancora dei Borboni senza l'aiuto di Palmerston; e senza la flotta inglese io non avrei potuto passare giammai lo stretto di Messina».” Cfr. Memorie Documentate per la Storia della Rivoluzione Italiana raccolte da PAOLO MENCACCI, Roma Tipografia Di Mario Armanni Nell'ospizio Degli Orfani Alle Terme, 1879, pag. 13.
(141) “I signori Finzi Mangili di Milano si recarono a Marsiglia, e con 450,000 franchi comperarono tre vapori.
Donde avevano ricavato quei 450,000 franchi? Non dalla Cassa centrale Bertani. Si seppe allora che la Direzione del Milione fucili, che la Società Nazionale offersero i loro mezzi; si disse pure che grossa somma erasi ricavata dal Governo, per vendita ad esso fatta dall'anzidetta Direzione di armi da essa possedute: quali? nol sappiamo.
Fatto sta che i tre vapori, coll'assistenza del Console degli Stati Uniti, prendevano bandiera americana, ed i nomi di Washington, Franklin, ed Oregon. Appena giunti in Genova, si dovettero munire di capitano, equipaggio, macchinisti ecc. ”
Cfr. Le spedizioni di volontari per Garibaldi - Cifre e documenti complementari al resoconto Bertani, Estratto dal Corriere Mercantile, Genova, Tipografia e Litografia dei Fratelli Pellas e C., Piazza Santa Marta, 1861, pag. 7-8.
(142) Cfr. La Repubblica - venti dialoghi politico-popolari, LEOPOLDO PEREZ DE VERA, Napoli, Tipografia dell’unione, Strada nuova Pizzofalcone, 1869, pag. 27.
(143) Cfr. L'Epistolario di Giuseppe La Farina - Ire politiche d'oltre tomba, raccolte da Agostino Bertani, Firenze, Tipografia di G. Polizzi e C.. 1869, pag. 72.
(144) Cfr. Nicola Mignogna nella Storia dell’unità d'Italia, GIUSEPPE PUPINO-CARBONELLI, Stab. Tip. del Cav. A. Morano, Napoli, 1889, pag. 214.
(145) Cfr. Scritti e discorsi politici (1849-1890), FRANCESCO CRISPI, Unione Cooperativa Editrice, Roma, 1890, pag. 595-603.
(146) “Mi venne detto, ma non lo affermo, che in Sarno fu trovato trafitto da varii colpi di pugnale un contadino di Agropoli, che si millantava di aver dato un colpo di vanga all'infelice Pisacane e di averlo così steso per terra.” Cfr. L’ITALIA DEL POPOLO GIORNALE POLITICO QUOTIDIANO Stabilimento Tip. Nazionale, via Sauli, presso Cannotto il lungo, N. 7, Anno II. Genova — Lunedi 1° Marzo 1858. Num. 60.
(147) Cfr. Carlo Pisacane e Giovanni Nicotera, o La spedizione di Sapri, FELICE VENOSTA, Barbini Editore, Milano, 1876, pag. 123.
(148) Cfr. I presupposti della spedizione di Pisacane e la realtà del regno borbonico, MASSIMO NARDINI, Storia e Politica, X n. 1, 2018, pp. 30-53.
(149) Il Garibaldi sapeva ogni mossa nostra, sia per terra, sia per mare. Egli navigava guidato, e perci sicuro nel suo cammino. Io ritenni sempre che la spedizione di Garibaldi era stabilita e decisa dall'estero, e fornita di aiuti e mezzi da estere potenze. Mosse perci dessa sicura per la Sicilia non avventurata come quella di Pisacane in Sapri. Gli errori di una volta si correggono con la esperienza. Pisacane si ebbe fatto avventurare su la semplice fede di corrispondenze che promettevano trovarsi pronti aiuti, e soccorsi. Garantia solida e non dubbia si perci richiesta dalla Sicilia pria di far muovere Garibaldi; e da qui surse la necessit per Palermo di manifestarsi, di compromettersi, pria di avere i soccorsi concertati e promessi, come ha anticipato col suo movimento rivoluzionario de' 4 aprile.Cfr. CRONACA DEGLI AVVENIMENTI DI SICILIA- Da' 4 aprile a' principii d'agosto 1860 con l'aggiunta de' fatti posteriori fino a marzo 1861 - ESTRATTA DA DOCUMENTI, Italia, 1863, pag. 82 - https://www.eleaml.org.
(150) Al di fuori degli studi su Pisacane, Enrichetta stata ignorata dagli storici. Eppure svolse un ruolo di rilievo nella Repubblica Romana, in cui, insieme a Cristina di Belgioioso e ad altre patriote, organizz i soccorsi ai feriti. Documenti emersi di recente sembrano indicare anche una sua posizione di responsabilit nellamministrazione finanziaria del governo repubblicano . Partecip con la sua ambulanza alla battaglia di Porta San Pancrazio, che descrisse con toni commossi in quello che sembra essere stato il suo unico scritto pubblico, sul Monitore romano. Mazziniana, partecip alle riunioni pi riservate, come quella in cui si decise la spedizione di Sapri, contro la quale dispieg tutta la sua influenza e i suoi serrati ragionamenti, riuscendo solo a ritardarla.Cfr. Relazioni epistolari di Enrichetta di Lorenzo, in Scritture femminili e Storia, LAURA GUIDI, Napoli, ClioPress, 2004, pag. 239.
(151) Cfr. Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015.
(152) “Ora, sperimentai, udii e vidi cogli occhi miei com'è fatta la italianità e la lealtà politica di U. Rattazzi. Dunque.… Osservo. U. Rattazzi sapeva tutto punto per punto ciò che si stava allestendo per la impresa di Sapri. Ora perchè non provvide acciocchè tanto tesoro d' ingegno e di sangue italiano non andasse a perdersi miseramente? Difettava di mezzi per avventura? Il Pisacane, quantunque differisce di fede dall'assoluta maggioranza de' profughi politici veri o falsi delle Due Sicilie, pure tutti lo stima-vano ed amavano; ed a tempo avriano saputo distoglierlo da un fine cotanto fatale se fossero stati confortati a farlo dal Ministro conscio del fine medesimo. No. Il Ministro italianissimo non vede partire una piccola porzione di cospiratori contro la tirannide per tornare Italia al suo perduto seggio di onore; e fa mettere le mani addosso ai complici loro andandoli a pigliare un per uno nelle loro case e facendoli anche arrestare per le vie di Genova, di Torino e pe' posti prossimani alla Liguria. Fortunati quelli ch'ebbero tempo di darsi al mare o d'involarsi al reame liberalone per inselvarsi nella schiava ed inospitale terra elvetica!…” Cfr. Vita di Urbano Rattazzi, CESARE PEROCCO, Stabilimento Tipografico de' fratelli De Angelis, Vico Pellegrini, 1867.
(153) Cfr. L'opera Politica del Conte di Cavour,ADOLFO OMODEO, V ol. III, Nuova Italia Editrice, 1945, pag. pag. 237.
(154) Cfr. “La polemica sulla spedizione di Sapri – Un aspetto della crisi del mazzinianesimo nel Mezzogiorno”, A. CAPONE, Rassegna Storica Salernitana, Anno XXVII (1966), pag. 79-96.
(155) Taluni sostengono che la diplomazia napolitana, nella vicenda del Cagliari, dimostrò tutta la sua inconsistenza, noi pensiamo che il Regno delle Due Sicilie fosse un vaso di coccio tra vasi di ferro. La sua posizione al centro del Mediterraneo lo esponeva agli interessi delle potenze dall'epoca: Inghilterra, Francia, Austria, Russia, Stati Uniti. Questo ovviamente non lo assolve da errori:
“Da prima l'Inghilterra parve disposta a far causa comune con la Sardegna e anzi la invitò a risentirsi, ma poi, insufflata dall'Austria, mutò contegno, e forse avrebbe dato ragione al re di Napoli, se egli avesse francamente posta la questione sul terreno politico, imputando al governo sardo la connivenza con la spedizione Pisacane e chiedendogli, a sua volta, ragione e indennizzo per il violato diritto delle gentil e per i danni recati al reame. Ma re Ferdinando si ostinò a voler mantenuta la controversia nei confini giuridici; nel che gli dettero torto i migliori pubblicisti europei. Talché il governo inglese dové unire le sue proteste a quelle sarde, e al re di Napoli toccò cedere, rendere il piroscafo, liberare i carcerati e indennizzare questi ei proprietari di esso.” Cfr. Storia Politica d'Italia - Il Risorgimento Italiano (1849-1860), AGOSTINO GORI, Casa Editrice Francesco Vallardi, Milano, 1903, pag. 215.
“Lo sbarco degli insorti era la conferma di come “l’acqua salata e l’acqua santa” (le frontiere del Regno erano quasi tutte marittime, a esclusione di quella con lo Stato Pontificio) non bastassero più a garantire la sicurezza del Regno. La lunga controversia sulla restituzione del piroscafo Cagliari non fece che provocare un nuovo scontro con la diplomazia inglese, conclusasi per di più con l’umiliante pagamento di 3.000 sterline di indennizzo alla Gran Bretagna”. Cfr. Patrioti o traditori? Gli ufficiali della Marina napoletana nella crisi e fine delle Due Sicilie, MICHELE LACRIOLA, Collana Scientifica dell’Università di Salerno, Rubbettino Editore, 2021, pag. 59.
(156) Cfr. Correspondence respecting the Cagliari, Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, 1858, London:Printed by Harrison and Sons.
(157) La narrazione dell’impresa del Pisacane, dopo la guerra civile (o di resistenza, se preferite) passata alla storia come “brigantaggio”, seguì la stessa sorte di ogni altro avvenimento accaduto nelle Provincie Napolitane, prima e dopo l'unificazione. L’avvenimento viene descritto come accaduto in un non luogo, fuori dalla storia e dalla civiltà.
“Sanza offrì lo spettacolo di una scena africana.” scrive Brangi (Cfr. I moribondi di Montecitorio, LUIGI BRANGI, L. Roux E C. Editori Roma-Torino-Napoli, 1889.).
Da qui al “Se vogliamo che tutto rimanga com’è...”, al “Cristo si è fermato a Eboli” per giungere alla descrizione di Napoli, ex-capitale del Regno delle Due Sicilie, come di “una città orientale senza un quartiere occidentale” il passo è breve.
(158) Cfr. Giuseppe Fanelli, https://www.treccani.it/ .
(159) Cfr. Lettera di Giuseppe Fanelli a Carlo Pisacane, datata Napoli 10 febbraio 1857 in Il Risorgimento Italiano, Rivista Storica diretta da T. PALAMENGHI CRISPI, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1914, pag.328-330
(160) Nella vostra dei 19 mi dite pare che fondate su di un disbarco in Cilento, sarebbe meglio Basilicata. In nome di Dio abolite i condizionali, io dico Cilento perch cos mi hanno suggerito le notizie da voi fornite; ma tale scelta assolutamente subordinata alla vostra volont; voi avreste dovuto dirmi; no Cilento non vale, bisogna attenersi a Basilicata ed indicarmi la spiaggia, e questa vostra determinazione era dipendente solo dalla condizione delle cose a voi nota, e quindi avreste potuto scrivermelo recisamente.Cfr. Cronaca del Comitato Segreto di Napoli su La Spedizione di Sapri, LUIGI DE MONTE, Napoli, Stamperia del Fibreno Strada, Trinit Maggiore, 1877. pag, LIII.
(161) Nella lettera scritta dal Comitato di Napoli a Mazzini il 26 marzo 1857, Kilburn (Fanelli) scriveva: Ho dati a Carlo schiarimenti su Ponza, appena ne avr altri glieli dar pure.Cfr. Cronaca del Comitato Segreto di Napoli su La Spedizione di Sapri, LUIGI DE MONTE, Napoli, Stamperia del Fibreno Strada, Trinit Maggiore, 1877. pag, LII.
(162) “I patrioti lucani si erano opposti al piano combinato a Londra e Genova, più che a Napoli e Montemurro. Nel 1857, fu una necessità per la nostra provincia evitare qualsiasi agitazione.” Cfr. IL LUCANO, nel Cinquantenario della Rivoluzione Lucana, Tipografia Editrice Garramone e Marchesiello, Potenza, 1910, pag. 5.
“La Basilicata era nel 1857 pronta ad insorgere. Duemila lucani avrebbero dato la loro vita, sulle coste del Tirreno, con l'eroico drappello capitanato da Pisacane e Nicotera «se i lontani architettori dell'impresa non fossero giunti inattesi, ignorati, senza armi e prima del promesso e non dato o non giunto motto d'ordine».
Ben a ragione G. Albini scrisse:
D'uomini o fati error fu quello stolto
Zel di silenzio, onde tuttor si langue?
Dirallo il tempo A me non tinge il volto
Di Sapri il sangue.”
Cfr. IL LUCANO, nel Cinquantenario della Rivoluzione Lucana, Tipografia Editrice Garramone e Marchesiello, Potenza, 1910, pag. 10.
(163) «Dirò, con l'autorità del chiarissimo patriota e storico lucano, Giacomo Racioppi, che «se il moto (cosi egli) avesse durato ancora alquanti giorni; se fosse Pisacane venuto direttamente in Basilicata cansando gli scontri per via; o se piuttosto al centro della congiura di Basilicata, che era a Montemurro, si fosse data notizia certa del luogo dello sbarco, del giorno e del disegno; e il disegno in qualche modo convenuto con essi che avevano a cooperarvi; la Basilicata senza dubbio rispondeva con suoi movimenti.» Cfr. La spedizione di Sapri e la provincia di Basilicata, DECIO ALBINI, Roma tipografia delle Terme Diocleziane, 1891, pag. 23.
(164) Cfr. Nel Mezzogiorno di epoca unitaria - Per una biografia politica di Giacomo Racioppi (1827-1908), DOMENICO MORLINO, Università degli Studi di Milano, Scuola di Dottorato Humanae Litterae Dipartimento Studi Storici, A. A. 2012-2013.
(165) Cfr. Lettera, datata Napoli 26 aprile 1857, del Comitato a G. Albini, in PER GIACINTO ALBINI Ricordi biografici e storici, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1887, Pag. 64.
(166) Cfr. La insurrezione della Basilicata e del barese nel 1860, PAOLO GIANCASPRO - Opera postuma pubblicata per cura del nipote Gaetano Giancaspro, Trani, V. Vecchi, Tipografo Editore, 1890, pag. 57.
(167) Cfr. La insurrezione della Basilicata e del barese nel 1860, PAOLO GIANCASPRO - Opera postuma pubblicata per cura del nipote Gaetano Giancaspro, Trani, V. Vecchi, Tipografo Editore, 1890, pag. 112.
(168) “Frotte di giornalisti giungono a giugno da ogni angolo d’Europa, persino dagli Stati Uniti, a testimoniare che anche la Sicilia è stata scossa dallo spirito del tempo, dal vento della rivoluzione che impronta di sé il XIX secolo. Quella che viene combattuta nel 1860 in Sicilia è la prima guerra che coinvolge l’opinione pubblica internazionale, e dunque uno dei primi eventi mediatici della storia italiana. Era stata la guerra di Crimea del 1853-1855 a inaugurare l’idillio tra missioni militari e giornalismo, e l’esistenza di una comunità di lettori che pretendeva di essere informata a mezzo stampa sulle attività dei propri governi era ormai da decenni un dato di fatto che solo gli Stati d’ancien régime, Regno delle Due Sicilie in testa, si ostinavano a ignorare.” Cfr. Memorie contro. Vinti e vincitori raccontano Milazzo, CHIARA MARIA PULVIRENTI, Studi Storici - Anno 52, N. 2 (Aprile-Giugno 2011), pp. 373-391 - Fondazione Istituto Gramsci, Pag. 373.
(169) “Nicotera prima è trasportato al convento dei Minori Osservanti, poi a Buonabitacolo, e finalmente a Salerno, ove è processato e condannato a morte. Per istanza del governo inglese, gli è commutata la pena di morte nella galera a vita. È trasportato alla Favignana con trenta libbre di ferro al piede. Nel 1860 le porte delle prigioni di Favignana si aprono, e Nicotera ricupera la libertà.” Cfr. Gli uomini del mio tempo, DOMENICO GALATI, Bologna, Nicola Zanichelli, 1879, pag. 113.
(170) “Come d’accordo, il 27 Mazzini preannunciò telegraficamente a Fanelli lo sbarco di Pisacane. Ma Fanelli e gli altri congiurati, prima di muoversi, vollero sapere come era stato accolto dalla popolazione. Era l’eterna storia delle insurrezioni italiane che non scoppiavano mai perché ognuno aspettava l’iniziativa dell’altro e il suo successo.” Cfr. L'Italia del Risorgimento – 1831-1861, INDRO MONTANELLI, MARIO CERVI, Rizzoli Editore, Milano, 1972.
(171) Cfr. «La spedizione di Sapri e il Comitato di Napoli – Al generale Garibaldi, relazione di Nicola Fabrizi», Napoli, 1864.
(172) Cfr. Nicola Fabrizi and Maltese weapons in Sicily during the Spedizione dei Mille di ARNOLD CASSOLA, Periodico bimestrale dell'Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, Pubblicato il 1 luglio 2021, https://www.istitutoeuroarabo.it/
(173) “Qui e altrove in queste lettere si allude a un deposito di fucili fatto in Malta, all’ordine di N. Fabrizj, con denaro raccolto da Mazzini. La maggior parte di quelle armi, circa 700, non potuta introdurre né in Sicilia, né nelle provincie napoletane, fu dal Fabrizj sbarcata a Pozzallo in giugno 1860.” Cfr. NOTA ad una lettera di Rosolino Pilo a Nicola Fabrizj del 18 settembre 1855 in Il Risorgimento Italiano, Rivista Storica diretta da T. PALAMENGHI CRISPI, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1914, pag. 352.
(174) Cfr. “NOTE INTORNO ALLA BIOGRAFIA DI CARLO PISACANE” di LEOPOLDO CASSESE, Estratto da: Rassegna storica del Risorgimento, A. 23., fasc. 6, giugno 1936 – https://www.liberabit.unisa.it/ .
(175) “Prevedendo il disastro, Enrichetta scongiurò il suo compagno di rinunciare e, non riuscendovi, lo convinse a fare un sopralluogo a Napoli, nella speranza che si rendesse conto dell’assurdità dell’impresa. Pisacane se ne rese conto, ma non rinunciò. Rientrato a Genova dopo quattro giorni di colloqui con Fanelli e altri congiurati, consultò Mazzini e con lui decise di tentare ugualmente.” Cfr. L'Italia del Risorgimento – 1831-1861, INDRO MONTANELLI, MARIO CERVI, Rizzoli Editore, Milano, 1972.
(176) Cfr. Relazioni epistolari di Enrichetta di Lorenzo, in Scritture femminili e Storia, LAURA GUIDI, Napoli, ClioPress, 2004, pag. 239.
(177) “Un mio egregio scolaro del R. Istituto tecnico di Genova, pronipote di Giuseppe Daneri, che condusse a Ponza e a Sapri la spedizione Pisacane, mi ha comunicato e permesso di trascrivere— col consenso, s'intende, dei genitori — la copia che la sua famiglia possiede della narrazione, intorno alla spedizione stessa,dettata dal Daneri e non mai data alle stampe. L'originale è in mano d'altro congiunto del Daneri e una seconda copia di esso pare sia posseduta da un signor F. G. L. che nel Secolo XIX del 23 giugno dell'anno scorso si qualifica «testimonio di quei tempi,e pubblica nell'effemeride genovese alcuni particolari della spedizione Pisacane, rilevandoli, egli dice, da un quaderno di ricordi del capitano del Cagliari».
Qui io pubblico le parti più importanti di essa narrazione, soltanto omettendo talvolta, e tal-volta accennando in nota, giudizi del Daneri su uomini e cose che i congiunti suoi ed io stesso non abbiamo creduto sia opportuno riferire integralmente, tanto più che alcuni apprezzamenti riguardano fatti posteriori ed estranei alla spedizione, ed alcuni altri rivelano che il Daneri non sempre fu informato appieno dell'aggrovigliato lavorìo di cospirazione e di certi avvenimenti che prepararono e resero direi quasi necessaria la spedizione stessa, sulla quale hanno poi sparsa nuova luce numerose pubblicazioni, specialmente la ben nota e più recente del Bilotti.” Cfr. La Spedizione di Sapri narrata dal Capitano Giuseppe Daneri comandante del Cagliari, in Il Risorgimento Italiano, Rivista Storica, Anno IV, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1911, pag. 160.
(178) Cfr. La Spedizione di Sapri narrata dal Capitano Giuseppe Daneri comandante del Cagliari, in Il Risorgimento Italiano, Rivista Storica, Anno IV, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1911, pag. 160-188.
(179) Cfr. L'Italia del Risorgimento – 1831-1861, INDRO MONTANELLI, MARIO CERVI, Rizzoli Editore, Milano, 1972.
(180) Cfr. Cronaca del comitato segreto di Napoli su la spedizione di Sapri, LUIGI DE MONTE, Napoli, Stamperia del Fibreno,1877, pag. VIII.
(181) Cfr. “La polemica sulla spedizione di Sapri – Un aspetto della crisi del mazzinianesimo nel Mezzogiorno”, A. CAPONE, Rassegna Storica Salernitana, Anno XXVII (1966), pagg.79-97.
(182) Mentre scrivevo queste righe mi è giunta una sconsolata segnalazione da un amico del Principato Citeriore: Svimez, allarme demografico: entro il 2080 il Sud perderà 8 milioni di abitanti (lacnews24.it)
(183) Una carriera, quella di Crispi, emblematica: da bombarolo nell’agosto 1859 a capo del governo italiano nell’agosto del 1887!
“21 agosto. — Andiamo in campagna, in un fondo di Salvatore Cappello, in contrada Ciaculli. Là facciamo i modelli delle bombe e do le istruzioni necessarie per confezionarle. Le bombe sono di forma ovale e di varie grandezze. Ogni bomba, divisa nel mezzo, è di due parti uguali, le quali, congiunte e strette da una vite alle due estremità, combaciano perfettamente. Si riempie di polvere ordinaria, ed è tutta all’intorno munita di luminelli, ai quali si attaccano i cappellotti (capsule). Gittata sui lastrici, da qualunque parte cada, il cappellotto n’è percosso, e la scintilla del fulminante si comunica alla polvere, accesa la quale, la bomba scoppia, va in ischeggie e ne sono feriti quanti trovansi vicini.
Mazzini ne ha fatto costruire di piccola dimensione, in guisa da potersi da lontano lanciare con le frombole contro il nemico. Il piano della insurrezione è questo: siccome il 4 ottobre deve festeggiarsi l’onomastico del re e le truppe debbono uscire dai quartieri e recarsi al Foro Borbonico per la rivista, bisogna impedirne il ritorno.
Cinquanta dei più animosi dei nostri debbono assalire con le bombe i soldati, appena rientrati da Porta Felice. Sgominati i soldati da questo nuovo genere di armi, che certamente non si attendono, debbono avanzarsi gli altri insorti coi fucili. Nel disordine che ne deriverà bisognerà preparare le barricate.” Cfr. Scritti e discorsi politici (1849-1890), FRANCESCO CRISPI, Unione Cooperativa Editrice, Roma, 1890, pag. 243.
(184) Un interventista radical democratico, il Salvemini, che si rifaceva al partito d’azione e al mito del completamento del Risorgimento. In perfetta sintonia col Mazzini che, dopo il 1861, si disinteressò della tragedia che si consumava nelle Provincie Napolitane (non importa come la chiamiate, brigantaggio, guerra civile o guerra di resistenza) – fino al punto da chiedere che quelle provincie venissero consegnate al controllo di 100 mila uomini della Guardia Nazionale, in modo da utilizzare altrove i reparti dell’esercito.
«Non dite – così terminava il suo articolo il Mazzini – che gran parte dell'esercito vi occorre nel mezzogiorno. Mobilizzate centomila uomini di guardia nazionale, e affidate loro la guardia delle città e delle fortezze. Ordinate, come spesso dicemmo, il paese stesso a difesa contro i masnadieri; costituite Comitati locali composti di uomini energici ajutati da voi d'armi e di danaro, e non temete....». Cfr. La Rassegna Nazionale, Vol. XII. Anno V. Firenze, presso l'uffizio del Periodico, Via Faenza, 68, 1883, pag. 11.
(185) “Fu proprio l’infelice iniziativa di Pisacane a diventare l’occasione che Cavour aspettava per spingere gli emigrati a diventare strumenti principali di propaganda della sua politica. Sollecitò quelli a lui più vicini, come Giuseppe Massari, a firmare una protesta contro la sanguinosa spedizione.” Cfr. La Nazione Napoletana, GIGI DI FIORE, De Agostini Libri S.p.A., Novara, 2015,
(186) Cfr. Daniele Manin e Giorgio Pallavicino - Epistolario politico (1855-1857), con note e documenti per B. E. MAINERI, Milano, Tipografia Editrice di L. Bortolotti e C., 1878, pag. 502.
(187) Cfr. Partito Nazionale Italiano - Scritti Politici di GIORGIO PALLAVICINO, pubblicati nei giornali d'Italia, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice,1856, pag. 1-4.
(188) Cfr. Del rinnovamento civile d'Italia, VINCENZO GIOBERTI, Tomo 2, Parigi-Torino a spese di Giuseppe Bocca libraio di S. S. R. M Chamerot, Rue du Jardinet, 13 - 1851, pag. 234.
(189) Cfr. MEMORIE DI GIORGIO PALLAVICINO, pubblicate per cura della figlia, Volume Terzo - dal 1852 al 1860, Roux Frassati e Co, Editori, Torino, 1895, pag. 404.
(190) Cfr. Daniele Manin, MICHELE GOTTARDI, Dizionario Biografico degli Italiani - https://www.treccani.it/.
(191) Cfr. Partito Nazionale Italiano - Scritti Politici di GIORGIO PALLAVICINO, pubblicati nei giornali d'Italia, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice,1856, pag. 1-4.
(192) Cfr. Partito Nazionale Italiano - Scritti Politici di GIORGIO PALLAVICINO, pubblicati nei giornali d'Italia, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice,1856, pag. 1-4.
(193) Cfr. MEMORIE DI GIORGIO PALLAVICINO, pubblicate per cura della figlia, Volume Terzo - dal 1852 al 1860, Roux Frassati e Co, Editori, Torino, 1895, pag. 626.
(194) “E fu il Pallavicino chiamato a Caserta, dove il dittatore stava a campo. Quivi, a di 11 ottobre, si fece lunga ed aspra discussione. Tutti erano per l'assemblea: solo il Pallavicino d'accordo con i ministri, salvo il Crispi, la qualificava di «tradimento dell'unità nazionale» e gli oppositori buccinavano lui Cavouriano. Capi di costoro erano Mazzini e Cattaneo. Allora il Pallavicino rinunziò alla prodittatura. Tornato a Napoli la sera dello stesso giorno, vi trovò il popolo sommamente commosso.” Cfr. MEMORIE DI GIORGIO PALLAVICINO, pubblicate per cura della moglie, Volume Primo - dal 1852 al 1860, Roux Frassati e Co, Editori, Torino, 1895, pag. XXVII.
(195) Si conoscono le cose. Il buon genio di Garibaldi, sempre propizio all'Italia nei gravi cimenti, e il volere del popolo diedero ragione alla fermezza del Prodittatore che, combattendo ancora le ultime influenze avverse, il 21 ottobre pot assistere allo splendido risultamento del plebiscito, dovuto in gran parte (cosi gli scriveva il Cavour) al suo senno, alla sua fermezza ed al suo patriottismo.Cfr. Daniele Manin e Giorgio Pallavicino - Epistolario politico (1855-1857), con note e documenti per B. E. MAINERI, Milano, Tipografia Editrice di L. Bortolotti e C., 1878, pag. LXXXI
Nella stessa giornata dell’11 ottobre 1860 a Torino era stata votata la legge sulle annessioni delle nuove provincie, riportiamo dal resoconto stenografico:
“PRESIDENTE. [...] Leggo l'articolo unico della legge: «Il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per reali decreti l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio diretto universale, la volontà delle popolazioni di far parte integrante alla nostra Monarchia costituzionale.»
Se nessuno chiede di parlare, porrò ai voti quest'articolo. (La Camera approva all'unanimità) —(Nuovi prolungati applausi)” Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI — Sessione del 1860 - Tornata dell'11 Ottobre 1860 - Presidenza del Presidente Lanza, https://storia.camera.it/ .
Nella giornata seguente, 12 ottobre 1860, a Torino fu votata la legge sulle annessioni delle nuove provincie, riportiamo dal resoconto stenografico:
“PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. (È chiusa.)
Rileggerò l'articolo: «Articolo unico. È fatta facoltà al Governo del Re, tostochè sia attuata l'annessione allo Stato di altre Provincie d'Italia, di regolare con regii decreti le circoscrizioni dei collegi elettorali per modo che il numero dei deputati non sia mai minore di quattrocento, e che la cifra media degli abitanti presa a norma per formare le circoscrizioni non ecceda mai i cinquantamila.»
Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti. (La Camera approva.)” Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI — Sessione del 1860 - Tornata dell'12 Ottobre 1860 - Presidenza del Presidente Lanza, https://storia.camera.it/ .
(196) Cfr. ATTI OFFICIALI ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI, 1860 Num. 9. - Ottobre dall'8 al 9, pag. 97.
(197) Di assemblea parlavano anche Montanelli e Pallavicino, in uno scambio epistolare del novembre 1854, definendola a volte ASSEMBLEA UNIFICATRICE e altre volte ASSEMBLEA NAZIONALE, che avrebbe avuto il compito di conferire la corona d’Italia al re sabaudo, non appena raggiunta la indipendenza. Su tale assemblea Pallavicino esprimeva tutto il suo scetticismo: “Ma siete voi certi che da quest'Assemblea, sedicente unificatrice, uscirebbe la unione non la discordia?” Cfr. MEMORIE DI GIORGIO PALLAVICINO, pubblicate per cura della figlia, Volume Terzo - dal 1852 al 1860, Roux Frassati e Co, Editori, Torino, 1895, pag. 404.
Manin esponeva lucidamente la necessità di una assemblea nazionale anche in una lettera a Giorgio Pallavicino, scritta da Parigi il 12 agosto 1856:
“Non rispingo né adotto definitivamente le tue idee. Finché non mi sia dimostrato il contrario, persisto a credere inevitabile l'assemblea nazionale. Mi pare che tu sopprima uno stadio della rivoluzione, cioè l'intervallo fra la proclamazione del territorio insorto e l'accettazione del governo piemontese. Se non vi sarà intervallo, tanto meglio; ma mi pare impossibile che non vi sia.” Cfr. LETTERE di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino con note e documenti sulla Quistione Italiana, Torino, Unione Tipografico-Editrice, dicembre 1859, pag. 65.
(198) A riprova del del fatto che l’unificazione sognata da Manin lasciava il posto alla unità sabauda fu sancita dalla conservazione della numerazione dinastica di Vittorio Emanuele II:
“La legge, promulgata il 17 marzo 1861, è la seguente:
Vittorio Emanuele II, per Grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca Di Savoia, di Genova, Ecc., Ecc., Ecc., Principe di Piemonte, Ecc., Ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e pei suoi successori il titolo di Re d’Italia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti dal Governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino addì 17 marzo 1861
Vittorio Emanuele
C. Cavour. M. Fanti.
M. Minghetti. T. Mamiani.
G. B. Cassinis. T. Corsi.
F. S. Vegezzi. U. Peruzzi”
Cfr. Regno d’Italia. Statuto Fondamentale del Regno in data 4 marzo 1848, corredato di Lettere Patenti, Decreti, Proclami, Plebisciti con intestazioni degli atti di governo e formola per la promulgazione delle Leggi, Torino 1884, p. 27.
(199) “E infatti, mentre sui primi del '47 Pisacane è ancora un napoletano qualunque, alieno dalle cose politiche e tutt'al più, come ufficiale, voglioso di complicazioni europee per avere finalmente occasione di smettere la monotona vita di guarnigione, e di provare, coi rischi, l'ebbrezza di una guerra, sui primi del '48 egli è già un fervido patriota «italiano», con idee sue, fisime sue, programmi suoi.” Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 18.
(200) Cfr. Der Krieg in Italien 1848-1849. Von CARLO PISACANE. Aus dem Italienischen von A. Cloßmann. Mit zwei lithographirten Karten. Chur, Druck und Verlag von Leonh. Hiß. 1852.
(201) Cfr. Carlo Pisacane e la nazione armata, F. Vairo, «Nuova Rivista di Fanteria», 1910.
(202) Cfr. Sul pensiero militare di Carlo Pisacane, LUIGI DERLA, Belfagor, Vol. 32, No. 2 (31 MARZO 1977), Casa Editrice Leo S. Olschki.
(203) Cfr. Carlo Pisacane teorico militare, VINCENZO GALLINARI, Ufficio Storico SME - Roma 1981.
(204) Cfr. Cenni sulla rivoluzione italiana del 1860, DEMETRIO SALAZARO, Napoli, Stabilimento Tipografico di R. Ghio In S. Teresa agli Studi, 1866, pag. 122.
(205) Cfr. Benedetto Musolino, GIUSEPPE BERTI, Studi Storici, Rivista trimestrale, Anno I 1959-60 n. 4, luglio-settembre 1960, Istituto Gramsci Editore.
(206) Cfr. Giudizi d’un esule su figure e fatti del risorgimento” di IVANO RAULICH - Il Risorgimento Italiano - Rivista Storica (organo della “società nazionale per la storia del risorgimento italiano”), diretta dal prof. BENIAMINO MANZONE, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1908, pag. 456.
(207) Cfr. L'opera Politica del Conte di Cavour,ADOLFO OMODEO, V ol. III, Nuova Italia Editrice, 1945, pag. pag. 237.
(208) Cfr. Benedetto Musolino, GIUSEPPE BERTI, Studi Storici, Rivista trimestrale, Anno I 1959-60 n. 4, luglio-settembre 1960, Istituto Gramsci Editore.
(209) Non condividiamo affatto questo benevolo giudizio, che dimostra il credito di cui godeva il Fabrizj nella rete dei cospiratori e lo scarso discernimento che caratterizzava Pisacane nel valutare persone che incontrava.
(210) Cfr. L'opera Politica del Conte di Cavour,ADOLFO OMODEO, V ol. III, Nuova Italia Editrice, 1945, pag. pag. 237.
(211) Cfr. Giudizi d’un esule su figure e fatti del risorgimento” di IVANO RAULICH - Il Risorgimento Italiano - Rivista Storica (organo della “società nazionale per la storia del risorgimento italiano”), diretta dal prof. BENIAMINO MANZONE, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1908, pag. 456.
(212) “6 marzo 1857 - Fratello Voi per la prima volta mi proponete un'operazione definita, concreta, pratica: com'è debito e impulso del core l'accetto: me n'occupo subito, e sarà fatta. Sia nota a pochi, a nessuno se possibile; ogni cosa dipende dal segreto. Non avete bisogno per preparare che di annunziare qualche cosa che darà l'impulso. Date all'amico, il quale trasmette la vostra per me, ogni ragguaglio su Ponza. È essenziale.” Cfr. Cronaca del Comitato Segreto di Napoli su la spedizione di Sapri, LUIGI DE MONTE, Napoli Stamperia Del Fibreno, Strada Trinità Maggiore, 26 1877, pag. XIX.
(213) “Il piano architettato con il Fanelli prevedeva la liberazione dei prigionieri politici detenuti sull'isola di Ponza, per poi continuare il viaggio con essi fino ad una zona a sud di Napoli. Il 16 aprile, il Fanelli scrive al Mazzini a Londra che gli occorrono almeno altre sei settimane di tempo per stabilire una relazione sull'isola di Ponza. La data della rivoluzione viene fissata prima per il 25 maggio, poi per il 10 giugno. Tuttavia il piano, che doveva restare segreto, diventa il segreto di Pulcinella. Le autorità delle Province site sulle coste siciliane e l'Intendente di Salerno infatti erano già stati preavvisati dell'imminente sbarco. La giovane corrispondente inglese del The Daily News, miss Jessie White, fulva beniamina dei liberali, cerca di convincere il Garibaldi a prendere parte alla spedizione, ma ogni suo sforzo risulta nullo.” Cfr. Enrichetta di Lorenzo - storia di una famiglia, ALESSANDRO DI LORENZO, Istituto di Studi Atellani, 2012, pag. 68, http://www.iststudiatell.org/ .
(214) Prima di porre in atto la designata spedizione, il Pisacane tenne molte corrispondenze col Mazzini, col Fabrizii, col Fanelli e col Dragone, pubblicate da Luigi de Monte nella sua Cronaca; e poi, sfidando gravi pericoli, venne nel 13 giugno in Napoli, onde coi capi di sua parte fosse fermato che contemporaneamente allo sbarco sulle coste del Salernitano avvenisse nella capitale rumorosa agitazione. In casa di Luigi Dragone, ove il Pisacane tenevasi celato, convennero la sera del 15 giugno Giuseppe Fanelli, Giuseppe Lazzaro, Teodoro Pateras, Giovanni Matina, Antonio Rizzo, Luigi Fittipaldi, Raffaele Basile e Giuseppe e Mata, e fu fissato che, arrivando a quest'ultimo un telegramma da Genova con ordinativo di cappelli, l'agitazione comincerebbe, e sarebbe spedito corriere ai fratelli Magnone di Rotino per operare il movimento nel Cilento.
Cfr. li ultimi trentasei anni del eame di apoli (1824-1860)- Francesco I, Vol. I, NICCOLA NISCO, av. Antonio orano ditore, . Sebastiano, Napoli 894, pag. 452.
(215) “Pisacane grida più volte la parola d'ordine «l'Italia agli Italiani», ma dalla casetta bianca dove, secondo gli accordi presi con il Fanelli, si sarebbero dovuti trovare gli emissari del Comitato di Napoli, non giunge alcuna risposta. Dopo aver sparato qualche colpo di fucile a titolo puramente simbolico, la guardia urbana di Sapri si dà alla fuga. Il 29 la spedizione abbandona Sapri e si dirige verso Torraca, dove si celebrava la festa di San Pietro e Paolo. Alcuni, vedendoli, gridano "Viva Murat" fraternizzano con i rivoluzionari. Carlo, pur avendo letto un proclama per incitare le folle a seguirlo, deve constatare amaramente che nessuno vuole aderire al proclama.” Cfr. Enrichetta di Lorenzo storia di una famiglia, di ALESSANDRO DI LORENZO, seconda edizione, Tipolitografia «DEL PRETE», Frattaminore (Napoli), pag. 69.
(216) Cfr. Il Risorgimento, ANTONIO GRAMSCI, a cura di Valentino Gerratana, Roma, Editori riuniti, 1996, pag. 72-73.
(217) “Nel giugno-luglio '52 si trattenne per qualche settimana a Genova il celebre rivoluzionario russo Alessandro Herzen:150 era intimo di Medici, legato a molti altri emigrati italiani da lui già conosciuti nel '49 in Isvizzera. Vide assai spesso Pisacane col quale discusse a fondo della situazione napoletana e, verosimilmente, del problema sociale. Herzen, che tra gli amici italiani si trovava a tutto suo agio e che ne ammirava sinceramente le istintive doti rivoluzionarie, scrisse più tardi in termini di vero entusiasmo per Pisacane.” Cfr. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927, pag. 79.
(218) I mazziniani avrebbero appoggiato nell’estate del 1860 la “prodigiosa” avanzata di Garibaldi, in ossequio alla posizione che il loro maestro Mazzini aveva assunto in un messaggio ai siciliani il 2 marzo 1860:
«Prima di tutto io ripeto a voi ciò che stampiamo da oramai due anni: non si tratta più di republica odi monarchia: si tratta di unità nazionale – d'essere o non essere – di rimanere smembrati e schiavi della volontà di una despota straniero,francese o austriaco non monta, o di essere noi, di esser uomini, di esser liberi. Se l'Italia vuol essere monarchia sotto Casa Savoja,sia pure. Ciò che tutti or vogliamo è che l'Italia si faccia».
Cfr. IL RISORGIMENTO ITALIANO,Rivista Storica diretta da T. Palamenghi–Crispi, Anno VII, Fasc. IV. Luglio-Agosto, 1914, pag. 558-559.
«Ripeto a voi ciò che stampiamo da ormai due anni. Non si tratta più di repubblica o di monarchia:si tratta di unità nazionale d'essere, o non essere di rimanere smembrati e schiavi della volontà d'un despota straniero, francese o austriaco non monta, o d'esser noi, d'essere uomini, d'esser liberi, d'esser tenuti siccome tali, e non siccome fanciulli tentennanti, inesperti, da tutta Europa. Se l'Italia vuole esser monarchia sotto casa Savoia, sia pure. Se dopo vuole acclamare liberatore e non so che altro il Re e Cavour, sia pure. Ciò che tutti or vogliamo è che l'Italia si faccia.»
Cfr. Repubblica e Monarchia - A Giuseppe Mazzini, lettera di Francesco Crispi, deputato, Tipografia V. Vercellino Dora Grossa, 33, Torino 1865, pag. 21.
Se si cerca, col lanternino e senza paraocchi, nelle ricostruzioni storiche patriottarde si trovano delle “licenze” nel riportare le citazioni, da far impallidire la cosiddetta libellistica borbonica.
BIBLIOGRAFIA
Alcuni dei titoli appresso elencati, coperti da copyright, si trovano in rete e possono essere letti o consultati, spesso anche scaricati in formato pdf. Vi invitiamo a consultare sempre gli originali in caso di pubblicazioni o di tesi- e a citare con cura la fonte.
- Cavour e la scommessa italiana, ROBERTO MARTUCCI, Quaderni costituzionali, Nº 2, 2012,.
- Il racconto di una metamorfosi Dalle lettere di Carlo Pisacane al fratello Filippo 1847-1855, ERNESTO MARIA PISACANE, Artetetra, Napoli, 2015,.
- Enrichetta di Lorenzo storia di una famiglia, di ALESSANDRO DI LORENZO, seconda edizione, Tipolitografia DEL PRETE», Frattaminore (Napoli).
- I presupposti della spedizione di Pisacane e la realtà del regno borbonico, MASSIMO NARDINI, Storia e Politica, X n. 1, 2018.
- L'opera Politica del Conte di Cavour, ADOLFO OMODEO, Vol. III, Nuova Italia Editrice, 1945.
- La polemica sulla spedizione di Sapri – Un aspetto della crisi del mazzinianesimo nel Mezzogiorno, A. CAPONE, Rassegna Storica Salernitana, Anno XXVII.
- L'Italia del Risorgimento – 1831-1861, INDRO MONTANELLI, MARIO CERVI, Rizzoli Editore, Milano, 1972.
- Cavour e il suo tempo (4-1861), ROSARIO ROMEO, vol. 3°, Gius. Laterza & Figli, 2012.
- Relazioni epistolari di Enrichetta di Lorenzo, in Scritture femminili e Storia, LAURA GUIDI, Napoli, ClioPress, 2004.
- Epistolario, a cura di ALDO ROMANO, Società anonima editrice Dante Alighieri, Milano-Genova, 1937.
- Benedetto Musolino, GIUSEPPE BERTI, Studi Storici, Rivista trimestrale, Anno I 1959-60 n. 4, luglio-settembre 1960, Istituto Gramsci Editore.
- Carlo e Filippo Pisacane. Un conflitto civile privato» nel Mezzogiorno borbonico di SILVIA SONETTI, in MERIDIANA, N 81,Viella, Via delle Alpi, Roma, 2014.
- Ippolito, Ercole e Oliphant nella spedizione dei mille di GIUSEPPE ESPOSITO, https://www.fattiperlastoria.it - 15 Novembre 2023.
- L’altra guerra di Crimea di DAVIDE MARIA DE LUCA, 2014 https://www.ilpost.it/.
- L'emigrazione politica in Piemonte nel decennio pre unitario, G. B. FURIOZZI, Firenze, 1979.
- La Nazione Napoletana, GIGI DI FIORE, De Agostini Libri S.p.A., Novara, 2015.
- Gli ideali del Risorgimento e dell'Unità, Antologia a cura di Giuseppe Talamo, Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche, 1961.
- Lord Palmerston and the Secret Service Fund, Gavin B. Henderson, The English Historical Review, Vol. 53, No. 211 (Jul., 1938), https://www.jstor.org/
- Memorie contro. Vinti e vincitori raccontano Milazzo, CHIARA MARIA PULVIRENTI, Studi Storici - Anno 52, N. 2 (Aprile-Giugno 2011), pp. 373-391 - Fondazione Istituto Gramsci.
- Nel Mezzogiorno di epoca unitaria - Per una biografia politica di Giacomo Racioppi (1908), DOMENICO MORLINO, Università degli Studi di Milano, Scuola di Dottorato Humanae Litterae Dipartimento Studi Storici, A. A. 2012-2013.
- Nello Rosselli e la valenza del sacrificio di Carlo Pisacane di ANGELO MARTINO - https://www.angelomartino.it/nello-rosselli-e-la-valenza-del-sacrificio-di-carlo-pisacane/ - 13 Novembre 2022.
- Nicola Fabrizi and Maltese weapons in Sicily during the Spedizione dei Mille di ARNOLD CASSOLA, Periodico bimestrale dell'Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, Pubblicato il 1 luglio 2021, https://www.istitutoeuroarabo.it/
- Patrioti o traditori? Gli ufficiali della Marina napoletana nella crisi e fine delle Due Sicilie, MICHELE LACRIOLA, Collana Scientifica dell’Università di Salerno, Rubbettino Editore, 2021.
- Pisacane proibito, EDOARDO VITALE, Golfonetwork, Villammare (Sa), 2021.
- Risorgimento rivoluzionario, PAUL GINSBORG, 9 Settembre 2020, https://www.vocedellasera.com/
- Spagna 1808: la genesi della guerriglia moderna. 2. Fenomenologia della guerriglia spagnola e suoi riflessi internazionali di VITTORIO SCOTTI DOUGLAS in “Spagna contemporanea”, 2001, n. 20.
- L'INVENZIONE DEL MEZZOGIORNO Una storia finanziaria, Nicola Zitara, Editore Jaca Book, 2011.
- Appunti sul codice cifrato delle lettere di Carlo Pisacane durante l'organizzazione della spedizione di Sapri, CONTILLI CRISTINA, Accademia.Edu – 2024.
Alcuni dei titoli appresso elencati, non coperti da copyright oppure di pubblico dominio, si trovano in rete e possono essere letti oppure scaricati, in genere in formato pdf. Vi invitiamo a consultare sempre gli originali in caso di pubblicazioni o di tesi.
- Agostino Bertani e i suoi tempi, JESSIE WHITE MARIO, Vol. II - Firenze, Tipografia di G. Barbera, 1888.
- Archivio storico siciliano, Pubblicazione periodica della Società Siciliana per la Storia Patria, Nuova Serie, Anno XXIV, Tipografia lo Statuto, Palermo 1899.
- Atti del Governo - Estratti dal Giornale Officiale di Napoli, dal 7 Settembre al 31 dicembre 1860.
- ATTO DI ACCUSA proposta dal Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Principato Citeriore contro Giovanni Nicotera ed altri molti detenuti imputati degli avvenimenti politici verificatisi in Ponza, Sapri, ed altri paesi del Distretto di Sala e Decisione emessa dalla G. C. su di essa, Dicembre 1857.
- Autobiography of Giuseppe Garibaldi, by Jessie White Mario, Vol. III, Supplement. Bern Walter Smith And Innes, 1889.
- Biografia di Giovanni Nicotera (estratto dalla Storia del Parlamento Italiano), Vol. III, Matteo Augusto Mauro, Nocera Inferiore, Tipografia Editrice della Vesuviana, 1886.
- Carlo Pisacane e Giovanni Nicotera, o La spedizione di Sapri, FELICE VENOSTA, Barbini Editore, Milano, 1876.
- Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, NELLO ROSSELLI, Torino, Fratelli Bocca – Editori, 1927.
- Cenni sulla rivoluzione italiana del 1860, DEMETRIO SALAZARO, Napoli, Stabilimento Tipografico di R. Ghio In S. Teresa agli Studi, 1866.
- Correspondence respecting the Cagliari, Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, 1858, London:Printed by Harrison and Sons.
- CRONACA DEGLI AVVENIMENTI DI SICILIA - Da' 4 aprile a' principii d'agosto 1860 con l'aggiunta de' fatti posteriori fino a marzo 1861 - ESTRATTA DA DOCUMENTI, Italia, 1863 - https://www.eleaml.org/.
- Cronaca del Comitato Segreto di Napoli su La Spedizione di Sapri, LUIGI DE MONTE, Napoli, Stamperia del Fibreno Strada, Trinità Maggiore, 1877.
- Daniele Manin MEMORIE DI GIORGIO PALLAVICINO, pubblicate per cura della figlia, Volume Terzo - dal 1852 al 1860, Roux Frassati e Co, Editori, Torino, 1895,
- Daniele-Manin e Giorgio Pallavicino - Epistolario politico (5-1857), con note e documenti per B. E. MAINERI, Milano, Tipografia Editrice di L. Bortolotti e C., 1878.
- Del rinnovamento civile d'Italia, VINCENZO GIOBERTI, Tomo 2, Parigi-Torino a spese di Giuseppe Bocca libraio di S. S. R. M Chamerot, Rue du Jardinet, 1851.
- Der Krieg in Italien 1848-1849. Von CARLO PISACANE. Aus dem Italienischen von A. Cloßmann. Mit zwei lithographirten Karten. Chur, Druck und Verlag von Leonh. Hiß. 1852.
- Dichiarazioni di Daniele Manin sulla quistione italiana, Pubblicate ne' giornali di Francia e d'Italia dal marzo 1854 al febbraio 1856, Stamp. dell'Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1856.
- Diplomatic study on the crimean war (2 to 1856), RUSSIAN OFFICIAL PUBLICATION, Vol. II. London:W. H. Allen & Co., 13 Waterloo Place Publishers To The India Office, 1882.
- EPISTOLARIO di Giuseppe Garibaldi, Vol. III 1850 -1858, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1981.
- Epistolario di Giuseppe La Farina, Raccolto e pubblicato da AUSONIO FRANCHI. E. Treves & C., Editori, Milano, 1869
- Garibaldi and the thousand by George Macaulay Trevelyan, Long Mans, Green, and Co., London, 1909.
- Garibaldi capitano del popolo, ALFREDO BIANCHI, Roma, Edoardo Perino, Editore-Tipografo, 1892.
- Giudizi d’un esule su figure e fatti del risorgimento” di IVANO RAULICH - Il Risorgimento Italiano - Rivista Storica (organo della “società nazionale per la storia del risorgimento italiano”), diretta dal prof. BENIAMINO MANZONE, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1908.
- Gli ultimi trentasei anni del Reame di Napoli (-1860) - Francesco I, Vol. I, NICCOLA NISCO, Cav. Antonio Morano Editore, S. Sebastiano, Napoli 1894.
- Gli uomini del mio tempo, DOMENICO GALATI, Bologna, Nicola Zanichelli, 1879.
- Guerra ad Oriente dalla guerra di Crimea alla guerra d’Ucraina” di ZENONE DI ELEA, 2022, https://www.eleaml.org/.
- HANSARD'S PARLIAMENTARY DEBATES: Third Series,, Vol. CXXXI Comprising the period from the twenty-eighth day of February, tο the twenty-eighth day of March, 1854. Second volume of the Session, London, Published by Cornelius Buck, At the Office for Hansard's Parliamentary Debates, 32, Paternoster Row.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Èmile_Mellinet.
- I moribondi di Montecitorio, LUIGI BRANGI, L. Roux E C. Editori Roma-Torino-Napoli, 1889.
- I tentativi per far evadere Luigi Settembrini all’ergastolo di Santo Stefano negli anni 1855-56” di GAETANO CAPASSO - Il Risorgimento Italiano - Rivista Storica (organo della “società nazionale per la storia del risorgimento italiano”), diretta dal prof. BENIAMINO MANZONE, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1908.
- Il decennio orribile delle Due Sicilie (-1860) https://www.eleaml.org/
- Il dissidio tra Mazzini e Garibaldi - La storia senza veli, Documenti inediti, GIACOMO EMILIO CURATULO, A. Mondadori, Milano – 1928.
- IL LUCANO, nel Cinquantenario della Rivoluzione Lucana, Tipografia Editrice Garramone e Marchesiello, Potenza, 1910.
- IL RISORGIMENTO ITALIANO, Rivista Storica diretta da T. Palamenghi–Crispi, Anno VII, Fasc. IV. Luglio-Agosto, 1914.
- Il Risorgimento, ANTONIO GRAMSCI, a cura di Valentino Gerratana, Roma, Editori riuniti, 1996.
- Il ruolo della Gran Bretagna nella caduta del Regno delle Due Sicilie, Tesi di laurea di Martin Kohler, https://www.eleaml.org/sud/storia/martin1_tesi.html
- Italia e popolo giornale politico, Anno VI n. 169, Genova Giovedi 19 Giugno, Italia e popolo giornale politico, Anno VI n. 180, Genova Lunedi 30 Giugno, Italia e popolo giornale politico, Anno VI n. 188, Genova Martedi 8 Luglio.
- L'Epistolario di Giuseppe La Farina - Ire politiche d'oltre tomba, raccolte da Agostino Bertani, Firenze, Tipografia di G. Polizzi e C.. 1869.
- L’ITALIA DEL POPOLO, Giornale politico quotidiano, Stabilimento Tip. Nazionale, via Sauli, presso Cannotto il lungo, N. 7, Anno II. Genova — Lunedi 1° Marzo 1858. Num. 60.
- La Basilicata nella istoria del Risorgimento Nazionale, Memoria letta nella tornata del 2 giugno 1895 dal socio MICHELE LACAVA - Volume XXV degli ATTI della Accademia Pontaniana, Tipografia Della Regia Università, Napoli,1895.
- La fine di un regno Il regno di Ferdinando II, Raffaele de Cesare, Citta di Castello, Casa Tipografico Editrice S. Lapi, 1908.
- La insurrezione della Basilicata e del barese nel 1860, PAOLO GIANCASPRO - Opera postuma pubblicata per cura del nipote Gaetano Giancaspro, Trani, V. Vecchi, Tipografo Editore, 1890.
- La questione commerciale d'Oriente L'italia e il Canale di Suez, Pier Luigi Barzellotti Tipografia Eredi Botta, Firenze, 1869.
- La Rassegna Nazionale, Vol. XII. Anno V. Firenze, presso l'uffizio del Periodico, Via Faenza, 68, 1883.
- La Repubblica - venti dialoghi politico-popolari, LEOPOLDO PEREZ DE VERA, Napoli, Tipografia dell’unione, Strada nuova Pizzofalcone, 1869.
- La repubblica romana del 1849 con documenti inediti e illustrazioni per Giuseppe Beghelli, Volume Primo, Società Cooperativo-tipografica, Lodi, 1874.
- La Spedizione di Sapri e il Comitato di Napoli - Al Generale Garibaldi, Relazione di NICOLA FABRIZJ, Tipografia dell'Arno, Napoli, 1864.
- La spedizione di Sapri e la provincia di Basilicata, DECIO ALBINI, Roma tipografia delle Terme Diocleziane, 1891.
- La Spedizione di Sapri narrata dal Capitano Giuseppe Daneri comandante del Cagliari, in Il Risorgimento Italiano, Rivista Storica, Anno IV, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca Editori, 1911.
- La spedizione di Sapri poemetto epico-lirico, Eliodoro Lombardi, Milano, Edoardo Sonzogno Editore, via Pasquirolo. 1885.
- Le Memorie dei miei tempi, SALVATORE COGNETTI GIAMPAOLO, Napoli Stabilimento Tipografico A. Manzoni nell'Ex-Collegio Medico, 1874.
- Le spedizioni di volontari per Garibaldi - Cifre e documenti complementari al resoconto Bertani, Estratto dal Corriere Mercantile, Genova, Tipografia e Litografia dei Fratelli Pellas e C., Piazza Santa Marta, 1861.
- Le Tipografie del Canton Ticino dal 1800 al 1859, BOLLETTINO STORICO della svizzera italiana, Anno VI, maggio 1884, N. 5.
- Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino con note e documenti sulla Quistione Italiana, Torino, Unione Tipografico-Editrice, dicembre 1859.
- Lettere di Gladstone Gladstone's Letters https://www.eleaml.org/
- Lettere edite ed inedite raccolte ed illustrate da LUIGI CHIALA, deputato al parlamento, Vol. II, Torino Roux e Favale 1883.
- Lettre du Chef de l'État-Major de l'armée de la République Romaine au Général en Chef de l'armée française en Italie, Société Éditrice de l’union, Lausanne, 1849.
- LORENZO VALERIO CARTEGGIO (-1865) Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi – V (-1855) Edito a cura di ADRIANO VIARENGO, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 2010.
- Mazzini’s Letters to an english family 1844-1854, Edited and with An Introduction by E. F. Richards, London: John Lane, The Bodley Head New York: John Lane Company, MCMXX”:
- Memorie di Giorgio Pallavicino dal 1796 al 1848, pubblicate per cura della moglie, Volume Primo, Ermanno Loescher Editore, 1882, PROLOGO.
- Memorie di Giorgio Pallavicino dal 1852 al 1860, pubblicate per cura della figlia, Volume Terzo, Editori Roux Frassati e Co., Torino, 1896.
- Memorie Documentate per la Storia della Rivoluzione Italiana raccolte da PAOLO MENCACCI, Roma Tipografia Di Mario Armanni Nell'ospizio Degli Orfani Alle Terme, 1879.
- Nicola Mignogna nella Storia dell’unità d'Italia, GIUSEPPE PUPINO-CARBONELLI, Stab. Tip. del Cav. A. Morano, Napoli, 1889.
- NOTA ad una lettera di Rosolino Pilo a Nicola Fabrizj del 18 settembre 1855 in Il Risorgimento Italiano, Rivista Storica diretta da T. PALAMENGHI CRISPI, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1914.
- Note intorno alla biografia di Carlo Pisacane” di LEOPOLDO CASSESE, Estratto da: Rassegna storica del Risorgimento, A. 23., fasc. 6, giugno 1936 – https://www.liberabit.unisa.it/.
- Nuova luce sullo sbarco di Sapri, Memoria letta nella tornata del 19 novembre 1893 dal socio MICHELE LACAVA - Volume XXV degli ATTI della Accademia Pontaniana, Tipografia Della Regia Università, Napoli,1893.
- Partito Nazionale Italiano - Scritti Politici di GIORGIO PALLAVICINO, pubblicati nei giornali d'Italia, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice,1856.
- PER GIACINTO ALBINI Ricordi biografici e storici, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1887.
- Rapido cenno sugli ultimi avvenimenti di Roma dalla salita della breccia al di’ 15 luglio 1849, CARLO PISACANE, Losanna, Società Editrice l’Unione, 1849.
- Regno d’Italia. Statuto Fondamentale del Regno in data 4 marzo 1848, corredato di Lettere Patenti, Decreti, Proclami, Plebisciti con intestazioni degli atti di governo e formola per la promulgazione delle Leggi, Torino 1884, p. 27.
- Repubblica e Monarchia - A Giuseppe Mazzini, lettera di Francesco Crispi, deputato, Tipografia V. Vercellino Dora Grossa, 33, Torino 1865.
- Scritti e discorsi politici (-1890), FRANCESCO CRISPI, Unione Cooperativa Editrice, Roma, 1890.
- Scritti editi ed inediti di GIUSEPPE MAZZINI, Ricordi su Carlo Pisacane, Imola, Cooperativa tipografico-editrice Paolo Galeati, 1931.
- SCRITTI EDITI ED INEDITI, Giuseppe Mazzini, Volume XLV – Epistolato Vol. XXIV, Imola, Cooperativa Tipografico-Editrice, Paolo Galeati, 1926.
- Storia dei servizi segreti - La verità su chi veramente governa il mondo, MIRKO MOLTENI, Newton Compton Editori, 2022.
- Storia delle due Sicilie dal 1847 al 1861, Giacinto de' Sivo, Volume primo, Trieste, 1868.
- Storia di dodici anni narrata al popolo italiano, G. LOMBROSO E D. BESANA, Milano, 1861.
- Storia documentata della Diplomazia europea in Italia dall’anno 1814 all'anno 1861, per Nicomede Bianchi, Vol. VII, 1870.
- Storia Politica d'Italia - Il Risorgimento Italiano (-1860), AGOSTINO GORI, Casa Editrice Francesco Vallardi, Milano, 1903.
- Storia universale degli ultimi quattro anni, 1856-1860, WOLFGANG MENZEL, Editrice Guigoni, 1861.
- Studio critico che può servire di prefazione al presente poemetto, Francesco dall'Ongaro, in LA SPEDIZIONE DI SAPRI, poemetto epico-lirico di Eliodoro Lombardi, Milano, Edoardo Sonzogno, Editore, 1885.
- The birth of modern Italy, Posthumous papers of Jessie White Mario, edited with an introduction by the Duke Litta-Visconti-Arese. London. T. Fisher Unwin, 1909.
- Un episodio sullo sbarco di Carlo Pisacane in Ponza, VINCENZO DE LEO, Tipografia di Giuseppe Carluccio, Vico Carogioiello a Toledo, 17, Napoli, 1868.
- Vita di Giuseppe Garibaldi di LUIGI PALOMBA, Edoardo Perino Editore, Roma, 1882.
- Vita di Urbano Rattazzi, CESARE PEROCCO, Stabilimento Tipografico de' fratelli De Angelis, Vico Pellegrini, 1867.
Pisacane e la spedizione di Sapri (1857) - Elenco dei testi pubblicati sul nostro sito
|
Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - lho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura! Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin) |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License . |
Ai sensi della legge n.62
del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata
giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del
Webm@ster .